Don
Saverio di Campuzano s’avvicinava alla morte: la vedeva venire senza timore;
pentito delle sue colpe, confidava nella misericordia di Colui che morí
perché ebbe misericordia di tutti gli uomini. Solo un’inquietudine
lo turbava talvolta nella notte, quando era oppresso dall’insonnia che,
a volte, tormenta i vecchi. Pensava che, venendo egli a mancare, tra i
suoi due figli, unici eredi, sarebbero nati dissensi, acerbe lotte, litigi
per questioni di interessi. Don Saverio era assai facoltoso e potente;
ma non ignorava che le lotte piú accanite per questioni di denaro
avvengono sempre tra i ricchi. Certi amarissimi ricordi di gioventú
contribuivano ad accrescere le sue apprensioni. Ricordava la lunga lite
col fratello maggiore: lite intricata, accanita, interminabile, che al
principio aveva intiepidito l’amore fraterno e poi l’aveva mutato in odio
mortale. Il peccato di aver augurato a suo fratello ogni specie di mali,
di averlo ingiuriato e diffamato e persino (tremendo ricordo!) di averlo
aspettato una notte, tra le fronde di un querceto, per sfidarlo a spaventosa
lotta, era il peso che per molti anni aveva gravato sulla coscienza di
don Saverio. Con l’intenzione era stato fratricida, e tremava al pensiero
che i suoi figli, che amava teneramente, potessero odiarsi per un pugno
d’oro. La natura aveva dato a don Saverio una chiara lezione: i suoi due
figli, maschio e femmina, erano gemelli; riunendoli dall’origine nello
stesso ventre, inviandoli al mondo alla stessa ora, Dio aveva loro comandato
imperativamente che si amassero. Colpita fin dalla loro nascita, la mente
di don Saverio ritornava insistentemente sul pensiero che due gocce di
sangue delle stesse vene, coagulate nello stesso tempo in un grembo di
donna, potevano, tuttavia, odiarsi fino al delitto. Per evitare che il
suo affetto potesse generare gelosie ed odi, aveva avviato suo figlio alla
carriera militare e lo aveva tenuto quasi sempre lontano; solamente quando
s’era avveduto che, per la vecchiaia e gli acciacchi, era ormai vicino
alla tomba, aveva chiamato Giuseppe Maria e aveva permesso che le sue cure
filiali si alternassero con quelle di Maria Giuseppina. Dopo molto riflettere,
il vecchio aveva preso una decisione; chiamò a parte sua figlia,
in gran segreto, e le disse con solennità:
«Figlia
mia, prima dell’arrivo di tuo fratello debbo informarti di una cosa che
ti riguarda. Ascolta attentamente e non dimenticare una sola delle mie
parole. Non v’è bisogno di dire che ti amo molto: però il
tuo sesso dev’essere protetto in modo speciale ed avere maggiore aiuto.
Ho pensato di lasciare a te qualche cosa in piú, senza che nessuno
possa contestarti il possesso di ciò che ti dono. Quando io abbia
chiuso gli occhi, dopo aver pregato un po’ per me... andrai alla fattoria
di Guadeluz e, nella sala a pianterreno, dove è quel forziere assai
vecchio e pesante che dicono gotico, conterai alla tua sinistra, dalla
porta, diciassette mattoni – ricorda bene, diciassette! – e alzerai il
diciassettesimo, su cui è un segno di croce, ed altri intorno. Sotto
i mattoni vedrai una pietra e un anello; la pietra è assicurata
con dura calcina. Toglierai la calcina, solleverai la pietra e apparirà
un nascondiglio, e in esso un milione di reali in monete d’oro. Sono i
miei risparmi di molti anni! Il milione è tuo, solo tuo: a te lo
lascio. E adesso, silenzio! Non torniamo a parlare di ciò! Quando
morrò...»
Maria
Giuseppina sorrise dolcemente, ringraziò con parole assai affettuose
e disse che desiderava non si presentasse mai l’occasione di venire in
possesso del ricco lascito. Arrivò Giuseppe Maria quella stessa
notte, e i due fratelli, a turno, vegliarono don Saverio che si spegneva
a vista d’occhio. Non tardò a presentarsi il momento critico, l’ora
suprema e, tra le contrazioni di una dolorosa agonia, Maria Giuseppina
notò che il moribondo stringeva la sua mano in modo significativo,
e le parve che gli occhi già vitrei, senza luce interiore, dicessero
chiaramente ai suoi: “Ricordati, diciassette mattoni... Un milione di reali...”
I
primi giorni dopo il funerale furono dedicati, naturalmente, al duolo,
alle lacrime, alle condoglianze, alle effusioni di tristezza. I due fratelli,
abbattuti e con le palpebre rosse, si scambiavano poche parole e nessuna
che si riferisse a cose di interesse. Tuttavia si dovette aprire il testamento;
dovettero parlare con notai, procuratori, esecutori testamentari. Una notte
in cui Giuseppe Maria e Maria Giuseppina erano soli nel vasto salone da
ricevimento e la luce debole del lume a petrolio sembrava che rendesse
visibili le tenebre, la sorella s’avvicinò al fratello, lo toccò
su una spalla e timidamente mormorò:
«Giuseppe
Maria, debbo dirti una cosa... una cosa strana... di papà».
«Dimmi,
cara... Una cosa strana?»
«Sí,
vedi., non meravigliarti... c’è un milione di reali in monete d’oro
nascosto nella fattoria di Guadeluz».
«No,
sciocca», esclamò sorpreso e con improvviso impeto Giuseppe
Maria «non hai capito bene. Nemmeno per sogno! Il milione è
nascosto nel podere della Corchada».
«Che
dici, Peppino? Papà me lo spiegò benissimo, con tutti i particolari...
È nella sala a pianterreno; bisogna contare sedici mattoni a sinistra
dalla porta e, al diciassettesimo, vi è la pietra con l’anello che
ricopre il tesoro».
«Ti
assicuro che sbagli, sorella! Papà mi diede tali particolari che
non vi può essere dubbio. Nel podere, vicino al muro del vecchio
ovile abbandonato, c’è una specie di vasca dove beveva il bestiame.
Dietro c’è una piccola arca mezza rovinata e, al piede, una lastra
rotta in un angolo. Togliendo questa lastra, in una nicchia di mattoni,
vi è un milione di reali...»
«Caro
fratello, è impossibile! Credimi. Quando papà ti chiamò
era già grave, agli estremi; forse la sua testa non era piú
a posto, poveretto! Le sue parole mi sono rimaste scolpite qui...»
«Maria»,
disse Giuseppe, prendendo la mano della giovane, dopo aver meditato un
istante, «è certo che i tesori sono due, e solo cosí
ci capiremo. Papà mi disse che lasciava quel denaro esclusivamente
a me...»
«E
a me che quello di Guadeluz era unicamente mio... »
«Povero
papà!» mormorò commosso l’ufficiale. «Che cosa
strana! Se ti par bene bisogna andare prima a Guadeluz e dopo alla Corchada.
Cosí non saremo piú in dubbio. Sarebbe bella che non ce ne
fosse che uno!»
«Dici
bene », confermò Maria Giuseppina trionfante. «Prima
ove dico io: vedrai che è là il tesoro!»
«E
anche perché avesti l’accorgimento di parlare per prima, è
vero, bambina? Devi sapere che io non te lo dicevo perché temevo
di affliggerti; potevi credere che papà ti avesse escluso, che mi
avesse preferito a te... o che so io! Pensavo di ritirare il tesoro e di
dartene la metà senza dirtene la provenienza. Ora m’accorgo che
sono stato uno sciocco».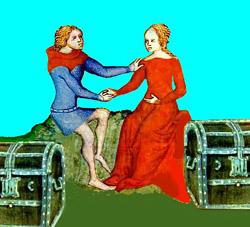 «No,
no; avevi ragione», replicò Maria confusa e turbata. «Sono
una chiacchierona, un’imprudente. Dovevo pensarci... Dovevo cercare il
tesoro e fare come te, consegnartelo senza dire donde provenisse... Che
mancanza di acume!»
«E
a me dispiace che tu abbia parlato per prima», rispose sinceramente
Giuseppe, stringendo la fine mano della sorella.
Pochi
giorni dopo i gemelli si recarono a Guadeluz e trovarono tutto proprio
come aveva annunciato Maria Giuseppina. Il tesoro era contenuto in un cofanetto
di ferro, chiuso; la chiave non fu trovata. Trasportando il cofano e senza
pensare ad aprirlo, si misero in viaggio per la Corchada, dove, al piede
della piccola arca rovinata, trovarono un’altra cassa di ferro, di egual
peso e volume della prima. Portarono a casa le due casse in una sola valigia,
si chiusero di notte in una stanza, e Giuseppe Maria, con i ferri da magnano,
le aprí, o meglio le forzò e scassinò la serratura.
Quando si aprirono i coperchi, brillarono le accumulate monete che i due
fratelli, senza contarle, unendo i due tesori, sparsero sul tavolo, dove
si mescolarono come il fiume Pattolo che confonda le sue meravigliose acque
d’oro con un altro Pattolo.
Improvvisamente
Maria sussultò:
«Nel
fondo della mia cassa vi è un foglio!».
«E
uno anche nella mia» osservò il fratello.
«La
calligrafia è di papà».
«È
proprio la sua».
«Cos’è
scritto nel tuo?».
«Aspetta...
avvicina la luce... Dice cosí: “Figlio mio, se leggi questo scritto
da solo, ti compatisco e ti perdono; se lo leggi in compagnia di tua sorella,
esco dal sepolcro per benedirti...”».
«Il
senso del mio è identico», esclamò dopo un istante,
singhiozzando e ridendo insieme, Maria Giuseppina. Posarono i fogli e,
al di sopra del mucchio d’oro, calpestando le monete sparse sul tappeto,
si tesero le braccia e stettero a lungo abbracciati.
«No,
no; avevi ragione», replicò Maria confusa e turbata. «Sono
una chiacchierona, un’imprudente. Dovevo pensarci... Dovevo cercare il
tesoro e fare come te, consegnartelo senza dire donde provenisse... Che
mancanza di acume!»
«E
a me dispiace che tu abbia parlato per prima», rispose sinceramente
Giuseppe, stringendo la fine mano della sorella.
Pochi
giorni dopo i gemelli si recarono a Guadeluz e trovarono tutto proprio
come aveva annunciato Maria Giuseppina. Il tesoro era contenuto in un cofanetto
di ferro, chiuso; la chiave non fu trovata. Trasportando il cofano e senza
pensare ad aprirlo, si misero in viaggio per la Corchada, dove, al piede
della piccola arca rovinata, trovarono un’altra cassa di ferro, di egual
peso e volume della prima. Portarono a casa le due casse in una sola valigia,
si chiusero di notte in una stanza, e Giuseppe Maria, con i ferri da magnano,
le aprí, o meglio le forzò e scassinò la serratura.
Quando si aprirono i coperchi, brillarono le accumulate monete che i due
fratelli, senza contarle, unendo i due tesori, sparsero sul tavolo, dove
si mescolarono come il fiume Pattolo che confonda le sue meravigliose acque
d’oro con un altro Pattolo.
Improvvisamente
Maria sussultò:
«Nel
fondo della mia cassa vi è un foglio!».
«E
uno anche nella mia» osservò il fratello.
«La
calligrafia è di papà».
«È
proprio la sua».
«Cos’è
scritto nel tuo?».
«Aspetta...
avvicina la luce... Dice cosí: “Figlio mio, se leggi questo scritto
da solo, ti compatisco e ti perdono; se lo leggi in compagnia di tua sorella,
esco dal sepolcro per benedirti...”».
«Il
senso del mio è identico», esclamò dopo un istante,
singhiozzando e ridendo insieme, Maria Giuseppina. Posarono i fogli e,
al di sopra del mucchio d’oro, calpestando le monete sparse sul tappeto,
si tesero le braccia e stettero a lungo abbracciati.
E.
Pardo Bazan, Cuentos sacroprofanos, I.B.d.L., Rizzoli, Milano 1957
|