 |

Tra i sette colli di Roma, l’Aventino ha sempre conservato un suo carattere
di extraterritorialità, trovandosi fuori del pomerio, il recinto
sacro tracciato da Romolo per delimitare l’Urbe quadrata che andava sorgendo
sul Palatino. Era definito, in epoca arcaica, Mons Murcius,
per via dei mirti che ricoprivano le sue pendici e la sottostante Valle
Murcia, divenuta poi Circo Massimo, che lo separava dal Palatino.
Vera isola del tempo, rimane fuori anche dagli itinerari canonici del
turismo organizzato. Solo qualche visitatore alla ricerca di peculiarità
storiche, letterarie e paesaggistiche si spinge fin sulla sommità
della sua breve orografia. Qui, nella piazza dove risiede il Gran Maestro
dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, attraverso il buco della serratura
del portale di Santa Maria del Priorato, al civico 4, è possibile
ammirare il cupolone di San Pietro ingigantito per uno strano effetto ottico.
Sempre attraverso un’esigua finestrella, a Santa Sabina, poco distante,
è possibile intravedere nell’orto dei domenicani l’arancio piantato,
si dice, da San Domenico nel lontano 1222, mentre nella cripta di Sant’Alessio
riposano alcune reliquie di San Tommaso di Canterbury (Thomas Becket) il
vescovo martirizzato da Enrico II d’Inghilterra il 29 dicembre 1170.
A rinverdire le memorie di amenità agresti, a ogni maggio un
roseto dispiega meraviglie di rarità floreali. Un luogo idilliaco,
dunque, un’oasi di silenzio e di pace.
Non certo però quel giorno di tanti secoli fa. Era il 5 dicembre
del 494 a.C., il primo delle none del mese. Dopo l’armilustrium
celebrato come ogni anno il 18 di ottobre, e che chiudeva la campagna militare,
la plebe aveva abbandonato la città rifugiandosi sull’Aventino.
Si trattava di un luogo che nel tempo aveva finito col rappresentare il
simbolo dell’emarginazione sociale e territoriale.
Come si era potuto arrivare a tanto? Nel 499 a.C., i Romani avevano
sconfitto i Latini confederati al lago Regillo, uno specchio d’acqua ormai
del tutto prosciugato, tra i Colli Albani e la costa. La vittoria, si era
detto, era stata conseguita grazie all’intervento soprannaturale e provvidenziale
dei divini gemelli, i Dioscuri. In groppa a bianchi destrieri, i due fratelli
celesti si erano uniti alle schiere quirite in difficoltà, permettendo
loro di aver ragione di avversari dimostratisi valorosi oltre ogni aspettativa.
Il Senato aveva deciso di non ridurre in schiavitú i vinti, come
di solito avveniva. Li aveva fatti insediare sull’Aventino in regime di
libertà, permettendo loro di coltivare la terra e di commerciare.
Uguale trattamento era stato riservato ai Sabini, dopo la loro sconfitta
nel 502 a.C., allocati invece sul Quirinale.
Quei gesti di clemenza e magnanimità si giustificavano ufficialmente
per la consanguineità dei Romani con le popolazioni laziali sconfitte.
In realtà, l’inusitata munificenza nascondeva un progetto a lunga
scadenza vagheggiato dal patriziato romano, che costituiva per la gran
parte il Senato e che doveva potere e ricchezza allo sfruttamento del latifondo.
Le terre intorno alla città e quelle delle popolazioni di volta
in volta conquistate, richiedevano braccia valide e soprattutto esperienza
nelle pratiche di coltivazione. Requisiti in possesso per eccellenza delle
genti sabine e latine, dedite da sempre e con profitto all’agricoltura,
alla pastorizia e all’utilizzo delle risorse boschive. Popolazioni inoltre
laboriose e frugali, devote agli Dei, dai costumi familiari e sociali specchiati.
Elementi quindi affidabili e, data la loro subordinazione, facilmente ricattabili
e soprattutto non remunerati. Una forza di lavoro ideale, per chi intendeva
trarre il massimo di profitto dalla terra e dalle attività connesse,
con il minimo di spesa e con pochi o nulli problemi gestionali.
Cosí la pensavano i patrizi capeggiati dal senatore Appio Claudio.
Naturalmente tali valutazioni utilitaristiche da parte loro rimanevano
inespresse, per cosí dire in pectore. All’esterno, invece,
la parola d’ordine era tacciare la massa dei cittadini, di diritto ma nullatenenti,
di ogni possibile inadempienza, in maniera da giustificare la loro graduale
sostituzione con le fresche e prestanti compagini degli immigrati coatti
latini e sabini. In un veemente discorso al Senato, Appio Claudio aveva
accusato la plebe romana di vivere parassitariamente a spese dei patrizi,
di piatire sportule e denari in continuazione, stigmatizzando con
feroce sarcasmo la loro pretesa di eguaglianza sociale, andando in giro
a declamare il loro pretenzioso quanto arrogante ritornello «Civis
romanus sum!», frase che suonava ormai come un insulto alle orecchie
degli aristocratici, possidenti e magistrati, che erano a buon titolo,
a loro parere, i soli e veri artefici della ricchezza, del potere e della
gloria di Roma.
Il popolo masticava amaro, ma non si ribellava. Molti vivevano con
prestiti a usura concessi proprio da chi deteneva denaro e potere, correndo
il rischio, se inadempienti nel restituire i prestiti con altissimi interessi,
di finire schiavi dei loro creditori. Finché un episodio aveva portato
a un punto di rottura. A sancire la benevolenza del Senato e del patriziato
nei confronti degli immigrati, il console Spurio Cassio aveva fatto approvare
il Foedus Cassianum, una legge che accordava alle popolazioni assimilate
benefíci, privilegi e sovvenzioni di cui neppure i cittadini per
diritto di appartenenza all’Urbe avevano mai sognato di godere. Fu cosí
che artigiani, bottegai, maniscalchi, piccoli commercianti  e
imprenditori, servi e fullones, scrivani e persino architetti e
medici avevano lasciato la città rifugiandosi sull’Aventino, il
Saxum Sacrum, altra denominazione del colle dovuta alla sua contiguità
con le grotte delle Camène, dalle cui fonti salutari nasceva il
torrentello Euripus che, dopo aver attraversato la Valle Murcia, andava
a gettarsi nel Tevere. Ma era, quella breve asperità collinare,
anche il monte dei perdenti illustri. Vi erano infatti sepolti Remo e Tito
Tazio, vittime del vincente Romolo. Era la roccaforte della plebe, contrapposta
al dominio aristocratico insediato nelle sontuose dimore del Palatino.
Appio Claudio aveva esultato: la plebe si eliminava in blocco di propria
iniziativa. E a chi gli aveva fatto notare che disertando i cives
di diritto mancavano i soldati per difendere anche le sue proprietà,
egli aveva replicato che avrebbe in quattro e quattr’otto allestito un
esercito con gli immigrati, piú integri e resistenti dei cittadini
rammolliti dall’ozio e dalla pigrizia di un’esistenza saprofitica. Ma il
Senato non era stato tutto dalla sua parte e aveva inviato diverse ambascerie
per far recedere la plebe dalla sua intransigente posizione. Tutti i tentativi
si erano rivelati però dei fallimenti.
Si arrivò cosí alle none di dicembre, il cinque del mese
nel nostro calendario. Questa volta si tentò la carta del sentimento,
inviando una compagine di pacificatori moderati e amici del popolo. Tra
questi spiccava, per la sua figura nobile e disinteressata, l’ex console
Menenio Agrippa, vincitore dei Sabini, uomo onesto e alieno dai giochi
di interessi e dagli intrighi di Palazzo. Un vero Padre della Patria. Era
l’extrema ratio: se falliva lui non c’era piú nulla da tentare.
Ai concittadini raccolti intorno al tempio di Diana Aricina, Menenio
Agrippa si rivolse parlando pacatamente e con toni paterni, esortandoli
a far ritorno a Roma. Al termine del suo discorso, enunciò il celeberrimo
apologo, raccontando dello stomaco che lavora aiutato dai vari organi del
corpo, ciascuno secondo la propria funzione e importanza, dicendo che se
gli organi e le membra cessano di cooperare muore lo stomaco con tutto
il corpo. L’espediente allegorico funzionò. La plebe si commosse
e un’ovazione generale si levò dalla folla, che si disse disposta
a terminare la sedizione. L’abilità dialettica di Menenio, non priva
di quel tanto di demagogia necessaria a uno come lui, abituato al comando
militare e ai discorsi politici, stava risolvendo il conflitto a favore
del patriziato. Se ne rese conto Giunio Bruto, un uomo del popolo dotato
di coraggio e di una buona capacità oratoria. Egli rivendicò
alla plebe quanto essa aveva contribuito alla grandezza dell’Urbe, prima
aiutando i patrizi a cacciare l’ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo,
e poi, in un susseguirsi di cruente battaglie militari, a debellare le
città che minacciavano la crescita di Roma. Giunio Bruto parlò
col cuore, e ottenne per la plebe la rappresentanza di magistrati e tribuni
nelle sedi giudiziarie e amministrative, oltre alla remissione di tutti
i debiti contratti dal popolo nei confronti degli usurai, antica piaga
del mondo mai guarita.
Stando alle cronache, in quel fatidico 5 dicembre vinsero un po’ tutti:
i patrizi, che vedevano ritornare in città le colonne portanti dell’esercito
e dei mestieri; la plebe, che finalmente otteneva rappresentanze politiche
e giudiziarie, oltre al condono pecuniario; e i due fautori di quel successo,
da una parte Menenio Agrippa ricoperto di onori, dall’altra Giunio Bruto
che divenne il primo tribuno della plebe. Vittoria di Pirro, ché
la soluzione dei problemi, con rare ed effimere tregue venne rimandata
sine die. E ciò perché la controversia tra patrizi
e plebei era stata risolta per via legale e non morale, e le concessioni
strappate a forza erano di ordine materiale come le richieste: denaro e
cariche pubbliche. E allorché gli uomini si accordano in base a
princípi puramente materiali, ecco agire in seno ai consessi sociali
le forze mai sopite del Grande Guastatore. La materia, nonostante la sua
tetragona apparenza, presta il fianco alle sue insidie e le vicende umane
si complicano. Roma, benché sapesse trarre da quel fatidico evento
una salutare lezione ed emancipasse la plebe fino a renderla apparentemente
partecipe della cosa pubblica, e a dispetto di un apparato legislativo
che doveva servire da guida e riferimento ad altri popoli per secoli, non
riuscí a estirpare il disagio profondo che aveva portato a quella
secessione. E non ci sono riusciti i governi dei popoli nelle epoche successive,
tant’è che sedizione e secessione hanno guatato con diabolica perseveranza
il vivere umano da ogni piega della sociale convivenza, e tuttora minacciano
le nazioni e gli ordinamenti che ne regolano i sistemi politici ed economici.
Questa impossibilità a individuare la causa vera del malessere che
inquina, oggi come ieri, i rapporti tra le varie parti sociali, viene cosí
tratteggiata da Rudolf Steiner: e
imprenditori, servi e fullones, scrivani e persino architetti e
medici avevano lasciato la città rifugiandosi sull’Aventino, il
Saxum Sacrum, altra denominazione del colle dovuta alla sua contiguità
con le grotte delle Camène, dalle cui fonti salutari nasceva il
torrentello Euripus che, dopo aver attraversato la Valle Murcia, andava
a gettarsi nel Tevere. Ma era, quella breve asperità collinare,
anche il monte dei perdenti illustri. Vi erano infatti sepolti Remo e Tito
Tazio, vittime del vincente Romolo. Era la roccaforte della plebe, contrapposta
al dominio aristocratico insediato nelle sontuose dimore del Palatino.
Appio Claudio aveva esultato: la plebe si eliminava in blocco di propria
iniziativa. E a chi gli aveva fatto notare che disertando i cives
di diritto mancavano i soldati per difendere anche le sue proprietà,
egli aveva replicato che avrebbe in quattro e quattr’otto allestito un
esercito con gli immigrati, piú integri e resistenti dei cittadini
rammolliti dall’ozio e dalla pigrizia di un’esistenza saprofitica. Ma il
Senato non era stato tutto dalla sua parte e aveva inviato diverse ambascerie
per far recedere la plebe dalla sua intransigente posizione. Tutti i tentativi
si erano rivelati però dei fallimenti.
Si arrivò cosí alle none di dicembre, il cinque del mese
nel nostro calendario. Questa volta si tentò la carta del sentimento,
inviando una compagine di pacificatori moderati e amici del popolo. Tra
questi spiccava, per la sua figura nobile e disinteressata, l’ex console
Menenio Agrippa, vincitore dei Sabini, uomo onesto e alieno dai giochi
di interessi e dagli intrighi di Palazzo. Un vero Padre della Patria. Era
l’extrema ratio: se falliva lui non c’era piú nulla da tentare.
Ai concittadini raccolti intorno al tempio di Diana Aricina, Menenio
Agrippa si rivolse parlando pacatamente e con toni paterni, esortandoli
a far ritorno a Roma. Al termine del suo discorso, enunciò il celeberrimo
apologo, raccontando dello stomaco che lavora aiutato dai vari organi del
corpo, ciascuno secondo la propria funzione e importanza, dicendo che se
gli organi e le membra cessano di cooperare muore lo stomaco con tutto
il corpo. L’espediente allegorico funzionò. La plebe si commosse
e un’ovazione generale si levò dalla folla, che si disse disposta
a terminare la sedizione. L’abilità dialettica di Menenio, non priva
di quel tanto di demagogia necessaria a uno come lui, abituato al comando
militare e ai discorsi politici, stava risolvendo il conflitto a favore
del patriziato. Se ne rese conto Giunio Bruto, un uomo del popolo dotato
di coraggio e di una buona capacità oratoria. Egli rivendicò
alla plebe quanto essa aveva contribuito alla grandezza dell’Urbe, prima
aiutando i patrizi a cacciare l’ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo,
e poi, in un susseguirsi di cruente battaglie militari, a debellare le
città che minacciavano la crescita di Roma. Giunio Bruto parlò
col cuore, e ottenne per la plebe la rappresentanza di magistrati e tribuni
nelle sedi giudiziarie e amministrative, oltre alla remissione di tutti
i debiti contratti dal popolo nei confronti degli usurai, antica piaga
del mondo mai guarita.
Stando alle cronache, in quel fatidico 5 dicembre vinsero un po’ tutti:
i patrizi, che vedevano ritornare in città le colonne portanti dell’esercito
e dei mestieri; la plebe, che finalmente otteneva rappresentanze politiche
e giudiziarie, oltre al condono pecuniario; e i due fautori di quel successo,
da una parte Menenio Agrippa ricoperto di onori, dall’altra Giunio Bruto
che divenne il primo tribuno della plebe. Vittoria di Pirro, ché
la soluzione dei problemi, con rare ed effimere tregue venne rimandata
sine die. E ciò perché la controversia tra patrizi
e plebei era stata risolta per via legale e non morale, e le concessioni
strappate a forza erano di ordine materiale come le richieste: denaro e
cariche pubbliche. E allorché gli uomini si accordano in base a
princípi puramente materiali, ecco agire in seno ai consessi sociali
le forze mai sopite del Grande Guastatore. La materia, nonostante la sua
tetragona apparenza, presta il fianco alle sue insidie e le vicende umane
si complicano. Roma, benché sapesse trarre da quel fatidico evento
una salutare lezione ed emancipasse la plebe fino a renderla apparentemente
partecipe della cosa pubblica, e a dispetto di un apparato legislativo
che doveva servire da guida e riferimento ad altri popoli per secoli, non
riuscí a estirpare il disagio profondo che aveva portato a quella
secessione. E non ci sono riusciti i governi dei popoli nelle epoche successive,
tant’è che sedizione e secessione hanno guatato con diabolica perseveranza
il vivere umano da ogni piega della sociale convivenza, e tuttora minacciano
le nazioni e gli ordinamenti che ne regolano i sistemi politici ed economici.
Questa impossibilità a individuare la causa vera del malessere che
inquina, oggi come ieri, i rapporti tra le varie parti sociali, viene cosí
tratteggiata da Rudolf Steiner:
|
Il tragico errore, riguardo all’incomprensione delle
rivendicazioni sociali contemporanee, sta nel fatto che in molti ambienti
non si ha il minimo senso di quel che ora, dalle anime di larghe
masse umane, affiora alla superficie della vita, e che si è incapaci
di dirigere lo sguardo a quanto avviene veramente nell’intimo degli uomini.
Pieno di paura, il non-proletario tende l’orecchio alle rivendicazioni
che salgono dal proletariato, e sente proclamare che «solo
con la socializzazione dei mezzi di produzione egli potrà
conseguire un’esistenza degna di un essere umano». Ma non sa formarsi
una rappresentazione del fatto che, nel trapasso dal vecchio al nuovo tempo,
la sua classe non solo ha chiamato il proletario a lavorare con mezzi di
produzione non suoi, ma non ha nemmeno saputo aggiungere al suo lavoro
qualcosa che potesse dargli un sostegno per l’anima.
Chi, nel modo che abbiamo accennato piú sopra,
trascura, sia nella conoscenza sia nell’azione, di tener conto delle vere
realtà della vita, potrà obiettare: «Ma, infine, il
proletario non vuol altro che pervenire a una posizione sociale pari a
quella delle classi dirigenti! Che c’entra qui la questione dell’anima?»
Persino al proletario stesso verrà fatto di dire: «Dalle
altre classi io non voglio nulla per la mia anima; chiedo soltanto che
sia loro impedito di sfruttarmi piú oltre; voglio che le attuali
differenze di classe scompaiano!» Tali discorsi non toccano però
l’essenza della questione sociale; nulla rivelano del suo vero aspetto.
Infatti, nell’anima della popolazione lavoratrice, una coscienza che dalle
classi dirigenti avesse ereditato un vero contenuto spirituale proclamerebbe
le rivendicazioni sociali in tutt’altro modo da come lo fa il proletariato
moderno, che nella vita spirituale ereditata non può veder altro
che un’ideologia. Questo proletariato è convinto del carattere
ideologico della vita spirituale, ma appunto a causa di questa sua convinzione
diventa sempre piú infelice. E gli effetti di questa infelicità
della sua anima, di cui egli non è cosciente, pur soffrendone intensamente,
hanno un peso infinitamente piú importante, per la situazione sociale
del nostro tempo, di tutte le rivendicazioni, pur giustificate nel loro
genere, che riguardano il miglioramento delle condizioni materiali della
vita.(1)
|
E Massimo Scaligero, riferendosi all’atteggiamento interiore assunto
in epoca attuale dalle due categorie sociali contrapposte, quella operaia
e quella intellettuale, cosí si esprime:
|
V’è una ragione per cui l’operaio fa l’operaio,
ed è soddisfatto di esserlo, pur essendo capace di aprirsi a livelli
piú elevati di cultura: la sua coscienza è fondata nella
sfera del sentire, piuttosto che in quella del pensare: ha la sensazione
di esprimere se stesso nell’attività fisica, meglio che in quella
concettuale: perciò è portato a vivere il contenuto dell’ideologia,
piú realisticamente che l’intellettuale. L’operaio crede, perciò
è il capro espiatorio. L’operaio va incontro all’ideologia con una
disposizione morale che manca all’intellettuale: ma a tale disposizione
morale non può rispondere l’ideologia materialista: potrebbe rispondere
solo una visione sovrasensibile della realtà: della quale egli viene
privato. D’onde l’infelicità profonda dell’operaio. Il suo problema
è solo in parte problema economico: anzi si può dire che
per lui in taluni Paesi (Germania, Svezia, Norvegia, Inghilterra ecc.)
tale problema non esiste quasi del tutto. Il suo problema è morale
e psicologico: alla richiesta del suo sentimento etico – rispondente alla
sua costituzione, per cui è operaio e non intellettuale – l’ideologia
materialista toglie la speranza di una risposta.
L’ideologo …non riesce a vedere l’importanza della figura
spirituale dell’operaio: d’onde l’occulto senso di colpa dell’ideologo,
che si ritiene socialista e invece è un cripto-conservatore, per
cui tende a riparare ed eleva a entità mistica l’operaio che veramente
non ne ha bisogno. L’operaio ha semplicemente bisogno che, come lui fa
il suo dovere sul piano esecutivo fisico, cosí l’intellettuale-ideologo
faccia il proprio sul piano interiore. Ma è quello che l’attuale
ideologo non fa: riesce soltanto a corrompere l’operaio, esaltandone la
funzione, di cui invero impedisce il collegamento con la virtú metadialettica
originaria. Lo impedisce, perché non è capace di concepirlo(2).
|
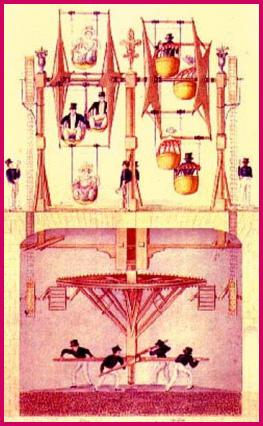
- Il mondo, da quella memorabile giornata di 2500 anni fa, non ha ancora
risolto i conflitti di classe e di lavoro in maniera capillare e definitiva,
proprio per il motivo che i patti sociali e le controversie che ne derivano
sono ispirati unicamente da istanze materiali. Se gli uomini agissero secondo
princípi morali, e piú ancora spirituali, otterrebbero esiti
risolutivi, sia in termini ideali sia in termini pratici, come ci dice
lo stesso insegnamento evangelico. Soprattutto, si chiarirebbero loro le
forze che agiscono a monte degli eventi, i meccanismi karmici che stabiliscono
le sorti, i ruoli, le condizioni degli individui nel gioco vario e misterioso
dei loro rapporti e dei loro destini. I subalterni e i diseredati vedrebbero
nel loro stato uno strumento di redenzione e riscatto. Consci del fine
ultimo del loro cammino terreno esistenziale, non piú reclamerebbero
soltanto pane e lavoro bensí anche remunerazioni dell’anima, per
una integrale realizzazione del loro Io irrinunciabile. Quanto agli organi
dirigenti, non piú assimilabili per aspetti e valori diversi ad
Appio Claudio o a Menenio Agrippa, si farebbero carico della tenuta morale
di tutta la società di cui sarebbero governanti, e considererebbero
i soggetti, fornitori della forza lavoro, non tanto utili e supini strumenti
del loro potere e delle loro ricchezze quanto piuttosto un materiale umano
da indirizzare al finale progetto unitario di valorizzazione della società
di cui tutti, forti e deboli, ricchi e poveri, sprovveduti e talentati,
fanno parte a pieno titolo, divino oltre che umano. Responsabilità
quindi da assumersi in maniera proporzionata ai propri valori e ruoli,
alle proprie capacità intellettuali, fisiche ed animiche. Ciascuno
portatore della sua pietra, ruvida o levigata, opaca o lucente, solida
o fragile, preziosa o povera, che, unita a quella recata dagli altri individui
a lui sodali, servirà a innalzare il tempio dell’Uomo realizzato.
- All’apologo di Menenio Agrippa, perché fosse perfetto, mancava
il suggello della carità. Venne il Cristo a portarlo. Attraverso
di Lui, Signore del karma, l’uomo può sciogliere ogni nodo esistenziale,
volgere in bene ogni destino, mutare in vita la morte, affrancarsi da ogni
servitú fisica e morale. E, se animato da buona volontà,
ottenere la pace su questa Terra.
- Chi si avventura sull’Aventino alla ricerca di peculiarità paesaggistiche,
rarità monumentali e suggestioni mitologiche, si fermi in meditazione
dove un tempo sorgeva il tempio di Diana Aricina, e dove oggi si erge,
austera e raccolta, Santa Sabina. Potrà udire, frammiste ai vespri
cantati dai benedettini di Sant’Anselmo, alle note del piano che scandisce
i tempi nella vicina Accademia di danza, al fruscío di pini e cipressi
e allo stormire delle foglie nel Giardino degli Aranci, le voci di uomini
che in quel lontano giorno delle none di dicembre del 494 a.C., senza esserne
consapevoli, reclamavano per noi tutti dalla storia, oltre al pane e alla
libertà per il corpo, il ben piú alto nutrimento dello Spirito.
- Il tempo è ormai maturo perché il loro desiderio venga
esaudito.
(1)
R. Steiner, I punti essenziali della questione
sociale, F.lli Bocca Editori, Milano 1950, pp. 18-19
(2) M.
Scaligero, Lotta di classe e karma, Perseo, Roma 1970, pp. 96-99
Immagini:
– Roesler Franz, «Il colle dell’Aventino
visto dal Tevere», acquerello, Roma 1876
– Nicola Sangiovanni, «La vita è una giostra»,
acquerello, 1830 – Museo di San Martino, Napoli
| |