|

Sciami irrequieti di
uccelli ormai pronti alla partenza, cadono foglie senza vita, la
terra indossa le gramaglie d’autunno. Scarmigliata e folle, un’ombra
percorre veloce, ansimando, questo grigio scenario. Nel libro V
delle Metamorfosi cosí Ovidio descrive l’affanno di
Cerere, ovvero Demetra, partita alla ricerca della figlia, la
fanciulla Core, la Persefone dei Greci, la Proserpina dei Romani:
Cercava Cerere invano la fanciulla
percorrendo angosciata terra e mare,
né l’Aurora né il Vespero la videro
mai riposarsi… |
- E per vincere il buio della notte,
la Dea ricava due torce dai pini dell’Etna, una per
ciascuna mano, perché la ricerca mai s’interrompa fino
allo spuntare del giorno che fa impallidire le stelle.
Ancora, sempre, cercando l’amata figlia. Ma Persefone è
stata rapita dal sovrano dell’Erebo, Ades, mentre coglieva
fiori nel bosco dell’eterna primavera, presso il lago
Pergo, in Sicilia, e ha finito con l’innamorarsi del suo
rapitore, diventando regina dell’Averno. E per suggellare
questa sua scelta di non ritorno nel mondo dei vivi ha rotto
il voto del digiuno, che le consentirebbe di lasciare il
mondo dei morti qualora lo volesse. Ha mangiato sette
chicchi di una melagrana colta nel giardino di Ades,
legandosi per sempre a lui e al mondo infero. Il dolore di
Demetra è tale che Zeus, mosso a pietà per il triste fato
della fanciulla, figlia anche sua, stabilisce che Persefone
trascorra sei mesi con la madre nel regno dei vivi e sei con
Ades nel regno delle ombre.
- L’autunno segnava, nella
tradizione mitologica greca, l’inizio di permanenza di
Core nell’Ade, quale regina di quel mondo tenebroso, e del
dolore della madre che per quel periodo la vedeva
scomparire. Per consolare e ingraziarsi la Dea, alla cui
tutela era affidata la fertilità della terra e la
fecondità della donna, venivano celebrate in Grecia le
Tesmoforie in onore di Demetra. Duravano tre giorni e
coincidevano di norma con la seminagione. Si snodavano in
processione per le città e i luoghi agresti trenodíe
formate esclusivamente da donne biancovestite, che portavano
in epifania le leggi scritte, che si diceva discendessero
direttamente dalla dea, e che governavano le tradizioni
civili e domestiche riguardanti il matrimonio e la prole. A
tal fine, l’ultimo giorno delle celebrazioni veniva
denominato “Kalligeneia”, ovvero della bella progenie.
Canti, danze e tripudi connotavano quel giorno.
- Il panteismo panico degli antichi
vedeva la divinità in ogni elemento, in ogni fenomeno, e i
miti erano allegorie e metafore del divenire del mondo,
cosí come gli uomini contribuivano a formarlo
diacronicamente, giorno dopo giorno, vicenda dopo vicenda.
Vedevano uno spirito universale multiforme nei segni della
natura, in particolare nelle piante e negli alberi. Nel
santuario di Dòdona Zeus parlava dalle querce, le Muse dai
salici dell’Elicona, Apollo si manifestava nell’alloro,
Dioniso nell’edera e Venere attraverso il mirto. Jahvè, l’Io
sono, parlò a Mosè da un roveto ardente. Gli antichi Egizi
consideravano il sicomoro un albero posto al confine tra il
mondo dei vivi e quello dei morti, e vi facevano risiedere
le divinità preposte al controllo delle anime durante il
passaggio dalla realtà fisica a quella ultraterrena:
Osiride, Maat, Anubi e Thot. La dea Nut, nel suo aspetto di
albero della vita, nutriva invece i morti, affinché
ottenessero il dono della vita eterna. Sotto l’albero di
fico indiano, il pipal, sulla riva del torrente Nerajara,
Siddharta, dopo aver attraversato i quattro stadi –
concentrazione, lievità dell’anima, abbandono e
imperturbabilità assoluta – raggiunse la bodhi, la
suprema Illuminazione, divenendo Buddha e uscendo dalla
ruota delle continue reincarnazioni, attingendo quindi al
Nirvāna, la condizione che esenta l’anima dal
ciclo di morte e rinascita.
- Dal credere senza dubbi degli
antichi, che vedevano la divinità in ogni cosa, si è
arrivati al meccanicismo deterministico dei filosofi, che
scorge soltanto processi chimici e fisici nelle
manifestazioni della natura. Lo stesso Kant giunse ad
affermare che proprio i fiori, la seduzione di Persefone,
mostrano una bellezza figlia dell’inutilità, un essere
senza scopo.
- Secondo le risultanze della
scienza positivistica, la straordinaria alchimia attraverso
cui i fiori variano i toni cromatici delle corolle, emanando
allo stesso tempo aromi inebrianti dai calici, non
dipenderebbe dal segreto lavorío di fate e folletti, dalle
dita angeliche di esseri elementari invisibili e alacri,
bensí altro non sarebbe che una casualità di processi
chimico-minerali legati alla simbiosi-osmosi tra vari
elementi e organismi. Ma una scrittrice amante della natura
in generale, e dell’Africa in particolare, la pensa
diversamente: «Non è possibile – dice Karen Blixen –
che una varietà cosí infinita sia necessaria alla economia
della natura; deve essere per forza la manifestazione di uno
spirito universale, inventivo, ottimista e giocondo all’estremo,
incapace di trattenere i suoi scherzosi torrenti di
felicità». Una divinità felice di creare, dunque, e
perciò disposta a rendere felice anche la sua creazione
piú raffinata: l’uomo.
- Proprio nel continente africano,
tanto caro alla scrittrice danese, le popolazioni hanno
meglio conservato, attraverso credenze animistiche, la
consapevolezza che forze sovrannaturali animano il creato, e
piú di ogni altra cosa gli alberi. A Dar es Salaam, in
Tanzania, un devoto e incessante pellegrinaggio dalla città
e dalla regione circostante conduce uomini e donne fino a un
gigantesco baobab, che dirama il suo corpo secolare, forse,
dicono alcuni, millenario, in un angolo di Kenyatta Drive,
poco distante dall’Oceano Indiano. Il poderoso leviatano
vegetale ospita uno spirito benigno che emana energie
taumaturgiche. I fedeli arrivano, si tolgono le scarpe prima
di inginocchiarsi ai piedi dell’albero, il cui diametro
supera i dieci metri, e, a occhi chiusi, chiedono grazie e
guarigioni, per sé e per conto di altre persone
impossibilitate a compiere direttamente tale devozione.

- Piú un albero è vecchio, credono
gli africani, piú grande è la possibilità che lo abitino
spiriti potenti e propizi. Negli esemplari piú vetusti il
durame interno si svuota, lasciando un’ampia nicchia
dentro la quale i postulanti lasciano cibo e offerte votive.
Fino a non molti anni fa, vi si ponevano le ceneri dei
cantastorie, affinché il genio dell’albero rendesse
immortale lo spirito di quei cantori che, attraverso la
tradizione orale, avevano perpetuato la storia del proprio
popolo.
- Confusi alle turbe dei devoti che
si recano a venerare il sacro baobab e a chiedere grazie e
miracoli, ci sono anche eminenti politici, i quali prima
delle tornate elettorali implorano sostegno per la loro
candidatura. Torneranno per ringraziare l’albero in caso
di successo nella consultazione.
- Ma tanto ricco di meraviglie è il
retaggio culturale africano da non poter ridurre incanti e
incantesimi a un solo prodigioso emblema. Sul crinale tra
magico e mistico, sottile al punto da consentire scambi
continui tra le due dimensioni, ecco svettare il “Mariam
Daarit”, che nell’idioma della provincia di Keren in
Eritrea vuol dire “Il baobab di Maria”. L’albero
mastodontico, che s’innalza trionfante poco fuori della
città di Keren appunto, ospita nella cavità del tronco
prodotta dall’opera dei secoli una cappella dedicata alla
Madonna. L’eressero alcune suore missionarie verso la
metà dell’Ottocento. Nel corso della Seconda Guerra
Mondiale l’area dove sorge il Mariam Daarit venne a
trovarsi proprio al centro delle operazioni militari
condotte dai paesi belligeranti, la cosiddetta “guerra del
deserto” tra gli alleati angloamericani e le forze dell’Asse.
Per sfuggire a un bombardamento dell’aviazione britannica,
alcuni soldati italiani si rifugiarono nella cappelletta del
baobab, raccomandandosi alla Vergine Maria, la cui immagine
era raffigurata nella statuina posta sul minuscolo altare.
Una bomba colpí il baobab, ma albero e soldati rimasero
illesi. Da allora, alla reputazione di positività botanica
già acquisita dall’albero nella tradizione locale, venne
ad aggiungersi quella di una sua virtú miracolosa dovuta
alla presenza della cappella e della statua. Scattò una
specie di sincretismo religioso spontaneo per cui venivano e
vengono tuttora in pellegrinaggio al “Baobab di Maria”
fedeli appartenenti a ogni culto e religione. Ne derivano
pertanto inedite e a volte colorite commistioni di riti e
pratiche devozionali, alcune tipiche dell’empirismo
sciamanico. Capita di vedere numerose postazioni di cucine
mobili con fornelli per preparare il caffè allestite nei
pressi dell’albero. Le ragazze che desiderano sposarsi, o
le maritate che non riescono ad avere un figlio, si danno da
fare con le cuccume, e se uno dei pellegrini si avvicina e
ne chiede una tazza, è segno che il desiderio formulato
verrà esaudito e sarà matrimonio imminente e felice o
prole sana e timorata di Dio. Soprattutto se la grazia viene
richiesta in occasione della grande festa che si celebra
ogni anno il 29 maggio, con inni, balli e giochi sulla
radura di Keren, intorno al possente e sacro albero che, le
radici affondate in una terra antica quanto il mondo, veglia
sul geloso mistero della vita.
- Qualche bella mente positivistica
potrebbe commentare: «La solita superstizione dei
primitivi, l’animismo tribale duro da sradicare. Venerare
un baobab!». Che direbbero allora queste razionali
intelligenze davanti allo spettacolo delle folle dirette da
ogni parte d’Italia a Canneto Sabino, in quel di Rieti,
per ammirare un veterano della flora europea, un ulivo
vecchio di 1.500 anni. Tempo fa, il Presidente del Consiglio
allora in carica, Romano Prodi, ha voluto posare per una
foto ricordo davanti a questo vegliardo vegetale, dal fusto
di oltre nove metri di diametro, tuttora in grado di
produrre dieci quintali di olive ad ogni stagione. Vecchie
glorie che non demordono!
- Come il tiglio di Macugnaga,
piantato dagli immigrati della regione svizzera di Walser
intorno al 1260, quasi coetaneo dell’abete bianco della
Verna che, si racconta, vide il poverello d’Assisi
ricevere le stigmate. E il castagno di Camaldoli, che per
non essere da meno ha raggiunto la circonferenza di dieci
metri alla base. Nella cavità del suo enorme tronco i
monaci ricavarono a suo tempo una cappelletta dove tuttora
si riuniscono a pregare. In quegli eremi, gli alberi hanno
avuto a che fare con le orazioni e la santità, mentre a
Sant’Alfio, alle pendici dell’Etna, con la potestà
regnante e agguerrita: la regina Giovanna d’Aragona si
riparò con tutto il suo seguito all’ombra di un castagno
alto e fronzuto, che per questa sua eccezionale prestazione
tutelare venne e viene tuttora chiamato “dei cento cavalli”.
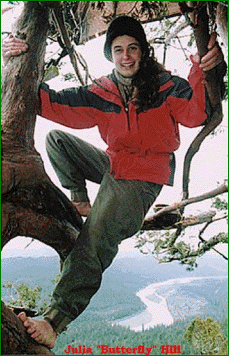 Gli
alberi proteggono dunque gli uomini. Il pacato respiro di
uno solo di essi produce ossigeno bastante alla vita di
trenta individui. Sereno, armonioso metabolismo che trae dal
sole la propria vivificante energia. I boschi sacri degli
antichi furono i primi templi. Dai boschi i nostri antenati
trassero nutrimento e materia per erigere le loro civiltà
urbane, nei boschi si rifugiarono, per sottrarsi alle
prevaricazioni dei potenti e ritrovare se stessi, rinascere
alla vita in piena libertà e dignità. I Wandervögel
dell’epopea romantica, riscoperti da Hermann Hesse, i Waldgänger
di Ernst Jünger che, ribellandosi ai guasti e ai ricatti
della civiltà materialistica e coartante “passavano al
bosco”, ritornavano cioè a un rapporto ancestrale con la
natura e con quel grande spirito che pervade ogni cosa, e di
cui sempre piú spesso l’uomo smarrisce l’essenza. Gli
alberi proteggono dunque gli uomini. Il pacato respiro di
uno solo di essi produce ossigeno bastante alla vita di
trenta individui. Sereno, armonioso metabolismo che trae dal
sole la propria vivificante energia. I boschi sacri degli
antichi furono i primi templi. Dai boschi i nostri antenati
trassero nutrimento e materia per erigere le loro civiltà
urbane, nei boschi si rifugiarono, per sottrarsi alle
prevaricazioni dei potenti e ritrovare se stessi, rinascere
alla vita in piena libertà e dignità. I Wandervögel
dell’epopea romantica, riscoperti da Hermann Hesse, i Waldgänger
di Ernst Jünger che, ribellandosi ai guasti e ai ricatti
della civiltà materialistica e coartante “passavano al
bosco”, ritornavano cioè a un rapporto ancestrale con la
natura e con quel grande spirito che pervade ogni cosa, e di
cui sempre piú spesso l’uomo smarrisce l’essenza.
- Necessità di riconciliarsi con se
stessi e con la divinità, ecco cosa ha spinto anche Julia
Hill “Butterfly” a insediarsi sulla cima di una
millenaria sequoia americana e viverci per due anni,
lottando contro la Pacific Lumber Company, che voleva
abbattere tutta la secolare foresta di sequoie per farne
legname da costruzione. Coraggioso esempio di tree-sitting,
che fa il pari, su un piano meno nobile ed epico, con il tree-climbing
del Tarzan metropolitano, all’anagrafe Antonio Mollo,
installatosi tra i rami di un tiglio secolare del Pincio, a
Roma, eletto a sua dimora a vita. Julia Hill vuole salvare
lo spirito cosmico e l’eredità naturale del mondo,
Antonio Mollo la propria identità di uomo libero. Azione
meditata quella della ragazza americana, atto disperato
quello dell’uomo, che rifiuta la civiltà malata e
contraddittoria. Una civiltà che noi tutti siamo riusciti a
creare a spese del patrimonio di armonia e bellezza di cui
eravamo stati dotati.
- E forse questi tentativi di
ritorno al nemus primigenio, nobili o maldestri che
siano, ci meriteranno la misericordia divina, e dall’Ade
tenebroso e gelido usciremo a riveder le stelle. Allora
Core, la fanciulla della nostra innocenza recuperata,
tornerà sulle rive del Pergo incantato, cogliendo fiori
variopinti e odorosi nella frescura di un bosco dell’eterna
primavera, come ben dice Ovidio sempre nelle Metamorfosi:
Un bosco fa corona alle sue acque,
da ogni lato le cinge con le fronde,
vela di Febo il fuoco e l’addolcisce.
Frescura danno i rami e variopinti
fiori produce l’umido terreno:
qui, dell’eterna primavera è il bosco
dove giocava a cogliere, Proserpina,
viole e gigli, e ne colmava cesti
e la sua veste ripiegata in grembo. |
Leonida I. Elliot
|