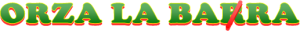Il direttore delle pompe funebri sembrava sinceramente addolorato: «Ve lo assicuro, signori miei – si giustificava accorato – non c’è proprio nulla da fare. Per vostro zio, purtroppo, non rimane che l’interramento a Prima Porta!».
Alberto insistette: «Ma ha provato con gli addetti alle sepolture?» chiese accompagnando la domanda con un eloquente strofinio di pollice, indice e medio, a indicare la sempre valida pratica della corruzione monetaria.
«Piano, con cautela – fu la risposta sconsolata del Direttore – non possiamo rischiare oltre un certo limite… anche perché – e si mise a rovistare nella cartella della pratica riguardante lo zio – anche perché, dicevo, cinque anni fa un parente di vostro zio, un certo Aristide Marchini – compulsò un foglio ingiallito – qui dice cugino di quarto grado, è stato inumato nel loculo di vostro competenza usando, voglio dire non lui, ma chi svolse le pratiche al momento del decesso, proprio quel sistema» e ripetè il gesto allusivo di Alberto, sfregando piú volte con energia le tre dita per indicare la consistenza della mancia erogata.
Carla reagí inviperita: «Ma quell’Aristide era una specie di prozio alla lontana…».
«Molto alla lontana…» rincarò Alberto.
Carla proseguí con foga: «…era un appartenente al ramo dei Marchini per intrecci matrimoniali di vari letti. E qui non sto a specificare… ci vorrebbe un esperto araldico e ci perderemmo in un ginepraio di parentele» e fece ruotare piú volte la mano all’altezza del viso congestionato, volendo segnalare la sua resa davanti a un argomento di cui, una volta introdotto, non si poteva prevedere lo sviluppo e l’esito finale.
Alberto tentò di calmare sua moglie: «Non te la prendere, Carla. Il signore non c’entra nulla. Sta facendo del suo meglio!».
«Appunto – ripeté il direttore – mi sto dannando l’anima per sistemare vostro zio, credetemi».
Dopo un attimo di silenzio, Alberto riprese: «Vede, lo zio Ernesto era praticamente solo, era scapolo e benestante. Achille, un nostro cugino, uno sfaccendato che non ha mai lavorato in tutta la sua vita, ha ronzato per anni intorno allo zio Ernesto con lo scopo di entrare in casa sua e restarci. Lui abitava, anzi abita ancora, in una cameretta ammobiliata a San Giovanni…».

Viale delle Cappelle al Verano
Carla intervenne: «Ma solo perché gli abbiamo impedito noi di impossessarsi della casa. Non ci siamo riusciti purtroppo con la tomba al Verano, al viale delle Cappelle…».
Alberto continuò: «Quando cinque anni fa è morto il padre di Achille, lo sfaccendato per mestiere è riuscito a farsi firmare una liberatoria dallo zio Ernesto. Con quel documento, corrompendo forse qualche impiegato degli uffici cemeteriali, ha ottenuto la disponibilità dell’ultimo posto della tomba».
«Quello purtroppo non siamo riusciti ad impedirlo» disse Carla in un sospiro. Tacque per un attimo, poi in tono piú deciso aggiunse: «Senza saperlo, lo zio Ernesto, con quel gesto di generosità, rinunciava all’eterno riposo e condannava noi all’agitazione perpetua».
Il direttore sorrise: «Vedo che vi state adattando molto bene alla situazione, specie lei signora. Vedrete, vostro zio si troverà benissimo a Prima Porta».
Alberto volle dire la sua: «Mi chiarisca una cosa, però, caro direttore. Si legge continuamente sui giornali e si vede alla TV di cappelle monumentali al Verano che, non essendo piú usate perché le famiglie proprietarie si sono estinte, vengono adibite a depositi di attrezzi, i ladri vi nascondono la refurtiva e vi si riuniscono per organizzare altri colpi, o, come ho letto di recente nella cronaca di Roma, in una tomba mausoleo appartenuta a uno dei Borboni hanno addirittura allestito una vera e propria bisca, con croupier e roulette. Mi chiedo, non si possono requisire tutte queste tombe diciamo sfitte ed assegnarle a chi ne ha bisogno?».
«Ecco, proprio cosí, restituirle al loro uso naturale» volle aggiungere Carla.
Il direttore allargò le braccia e appoggiò le mani sul ripiano di vetro della sua scrivania. «Certo, sono pienamente d’accordo – rispose condiscendente – ma il diritto di proprietà su cui si fonda la nostra società non prevede l’esproprio che in casi molto particolari, cara signora. Sarebbe troppo bello se venissero requisite tutte le case sfitte di Roma, e pensi che ammontano a diverse centinaia di migliaia, dicono circa 280.000 tra case e appartamenti completamente vuoti da anni. Non li occupano i proprietari e neppure li affittano a un equo prezzo. Preferiscono tenere queste case inoccupate, desolatamente vuote, magari le fanno andare in rovina, ma mai le darebbero alle migliaia di senza tetto che affollano i ridotti delle stazioni, i giardinetti pubblici, alloggiano sotto i ponti della ferrovia, del Tevere e dell’Aniene: un popolo intero di gente non in grado di permettersi di pagare un affitto ai prezzi correnti».
«È vergognoso!» esclamò Alberto.
«Disumano…» rincarò sua moglie.
Il direttore lasciava ormai carta bianca al sociologo che sopiva in lui. Riprese a dire: «Ma non leggete i giornali, non vedete la Tv? Ogni dieci secondi un bambino muore di fame in Africa, per cui mentre arrotoliamo i nostri spaghetti ci obbligano a pensare al povero bimbo africano che sta spegnendosi per mancanza di tutto: cibo, acqua, aspirine, antibiotici… Ecco allora che il problema di vostro zio diventa una goccia nel mare dei problemi essenziali del mondo globale, mi capite?».
«Sí, egregio amico – reagí Alberto – è tutto molto giusto quello che dice, ma ciò non toglie che mettere un morto in un deposito e tenercelo in attesa, magari per settimane, in una città che si vanta di essere la capitale morale e religiosa del mondo, non è giustificabile in alcun modo!».
«Settimane? Forse mesi! Pensate che ci sono bare con morti che giacciono nel deposito persino da anni!».
«Santo cielo!» esclamò inorridita Carla.
«Roba da Terzo Mondo!» aggiunse Alberto.

Riva del Gange a Benares
Il direttore soggiunse: «Magari Terzo Mondo! Quelli, caro dottore, hanno risolto brillantemente il problema dello spazio, e anche di tutte le altre liturgie e cerimonie che qui affliggono chi è costretto a occuparsi di un defunto. In India, ad esempio, l’ho visto io con i miei occhi, a Benares, oggi Varanasi, la città santa sul Gange, il morto lo mettono su una pira e gli danno fuoco. Un po’ di nenie e preghiere e mentre le spoglie vengono arse qualcuno canta, perché come sapete per loro la morte è una liberazione. Insomma, quando il fuoco ha bruciato tutto, i necrofori recuperano le ceneri dalla pira, poca roba, un mucchietto di resti, e li mettono in una brocca di metallo che consegnano ai parenti. I quali si avviano al fiume, sempre cantando e spargendo fiori, e una volta arrivati alla riva, se hanno i soldi noleggiano una barca e raggiungono il centro del fiume, dove la corrente è piú forte. Qui rovesciano la brocca e lasciano le ceneri nella corrente. Lo stesso fanno dalla riva quelli che non possono pagarsi una barca. Semplicemente svuotano il recipiente con le ceneri direttamente nel fiume».
Alberto e Carla avevano ascoltato perplessi e un po’ turbati il racconto del direttore. Dopo un attimo di smarrimento, reagirono, e fu Carla a parlare. Il suo tono era rassegnato: «Con questo lei vuol farci capire che dobbiamo accettare la morte di nostro zio con la ineluttabilità del karma in cui credono gli indiani e rassegnarci a mettere nostro zio nel posto dove lo ha destinato il Fato, o la Provvidenza?».
Il direttore si illuminò. Si alzò dalla sua poltrona e si diresse verso il plastico enorme che campeggiava su un ripiano in fondo alla sala. «Vedo che la soluzione Prima Porta vi appare in tutta la sua convenienza. Vedete, questa è la posizione della tomba in cui andrà vostro zio… Guardate che esposizione sopraelevata, con la campagna del Flaminio dritta davanti, soleggiata tutto il giorno, alberata…».
«Verrebbe voglia di morire per abitarci!» fu la battuta di Alberto, ma il direttore non l’accolse molto bene. Fece una smorfia che avrebbe dovuto esprimere ilarità, ma che finí col trasformarsi in uno spasmo di irritazione mal dissimulata.
Carla fissò il marito con stupore, ma in fondo ne approvava il commento estemporaneo. Il direttore aveva il tratto dell’imbonitore turistico, pur trattando una materia che poco avrebbe dovuto concedere al divertimento.
L’uomo riassestò la bocca in una posizione formale e composta e proseguí: «Ecco, guardate il plastico – con le dita raggiunse un angolo della mappa e puntò un riquadro con vari puntini colorati. – La tomba si trova nella Sezione H, area 12, viale 45, schiera 27, loculo 19… È proprio dove la collina inizia dolcemente a declinare, ma la postazione rimane esattamente sul crinale». Intanto la mano dell’uomo si era dotata di una bacchettina e con quella esplorava i rilievi del plastico, dove figuravano tondi e quadrati, rettangoli e triangoli, e poi linee parallele per indicare i viali e alberi tratteggiati con merlettature verdi. La città dei morti, dove lo zio Ernesto si sarebbe dovuto trasferirsi per sempre. Dopo l’illustrazione del plastico, il direttore ritornò al suo posto e con un gesto indicò le sedie.
Carla estrasse dalla borsetta una foto e la porse al direttore attraverso il ripiano della scrivania. Tutti i loro gesti venivano duplicati dal vetro e assumevano un carattere metafisico, ectoplasmatico.
«Cos’è?» chiese l’uomo mentre prendeva la foto.
«È lo zio Ernesto» disse Carla.
«Non quello che abbiamo chiuso nella cassa – celiò il direttore, rigirando la foto. – Qui vedo un signore ancora prestante, che veste da schiuma dei mari, con tutte queste conchiglie infilate nella cintura, e i moschettoni, i nodi marinari, il berretto da rimorchiatore…».
«Ma è lui, è lo zio Ernesto quando lavorava sui traghetti per isole Pontine – precisò Alberto – dopo che in gioventú aveva navigato sui bastimenti di lungo corso. Aveva visitato mezzo mondo!».
Il direttore si era pentito di aver detto “schiuma dei mari”, ma l’impressione che si riceveva osservando quella foto era proprio quella: di uno che era stato e che recitava ad essere una schiuma dei mari. Se ne uscí con un’osservazione strategica: «Adesso capisco la scelta del modello Viaggio di Ra» disse agitando a ventaglio la foto.
«Vale a dire?» intervenne Carla sospettosa.

Bara a barca di Ra
«Il modello della bara – chiarí il direttore prontamente. – Avete scelto il modello egizio, il 717, con le maniglie dorate a forma leggermente allungata, a mandorla… la barca di Ra… Eccola!». Aprí il catalogo alla pagina dove figurava un set di bare definite “mitologiche”. C’era il modello Clitennestra, Betsabea, Brunilde, e altre che si ispiravano a personaggi leggendari e a periodi storici molto connotati. In fondo alla pagina, il dito indice del direttore si appuntò sul modello 717. «Ecco, vedete, questa viene chiamata Barca di Ra, per essere traghettati oltre il fiume dell’eternità…».
Rigirò ancora per qualche momento la foto tra le dita, poi stava per restituirla facendola scivolare sul vetro in direzione di Carla.
«No, direttore – reagí lei, respingendo la foto al punto di partenza – ecco, noi vorremmo… vero, Alberto? – si rivolse al marito, che assentì. – Vorremmo che questa foto venisse posta sulla lapide della tomba, bene in alto, visibile, magari illuminata. Ci teniamo in maniera particolare. Giusto, Alberto?».
Di nuovo il marito annuí.
«Va bene, come volete» si rassegnò il direttore, incamerando la foto.
«Come voleva lo zio, semmai – corresse Alberto. – Noi tutto siamo fuorché marinai».
Quando furono soli in macchina, diretti a casa, Carla chiese ad Alberto: «Di’, ma lo zio è stato veramente quel grande navigatore che si vantava di essere? Certo, a sentirgli raccontare le sue avventure al bar sotto casa, dove tutti lo chiamavano “capitano” ne aveva fatte e viste piú lui di Magellano e Colombo messi insieme… Mi dà l’idea che si inventasse non tutto ma quasi tutto di quello che raccontava…».
Alberto rifletté per qualche momento, poi scosse il capo, e rivolgendo uno sguardo tranquillo a sua moglie, disse pacato: «Che importanza può mai avere, se fossero verità o invenzioni? L’uomo è quello che sarebbe potuto essere nella vita, non quello che gli hanno permesso di essere». Stette ancora in silenzio per qualche secondo, poi aggiunse, convinto: «Lo zio è stato una vera schiuma dei mari, e come tale noi lo ricorderemo».
Il furgone vetrato con a bordo lo zio Ernesto nella sua bella cassa con le maniglie egizie si destreggiava per districarsi nel traffico intenso della città. Alberto alla guida faticava molto a stargli dietro, con brusche frenate, partenze a scatto, zigzagando tra le altre vetture che impietosamente chiudevano lo spazio, scavalcavano, intersecavano. Carla si aggrappava al reggimano laterale, puntava i piedi sul fondo dell’auto come se avesse voluto aggiungere altra forza di presa ai freni.
«Mi ricorda le macchinette a scontro del luna park!» ironizzò a un tratto per scaricare la tensione. Alberto assentì, frenando di colpo subito dopo per evitare l’impatto con un camion. Carla, indicando il furgone che emergeva poco piú avanti dal mare caotico delle macchine, sbottò isterica: «Certo, che tra lo zio e noi non so proprio chi stia meglio!».
A quelle parole, Alberto venne preso da un senso di commozione. «Povero zio Ernesto – esclamò in tono accorato. – Negli ultimi tempi sognava di essere di nuovo a bordo del Semiramis a caricare legno di tek a Dakar, nel Senegal. Ricordi?»
Carla annuí: «Mi ricordo, eccome. Non si era mai rassegnato a fare l’animale terrestre. Era nato per stare a mollo. Negli ultimi giorni, quando gli portavo da mangiare e lui si addormentava alla fine del pasto, l’ho sentito parlare nel sonno…».
«E che diceva?».
«Biascicava parole incomprensibili, ma una frase a un certo punto mi fu chiara e comprensibile. La pronunciò ad alta voce, come se impartisse un comando alla ciurma. “Orza la barra!”».
«E non ha detto altro?».
«No, perché l’ho svegliato, ma lui non ricordava piú nulla di quello che aveva sognato».
Rimasero in silenzio per qualche momento. Poi Carla riprese a dire, inseguendo il filo dei pensieri:
«Lo zio Ernesto era un’anima libera. Amava i colori, gli spazi aperti, l’aria, la luce, il vento. – Tacque pensosa per poi osservare sorridendo con aria maliziosa: «E le donne? Non ci siamo mai chiesti delle sue avventure amorose…».
Alberto rise. «Ma certo che ne avrà avute… Una donna in ogni porto, no? Cosí sono i marinai, è tipico. Non abbiamo ancora guardato tra le sue cose nella sua stanza. Vedrai quante sorprese!».
«Che strazio, questo traffico!» si lamentò Carla, aggiustandosi la cintura di sicurezza.
«Ecco – osservò Alberto – lui almeno, lo zio Ernesto, di questi problemi non ne avrà piú!».
«E chi può dirlo – commentò enigmatica la moglie – chi ci dice cosa troverà dall’altra parte…».
«Magari troverà una grande nave soprannaturale, di cui avrà il comando. Sennò che paradiso sarebbe!».
«Allora tu dai per scontato che lo zio andrà in paradiso!».
«Ma certo, e spero proprio che troverà una bella nave metafisica ad attenderlo, e lui sarà insieme comandante e ciurma!».
Carla alzò le spalle. Poi si fermò ad osservare la pioggia che aveva cominciato a cadere. Sembrava grassa e oleosa, piú nafta e anidride solforosa che acqua.
«Ci mancava anche questa…» mormorò a denti stretti Alberto.
«Se va avanti cosí – disse Carla – dovremo telefonare in ufficio per giustificare anche il pomeriggio».
«Già, l’ufficio… E chi ci pensava piú – disse Alberto. – Dai, telefona, qui di questo passo faremo sicuramente notte».
Carla tirò fuori dalla borsetta il cellulare e dopo qualche secondo avvisò prima il suo ufficio, poi quello del marito.
«Quanto vorrei piantarlo quel lavoro!» disse Alberto, e a rinforzare lo sfogo pigiò sul clacson all’indirizzo di una moto che aveva scavallato sulla destra, con uno zig zag pauroso.
«Incosciente!» esclamò Carla. Poi in tono piú pacato, aggiunse: «Sai, l’ufficio ci permette di pagare i conti, e di fare qualche viaggio».
«Il brutto dei viaggi – osservò Alberto – è che poi finiscono e si torna in ufficio».
«Lui, lo zio – soggiunse in tono meditabondo Carla – dal suo certamente non ritorna».
Alberto distolse l’attenzione dal volante e scrutò di sbieco sua moglie. Le colse sul viso un’espresione assorta, distante, persa dietro indecifrabili pensieri. Ma indovinava che fossero la copia esatta dei suoi.
Riportò lo sguardo sul furgone che tentava di farsi strada nel groviglio di auto e camion come una nave rompighiaccio nella morsa del pack antartico. Disse: «Sí, hai ragione, lui non tornerà indietro, ovunque sia diretto! ». Diede poi un’occhiata di fianco per evitare la manovra azzardata di un’altra grossa moto, e aggiunse: «E non è detto che noi arriviamo da qualche parte!».

Vascello fantasma
Carla non pareva ascoltare, persa dietro i suoi pensieri. Poi riscuotendosi chiese: «Ricordi quando siamo andati all’Opera a vedere l’Olandese Volante?».
La domanda, in qualche modo fuori contesto, colse di sorpresa Alberto. «È stato tre anni fa, credo» rispose lui dopo una breve concentrazione.
«Quattro – precisò Carla, puntando l’indice in aria – è stato quattro anni fa».
«E allora?» Alberto tornò a scrutarla, interdetto.
«Non era un fantasma quello che comandava la nave?».
«E questo che c’entra?».
«Mah, io ci vedo zio Ernesto, un bel fantasma navigante che solca i mari dell’eternità. E me lo figuro come quando andava in giro per il quartiere, con la giubba, il berretto e tutti gli ammennicoli appesi alla cintura, chele di granchio, moschettoni di acciaio, ganci da presa…».
«Ma che vai pensando? Zio Ernesto Olandese Volante!».
«E io invece penso proprio che il paradiso sia cosí: vengono esauditi tutti i nostri desideri di quando eravamo vivi…».
Alberto tornò a scrutare sua moglie con un certo stupore, unito a preoccupazione. Disse in tono ironico: «E tu, che vorresti avere che non hai… magari in attesa del paradiso?».
Carla abbozzò un sorrisetto malizioso mentre inclinando la testa di lato rispondeva: «Intanto vorrei un frigo nuovo, no frost, per non doverlo sghiacciare continuamente come devo fare ora… E poi, mi piacerebbe quella madia provenzale che abbiamo visto l’estate scorsa alla Fiera del Mobile. Te la ricordi?».
«Certo, ricordo esattamente anche il prezzo» Alberto scosse la testa e aggiunse: «Il frigo, vedremo… Quanto alla madia, aspettiamo di essere in paradiso!».
Finalmente il traffico urbano si era diradato e il furgone, imboccata la Via Salaria, aumentò l’andatura.
«Cerca di stargli dietro!» si raccomandò Carla. Alberto faceva del suo meglio, ma la sagoma scura del veicolo col feretro guizzava via dribblando le auto, sfiorando a tratti i grandi platani che fiancheggiavano la strada.
«Ecco le conseguenze del lavoro a cottimo – si lagnò Alberto – piú morti traslocano e piú guadagnano!»
«Attento, non parlare!» gridò Carla, sapendo molto bene che il marito rischiava di alienarsi completamente dalla realtà.

La diga del Tevere a Castel Giubileo
Alberto riuscí però con una accelerata a portarsi quasi a ridosso del furgone, che intanto, lasciata la Salaria, aveva imboccato il raccordo anulare. La diga di Castel Giubileo si delineò in fondo, oltre la teoria di auto e mezzi pesanti col luccichío del Tevere in quel punto ancora indenne dal putridume della metropoli.
La pioggia ora cadeva piú forte, infrangendosi sul manto stradale e picchiando con violenza sulla carrozzeria.
«Ma è grandine! – esclamò Carla in apprensione. – Ci mancava anche questa!»
«Dai, non esagerare, è solo pioggia. Vedrai che passato il fiume si calmerà» disse Alberto per tranquillizzarla, cercando di non perdere di vista il furgone che avanzava nel turbinare di acqua e di vento.
Poco prima della diga, un grosso camion di traslochi, per superare un’auto ferma sulla destra forse a causa del diluvio, si spostò a sinistra senza mettere la freccia, invadendo la corsia di sorpasso. In regime di tempo buono, la leggera pressione sul pedale dei freni operata dal guidatore del furgone sarebbe bastata a rallentarne l’andatura evitando cosí di tamponare il camion. Solo che il fondo della strada, reso viscido dalla pioggia battente, non fece andare le cose come l’autista avrebbe voluto. Le ruote andarono soggette al cosiddetto effetto acquaplano, il furgone slittò e si mise di traverso. Poi tutto si svolse come in un incubo. Stridore di freni, cozzare di lamiere, urla. Alberto riuscí a fermare l’auto sulla destra sottraendosi all’infernale gimkana seguita all’azzardata manovra del camion. Ma il furgone ci era capitato proprio in mezzo. Marito e moglie assistettero impotenti alla scena che seguí: il furgone venne urtato da un trasporto latte, roteò, si raddrizzò, ma un altro colpo lo spinse dopo un testa coda contro il guardrail. Sotto, il fiume. E quello che avvenne allora doveva stamparsi come un film horror nella mente di tutti gli automobilisti che, scesi dalle loro vetture, cercavano di rendersi conto dei danni. Alberto e Carla avrebbero voluto fare qualcosa, intervenire, ma tutto accadde nel giro di secondi. L’ultima botta aveva spinto il furgone con estrema violenza contro il fascione del guardrail. Sotto la potenza dell’impatto, la bara si era staccata dal supporto, aveva sfondato il cristallo posteriore ed era letteralmente volata di sotto, nel fiume, con una parabola elegante e perfetta.
«No!» urlò Carla, portandosi le mani alla testa, ma non riuscí a dire e a fare altro, perché la voce le si bloccò in gola. Rimase immobile nel sedile, gli occhi sgranati.
Alberto invece trovò la forza per lanciarsi fuori dalla vettura e correre verso il furgone rimasto incastrato nel guardrail. Altri automobilisti lo avevano imitato. Si sporsero tutti dal varco dove la bara era precipitata. Alberto poté scorgere la massa di legno scuro che, sprofondata nell’acqua limacciosa del fiume, era riaffiorata alcuni metri oltre la rapida che si formava in quel punto. Ora fluttuava con maestosa lentezza, trascinata a valle dalla corrente. L’autista appariva sconvolto. Ascoltava frastornato i commenti che gli arrivavano come un ronzío di insetti molesti dall’assembramento eccitato dei testimoni, animati dalle migliori intenzioni:
«Ma cosa è stato?».
«Certo con questa pioggia!».
«Si è fatto male?»
«Mio Dio, che disastro!».
«Qualcuno chiami la polizia!».
«Qui ci vogliono i pompieri!».
«No, la polizia fluviale… la cassa è caduta nel fiume…».
Il pover’uomo rispondeva a monosillabi, sbracciandosi, indicando ora la bara che se ne andava via nella corrente, ora il furgone. Si scusava, ringraziava, si muoveva in giro come una mosca senza testa. Ma poteva ritenersi miracolato, gli dicevano, se non era finito anche lui giú nel gorgo. Chi stava veramente male era il suo collega. Durante il testa coda, istintivamente aveva sganciato la cintura di sicurezza ritenendo di doversi preparare a saltare fuori. Questo lo aveva consegnato allo sballottamento e infine a dare con la fronte contro la lamiera anteriore del furgone, e ora sanguinava copiosamente appoggiato al cofano. Una signora si fece forza e lo aiutò a tamponarsi con un fazzoletto.
«Ma lei deve andare di corsa al pronto soccorso!» lo esortava la signora.
E un volenteroso, lí vicino: «L’accompagno io… la mia macchia è fuori della mischia…».
Intanto un ululato di sirena annunciava l’arrivo di una volante della Polizia Stradale. Dopo aver zigzagato tra le auto ferme, si arrestò a ridosso del furgone, e la sirena si acquietò smorzandosi in un singulto. In agitazione, dandosi sulla voce, Alberto e l’autista fecero ai due poliziotti un resoconto della meccanica dell’incidente, ma soprattutto Alberto ci tenne a far vedere ai due tutori dell’ordine viario la bara dello zio che si poteva, sporgendosi un poco, aguzzando la vista, ancora a scorgere in lontananza, diretta si presumeva ormai a Ponte Milvio, e oltre.
«Non si può fare niente per fermarla?» chiese alla fine Alberto.
«Ecco, sí… per favore!» aggiunse accorata Carla, che intanto era uscita dalla macchina e dava man forte al marito.
«Noi ci occupiamo della strada, signora – rispose asciutto il capo pattuglia, accennando al furgone e alle auto disastrate. – Noi dobbiamo pensare a sistemare le cose qui. Per vostro zio, ci penseranno le autorità fluviali. Ma prima dovete denunciare l’incidente alle autorità».
Intervenne il suo collega piú giovane: «Qui a Prima Porta – fece segno in direzione dell’agglomerato di palazzine basse oltre la diga – ci sono i Carabinieri… Ci penseranno loro ad avvisare il Soccorso Fluviale».
Prima di andare, per sfogare la frustrazione e lo spavento Carla se la prese con l’autista che stava spiegando ai poliziotti come, secondo lui, si era svolto l’incidente: «Se lei avesse guidato piú lentamente, tutto questo disastro non ci sarebbe stato! E poi, credo che il suo furgone non abbia le gomme a posto».
«Ma signora!» reagí disperato l’autista.
E uno dei poliziotti: «La prego, si calmi. Stabiliremo noi le responsabilità».
L’autista aggiunse, in tono risentito: «Siamo dei professionisti, cosa crede!».
Alberto tirò via sua moglie: «Andiamo, Carla, qui perdiamo solo tempo, e intanto lo zio se ne va…».
«Sí, sí, vengo… Ma quello – e indicò, con un rapido cenno del viso alterato, l’autista – quello vuol far credere alla polizia che non è stata colpa sua!».
«Su, andiamo, la polizia verificherà e stabilirà come sono andate veramente le cose. E poi ci sono le assicurazioni, no? Pensiamo piuttosto a recuperare lo zio, altrimenti quello se ne va in Africa!».
«O la cassa si sfascerà contro i piloni del primo ponte che incontra. Ci pensi? Lo zio nella melma del Tevere, dopo i sogni di navigazione verso le isole felici!».
«Vedrai che lo ripescheranno!».
«Mi fai pensare a un concorso canoro, quando ripescano i candidati per riammetterli alla gara. È semplicemente orribile!».
 La tenenza dei Carabinieri di Prima Porta era sistemata in un villino quasi civettuolo a due piani, e ricordava piú un’abitazione di personaggi fiabeschi che un luogo dove convergevano ladri e trasgressori. L’unica nota che ne faceva un presidio autorevole da non prendere sottogamba era un enorme cartello, ripetuto varie volte lungo il recinto liminare del complesso, che avvisava: “Zona militare. Divieto di accesso. Sorveglianza armata”. Non era chiaro perché una persona provvista di buon senso dovesse scavalcare il recinto e subire gli strali della legge. Dentro, tutt’intorno all’edificio, si sviluppava un ameno giardino coltivato a fiori e piante, festonato di colorate bandierine. Che mai avrebbe potuto sabotare un guastatore che fosse penetrato clandestinamente in quel paradiso?
La tenenza dei Carabinieri di Prima Porta era sistemata in un villino quasi civettuolo a due piani, e ricordava piú un’abitazione di personaggi fiabeschi che un luogo dove convergevano ladri e trasgressori. L’unica nota che ne faceva un presidio autorevole da non prendere sottogamba era un enorme cartello, ripetuto varie volte lungo il recinto liminare del complesso, che avvisava: “Zona militare. Divieto di accesso. Sorveglianza armata”. Non era chiaro perché una persona provvista di buon senso dovesse scavalcare il recinto e subire gli strali della legge. Dentro, tutt’intorno all’edificio, si sviluppava un ameno giardino coltivato a fiori e piante, festonato di colorate bandierine. Che mai avrebbe potuto sabotare un guastatore che fosse penetrato clandestinamente in quel paradiso?
«Mi rendo conto del vostro stato d’animo» disse il comandante della caserma, dopo aver ascoltato il resoconto dell’incidente, cercando di apparire il piú compreso possibile. Ma non ci riuscí del tutto. tanto che dopo un attimo di esitazione, celiò con un mezzo sorriso: «Non vorrei apparirvi irriverente, ma certo che il vostro caso è al limite dell’assurdo!».
«Oh, lo può ben dire – rispose Alberto. – È in tono con la personalità di nostro zio».
«È stato un originale per tutta la vita…» rincarò Carla.
«E anche da morto, non scherza!» volle concludere meditabondo Alberto, scuotendo la testa.
E Carla: «Questo però non vuol dire che dobbiamo lasciare lo zio Ernesto in balía del fiume». Poi aggiunse, con una punta di risentimento nella voce: «Non crede anche lei?».
«Certo! – convenne il comandante – la prima cosa da fare è avvisare la Polizia Fluviale. Noi possiamo muoverci sulla terraferma, ma nel caso di vostro zio è una faccenda che riguarda i fiumaroli, come li chiamiamo in gergo, o i pompieri, che spesso operano congiuntamente». Mentre parlava aveva composto
un numero, che risultò occupato. Ne compose un altro. Un sibilo sortí dalla cornetta e irritò visibilmente l’ufficiale.
«Salteri!» chiamò poi a voce alta.
Un sottoposto si affacciò dalla porta: «Comandi!».
«Passami la Polizia Fluviale. Rapido, però!».
L’altro ritirò la testa e dopo qualche secondo lo udirono formare un numero nella stanza accanto, parlottare concitato, quindi il telefono sul tavolo del comandante squillò.
«Ah, sei tu, Cammarano. Bene, bene. Ho un caso molto urgente, e adire la verità alquanto insolito. Senti di che si tratta…». In tono conciso il comandante fece il resoconto dell’accaduto. «Capisci – spiegava – la cassa è finita in acqua alla diga di Prima Porta e sta navigando verso Ponte Milvio… almeno da una ventina di minuti… certo… mi rendo conto. Ho qui i parenti davanti a me. La denuncia? Ma certo, la inoltro io, e anche il comunicato ai Vigili e alla Questura… Non ti preoccupare, Cammarano, tu devi solo ripescare la cassa… Ma mi raccomando, rapidità, e anche – rivolse uno sguardo ammiccante a Carla e al marito – discrezione… Sai cosa intendo! – Altro sguardo allusivo ai due coniugi. – Mi riferisco alla stampa. Sai quelli ci sguazzano anche in storie meno importanti, figuriamoci in una come questa! Ti saluto… Tienimi informato!». Riagganciò, e guardando compiaciuto i due che sedevano tesi dall’altra parte della scrivania, disse: «Ecco, ora la macchina è in movimento. Nel giro di una mezz’ora tutte le forze di intervento saranno sul campo – esibí un sorriso impacciato – cioè saranno in acqua».
Poco dopo il telefono squillò. Il comandante disse: «Scusate…» e sollevò il ricevitore. «Tor di Quinto? I pompieri? Chi vi ha chiamato? Ah, quelli di Prima Porta… Sí, stanno qui da me. D’accordo! Saranno lí tra dieci minuti!». Riattaccò, poi disse in tono formale: «L’operazione di recupero è stata affidata, secondo il codice interforze, al presidio piú vicino alla posizione della cassa, in questo caso i pompieri di Tor di Quinto. Hanno il presidio nei pressi di Ponte Milvio… È una fortuna… Possono intervenire subito».
«E noi che facciamo, nel frattempo?» chiese Alberto.
«Vi aspettano al Gruppo Pompieri di Tor di Quinto. Cosí, potrete seguire, per cosí dire, da vicino le fasi del recupero di vostro zio».
 Carla, come al solito, volle puntualizzare. «Non capisco perché i pompieri – obbiettò calma. – Si fosse trattato di un incendio, di un crollo, avrebbe senso coinvolgerli, ma qui si tratta di acqua».
Carla, come al solito, volle puntualizzare. «Non capisco perché i pompieri – obbiettò calma. – Si fosse trattato di un incendio, di un crollo, avrebbe senso coinvolgerli, ma qui si tratta di acqua».
Il comandante sorrise con indulgenza. Replicò garbato: «Sí, in teoria sarebbe cosí, trattandosi di acqua, come lei dice, signora. Ma come ben sa, i pompieri intervengono anche in caso di allagamento, di alluvioni. Piove a Roma come mai nella storia? Ci sono interi quartieri sott’acqua? Scantinati invasi dal fango e dai detriti? Chi viene chiamato a manovrare idrovore, a spalare la melma, a rimuovere le macerie? I pompieri, ecco chi! Per cui, seguite un mio consiglio: andate a Tor di Quinto, dal capitano Cammarano. Vi sta aspettando. Vedrete, è l’uomo giusto».
Alberto e Carla, dallo sguardo che si scambiarono, denotavano perplessità e diffidenza. Il militare intervenne con un piglio energico. Si alzò dalla sua poltrona, e muovendosi verso di loro, li esortò: «Se fossi in voi – disse mentre accennava a congedarli tendendo la mano – non perderei altro tempo». Sorrise, sforzandosi di essere spigliato. Poi proseguì: «Il collega Cammarano dice che la corrente del fiume si è velocizzata con il nubifragio, ma è sotto controllo».
Una volta in macchina, diretti alla caserma dei vigili del fuoco, per l’emergenza vigili dell’acqua, marito e moglie si scambiavano riflessioni. Iniziò Alberto: «Come si fa a dire che è tutto sotto controllo! Come se Cammarano fosse in grado di fermare la corrente del Tevere, magari dividerla, e dal canalone asciutto in mezzo, come Mosè, portare in secco lo zio!».
Carla si stava riaggiustando i capelli guardandosi nello specchietto retrovisore sopra il cruscotto. Aveva una molletta tra i denti, e rispose sibilando: «Ci viene dai serial Tv americani… Dopo una sparatoria, o un incidente, o un terremoto, c’è sempre qualcuno che dice a qualcun altro “Va tutto bene, è tutto sotto controllo! E magari sta crollando il palazzo!».
«E nello stesso momento – aggiunse Alberto stando al gioco – l’eroe sopravvissuto alla sparatoria, mentre preme due dita sulla giugulare del criminale o del poliziotto colpito, e grida voltandosi dal lato degli spettatori: “Qualcuno chiami un’autoambulanza!”. Non si sognerebbe mai di alzarsi e chiamarsela da sé l’autoambulanza!».
Carla osservò, in tono pacato: «Se non fosse che lo zio è nella corrente, l’avremmo potuto recuperare da noi per portarlo al cimitero del Verano…».
«Per poi metterlo – aggiunse Alberto –in una di quella cappelle patrizie su al Pincetto, e buonanotte! Arrivederci nella Valle di Giosafat! E tu pensi che se ne sarebbero accorti, quelli dell’amministrazione cemeteriale?».
I pompieri all’inizio diedero l’impressione di voler fare qualcosa di piú dei carabinieri. Il capitano Cammarano fu solerte: fece accomodare Alberto e Carla, offrí loro un caffè e mentre lo sorbivano telefonò alla pattuglia fluviale.

La rapida di Ponte Milvio
«…A Ponte Milvio? Ha superato la rapida?… Però, che velocità!… Foro Italico… D’accordo. Mi tengo in contatto!». Prima che dallo stupore i due ospiti passassero alla protesta, Cammarano mise le mani avanti. «Capisco il vostro disappunto – disse empatico, e intanto con una matita segnava un punto sulla mappa che aveva davanti. – Vostro zio, non si sa come, ha già superato la rapida di Ponte Milvio e il Foro Italico. Evidentemente, almeno stando alla pattuglia fluviale, deve aver preso il centro della corrente».
Alberto lo interruppe: «Vale a dire?».
E Cammarano, paziente: «Sarebbe il centro del fiume, dove i flussi, per l’effetto del rimando dalle sponde, si combinano raddoppiando la loro velocità». Si interruppe per un attimo, poi riprese in tono comprensivo: «La nostra pattuglia è pronta ad intervenire…».
«Ma com’è che non lo hanno già fatto?» chiese Carla.
Cammarano sgorbiò con la matita sul tracciato della mappa. «Non ancora, perché il fiume nel tratto interessato non consente l’impiego di imbarcazioni. Garantiamo però l’intervento dei mezzi motorizzati piú a valle».
«E se la cassa finisce contro un pilone?» chiese preoccupato Alberto.
«La cassa ha preso, come spiegavo prima, il centro della corrente. Non può assolutamente uscirne. Solo che questo la fa procedere a una velocità problematica…».

Il salto del Tevere a Ponte Cestio
«E ti pareva!» commentò Carla.
«Quindi, capitano – chiese Alberto – dove pensa sarà possibile il recupero?».
«Mah – il capitano puntò la matita sull’Isola Tiberina – io direi che se c’è un punto dove la bara potrà essere agganciata dai motoscafi, è proprio qui, al salto di Ponte Cestio. Prima, data la condizione del fiume ingrossato dalla pioggia, non credo sia possibile».
«Mettiamo che superi quello che lei chiama salto – chiese ansiosa Carla – che succede?».
Cammarano si alzò, depose la matita e allargò le braccia. «Cara signora, io posso garantire per l’efficienza degli uomini e dei mezzi impiegati nell’operazione. Quanto poi all’imponderabile, beh, questo non è, consentitemelo, neppure augurabile. – Si fermò per elargire un sorriso rassicurante. – Suvvia, signori, ammetterete che si tratta di un caso su un milione, quello di un incidente sulla diga di Prima Porta e di una cassa da morto che fa un tuffo nel fiume. Io faccio questo lavoro da tanti anni e non ho mai affrontato un’emergenza simile. Ma ne verremo a capo, credetemi. Ve lo posso assicurare. Vostro zio, tempo qualche ora, forse meno, verrà tirato in secco!».
«Ma noi intanto che possiamo fare?» chiese Alberto.
«Potete andare all’ Isola Tiberina. È lí che stanno approntando lo sbarramento definitivo». Il capitano guardò l’orologio e concluse: «Sono le 10.40. Alla velocità attuale la cassa dovrebbe arrivare lí intorno alle 11.30, a meno che…».
«A meno che?» fecero all’unisono Alberto e Carla.
Cammarano appariva titubante: «A meno che – disse enigmatico – la cassa, anche se non lo credo, vada ad urtare contro un pilone, o uno dei barconi ancorati sulle rive del fiume. E allora…». Il suo tono si esaurí in una sfumatura lugubre.
E invece lo zio non aveva nessuna intenzione di finire contro uno dei piloni, e neppure di collidere con i goffi anacronistici barconi messi a marcire in una nostalgica scenografia di una Roma sparita, quella dei bagni nel Tevere pulito e odoroso, roba degli Anni Cinquanta. No, lo zio filò via liscio e sicuro, un vero missile nel giro tumultuoso della corrente, diventata ancora piú veloce man mano che la piena aumentava. Fu infatti un sollevamento inatteso e inusuale della massa d’acqua del flusso centrale della corrente che al salto dell’Isola Tiberina sollevò di peso la bara, facendola passare di un balzo oltre la barriera di Ponte Cestio, la proiettò oltre la rapida, e quando uno dei motoscafi della pattuglia fluviale tentò di abbordarla, lo urtò con un tremendo colpo nella fiancata. Il motoscafo fu sbattuto contro la massicciata dell’Isola e a stento gli occupanti riuscirono a mettersi in salvo sul molo. Un’altra imbarcazione provò ad agganciare il feretro, ma fu anch’essa spinta di lato, rischiando di naufragare dopo aver compiuto un paio di piroette, con gli occupanti, due poliziotti, che si agitavano e gridavano tra schiuma e spruzzi. Alberto e Carla dalla spalletta del ponte seguirono tutta la scena, e altri spettatori si affacciavano dai muraglioni, alcuni turisti scattavano foto e riprendevano con videocamere. Ma non ci fu nulla da fare. Alle 12.12, lo zio aveva superato lo sbarramento, e navigava veloce verso Ponte Marconi.

Il Tevere a Ponte Marconi
«Che succede adesso?» Alberto e Carla posero questa domanda al coordinatore della Polizia Fluviale. Il quale, allargando le braccia e scuotendo la testa sormontata da un bel cappello arricchito con le decorazioni di un’ancora e una ruota di timone dorate, ammise: «Non è mai capitata una cosa simile, ora non ci resta che Fiumicino. Abbiamo allertato le forze di Polizia del Porto di Traiano e di Fiumara Grande. Vi conviene andare lí e aspettare. La fermeranno!». Si tolse il cappellone e si grattò la testa. Evidentemente, la sua sicurezza era stata messa a dura prova da una cassa che aveva resistito a ogni ostacolo: quelli messi in campo dalla natura e dagli uomini.
A Ponte Marconi lo zio affiancò un grosso tronco sballottato dalla piena. Poi, un mulinello piú forte, al di là del ponte, separò i due compagni galleggianti, che presero ciascuno il proprio filo di corrente, il tronco quasi resistendo al flusso che lo spingeva, la cassa con lo zio assecondando la spinta dell’acqua, guadagnando metri su metri, avendo fretta e voglia di raggiungere al piú presto la foce del fiume e alla fine il mare.
«Che si fa, adesso?» chiese Carla, volgendo un ultimo sguardo allo zio che si allontanava tra i flutti. Nel cielo un elicottero volteggiava con un grande fracasso di eliche. Ad un tratto si abbassò e volò raso sull’acqua, nel punto dove la cassa ballonzolava su e giú, roteava, sommozzava per qualche attimo, poi riemergeva. L’elicottero virò stretto tra le due sponde, riprese quota, poi fece rotta verso il centro sorvolando le case della Magliana, fece sentire il suo ronzío per qualche attimo, poi fu solo un puntino contro l’azzurro intenso del cielo.
«Loro ci provano – disse Alberto con uno strano sorriso ammiccante – ma lo zio ha troppa voglia di raggiungere la sua isola…».
«E allora? – chiese Carla. – Dove andiamo adesso?».
«A Fiumicino… Lo zio arriverà lí, ne sono sicuro!».
Percorrevano l’autostrada che per qualche chilometro seguiva le anse del fiume in basso sulla sinistra. Ma da quell’altezza era impossibile distinguere alcunché nella corrente limacciosa dove la luce del giorno pieno accendeva riverberi verdastri. Carla ebbe una delle sue ispirazioni da sensitiva. Suggerí: «Ricordi quella domenica, da Bonaluce, quando lo zio volle invitarci a pranzo?».
«Già, è stato lo scorso giugno, in occasione del tuo compleanno. Proprio lí, a Fiumara Grande. Sí, ricordo. Fu un pranzo memorabile».
«Lo zio non faceva che parlare di barche, di punti nave, di arcipelaghi… Conosceva tutti i tipi di imbarcazioni, e ce le indicava tra quelle ancorate nella darsena del ristorante».
«Sí, lo zio arriverà lí, hai ragione. E noi lí lo aspetteremo».
Carla era illuminata da una certezza visionaria: «Sono sicura che verrà… Non ti sembra che tutte queste coincidenze, la cassa nel fiume, il fatto che abbia superato tutti gli ostacoli, la polizia, i pompieri, i piloni… Non credi che lo zio stia facendo di tutto per raggiungere il mare?».
Alberto annuí convinto: «È vero, con le tue sensazioni questa volta hai proprio ragione!».
Da Bonaluce avevano appena terminato il turno del pranzo e i camerieri stavano ripulendo la grande sala vetrata che si affacciava direttamente sul fiume. La corrente s’insinuava nei meandri della vasta foce con varie diramazioni che superata Fiumara Grande convergevano nella massa d’acqua marina ribollente di schiuma e vapori.
Si sedettero e ordinarono due insalate con formaggio. I camerieri li servirono osservandoli con sospetto. I due avventori chiesero se era possibile vedere la Tv. Fu acceso lo schermo del televisore e dopo qualche minuto di pubblicità venne il telegiornale regionale. La notizia della cassa finita nel Tevere fu data tra le scene di un corteo di protesta dei tassisti abusivi e una manifestazione di sfrattati a Piazza Venezia. Sullo schermo si videro passare in rapida sequenza i volti di un imbarazzato comandante dei carabinieri di Prima Porta e di un evasivo Cammarano dei Pompieri di Tor di Quinto. Entrambi, pressati dalle domande dei cronisti, abbozzarono vaghe giustificazioni per il mancato abbordaggio della cassa, prevedendo un quasi certo suo inabissamento prima di Fiumicino.

Fiumara Grande al tramonto
Ma di nuovo lo zio Ernesto sconfessò i due ufficiali: alle 17.17 la sua Barca di Ra, dopo aver lasciato la corrente maestra, bordeggiando dolcemente, venne ad accostare proprio in un boschetto di giunchi poco piú in basso del ristorante. Nessuno ci fece caso, ma i due strani clienti lasciarono il tavolo dove si erano insediati e raggiunsero l’insenatura dove la bara dondolava placida urtando la riva. Poi, nel cielo che stava già infiammandosi a ponente, l’elicottero si presentò con il suo fracasso e la sua presenza invadente. Eseguí diversi volteggi sulla Fiumara, si diresse verso il mare, poi ritornò. Aveva acceso dei fari sotto il ventre del velivolo e con quelle tangenti luminose perlustrava la darsena, sfiorando le antenne delle barche ormeggiate, increspando l’acqua dove si abbassava di piú. La bara era protetta dal fitto rameggio che si protendeva dalla riva. L’elicottero proseguì senza notarla, continuò ad esplorare, poi con una veloce virata si allontanò. Lo zio attendeva, cullato dallo stremo delle brevi onde. Aspettava il verdetto dei suoi cari nipoti. Stava a loro condannarlo alla fossa in eterno, al buio della terra putrida, oppure regalargli il sogno della sua vita: il mare aperto, la salsedine, il grido dei gabbiani, le focene, il periplo senza tempo né confini. Il tramonto era prossimo, dal mare poco lontano un chiarore dorato si rifletteva sull’acqua plumbea della Fiumara, l’accendeva di magici riverberi. Una brezza portò umori di cose disfatte e di cose acerbe. Era l’ora propizia per distaccarsi dalla terra, prima che la marea lo impedisse, prima che venisse il buio. Quattro mani si protesero dalla riva, accarezzarono il legno della bara, poi la spinsero verso il mare aperto.
Fulvio Di Lieto