
Hokusai «L’arte della scherma»
Fra le espressioni del Buddhismo mahayanico, lo Zen, che si può considerare la piú essenziale da un punto di vista metafisico, è peraltro quella che ha dato grande impulso alla cultura giapponese. Lo stile interiore proprio a quella ascesi si è fatto stile di vita e perciò costume eroico, come è evidente nell’arte della scherma, fiorita particolarmente nel periodo Kamakura: simultaneamente ha suscitato un modo peculiare di sentire esteticamente la natura e l’universo. Mirabili e grandiose figure di asceti si possono incontrare in quella parte della storia del Giappone in cui fluisce lo Zen: figure di una compiutezza umana e spirituale che, mentre sono maestri della meditazione, sono in pari tempo maestri di scherma e poeti o pittori o artigiani, di un tipo elevato: in sostanza, maestri di vita. Si ricordi, ad esempio, Miyamoto Musashi, del periodo Tokugava, fondatore della scuola detta Nitōryû, che fu non soltanto un possente schermitore, ma anche artista sumi-e e poeta.
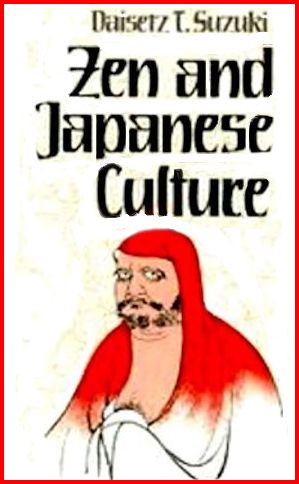 Un’opera orientatrice alla comprensione della cultura giapponese è Zen and Japanese Culture di D.T. Suzuki, seconda edizione riveduta e arricchita dell’opera pubblicata dall’Autore nel 1938 col titolo Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture. Degli insegnamenti dello Zen, Daisetz Teitaro Suzuki è da anni il piú chiaro e operoso espositore. Il valore della sua opera consiste soprattutto nella delicatezza e nell’arte con cui egli tratta un tema la cui sostanza è essenzialmente non dialettica, sovra-razionale, non concludibile in limiti intellettualistici. È evidente che Suzuki può parlare dello Zen nella misura in cui ne mantiene intatta la esigenza non-dialettica. Dello Zen, infatti, non si può essere interpreti se non a condizione di essere nello spirito stesso di dhyāna, ossia a condizione che l’esposizione stessa sia qualcosa come una continuazione dell’atto meditativo. Ed è questa l’impressione che si riceve ogni volta dalla lettura delle opere di Suzuki sullo Zen: egli può parlarne perché in sostanza lo sperimenta. Il suo non è soltanto un lavoro di erudizione, ma anzitutto di interna penetrazione del tema, in quanto egli lo vive.
Un’opera orientatrice alla comprensione della cultura giapponese è Zen and Japanese Culture di D.T. Suzuki, seconda edizione riveduta e arricchita dell’opera pubblicata dall’Autore nel 1938 col titolo Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture. Degli insegnamenti dello Zen, Daisetz Teitaro Suzuki è da anni il piú chiaro e operoso espositore. Il valore della sua opera consiste soprattutto nella delicatezza e nell’arte con cui egli tratta un tema la cui sostanza è essenzialmente non dialettica, sovra-razionale, non concludibile in limiti intellettualistici. È evidente che Suzuki può parlare dello Zen nella misura in cui ne mantiene intatta la esigenza non-dialettica. Dello Zen, infatti, non si può essere interpreti se non a condizione di essere nello spirito stesso di dhyāna, ossia a condizione che l’esposizione stessa sia qualcosa come una continuazione dell’atto meditativo. Ed è questa l’impressione che si riceve ogni volta dalla lettura delle opere di Suzuki sullo Zen: egli può parlarne perché in sostanza lo sperimenta. Il suo non è soltanto un lavoro di erudizione, ma anzitutto di interna penetrazione del tema, in quanto egli lo vive.
Un carattere peculiare dello Zen è il suo non trascurare la forma, anzi l’esigerla. Poiché l’atto meditativo è assolutamente informale, svolgendosi fuori delle categorie della natura, esso ha la potenza stessa delle forze che crearono la natura: ripercorre in modo genuino le vie per cui originariamente fu proiettata nelle forme una natura. Onde si può dire che il mondo luminoso del Ganda-vyūha si desta nella meditazione e tende a esprimersi nelle forme di un mondo nuovo: nuovo, però, perché è l’originario.
 D’onde diverse vesti espressive dello Zen: l’arte della spada e la tradizione Samurai, la pittura sumi-e e il poema tipo haiku, la cerimonia del tè e il senso della “trasparenza della natura” onde di continuo fiorisce uno stile detto sabi, o wabi, che non è uno stile, ma si afferma come tale: canone interiore che non si impara, ma sorge soltanto come il fiore stesso della pura meditazione, allorché si è capaci di contemplare l’universo come un grande kōan vivente e ci si rivolge alle cose quotidiane con la semplicità trascendentale che da simile contemplazione scaturisce.
D’onde diverse vesti espressive dello Zen: l’arte della spada e la tradizione Samurai, la pittura sumi-e e il poema tipo haiku, la cerimonia del tè e il senso della “trasparenza della natura” onde di continuo fiorisce uno stile detto sabi, o wabi, che non è uno stile, ma si afferma come tale: canone interiore che non si impara, ma sorge soltanto come il fiore stesso della pura meditazione, allorché si è capaci di contemplare l’universo come un grande kōan vivente e ci si rivolge alle cose quotidiane con la semplicità trascendentale che da simile contemplazione scaturisce.
Suzuki fa comprendere come il fluire della essenza dello Zen nella vita e il suo fiorire nella forma in quanto espressione di una purezza identica a quella originaria del creato, abbiano costituito non solo lo stile interno della cultura giapponese a partire dal XII secolo, ma anche una misura della concreta esperienza della meditazione, ad opera di una vasta famiglia di spiriti. Perché lo Zen – nota l’Autore – si rivolge non ai concetti ma agli atti, non al mondo delle astrazioni ma a quello del volere operante; che è, nella essenza, un volere incorporeo di continuo cercante corpo.
Un senso dell’incondizionato e una esigenza della libertà puramente metafisica sono il nucleo di una simile educazione, che si estrinseca nella forma come cultura superiore di quella vasta associazione umana che è un popolo. In effetto, nel Lankāvatara Sūtra si fa riferimento a un’attitudine essenziale che è la “verità della solitudine” (viviktadharma): la capacità di essere soli per essere veramente uni con l’universo, ossia per essere veramente presso gli esseri. La vicinanza quotidiana è illusoria. La vera vicinanza è interiore e passa attraverso la solitudine, attraverso l’esperienza del “vuoto”: è la continua istanza del satori. La mèta, di là dalla vita, è sempre dinanzi a colui che medita o pratica il nembutsu, perché la vita è veramente – come in Occidente intuisce Platone – contemplazione di un “ignoto” che è il vero essere, di un “invisibile” che diverrà visibile: il seme di una pianta, contemplato, è il simbolo dell’invisibile che diverrà visibile.
Secondo la pura tecnica del dhyāna, il pensiero che ancora non afferra se stesso fino ad estinguersi, è bensí alla presenza dell’ignoto, ma di un ignoto che è oggetto, vivente della vita stessa del soggetto, che è principio del conoscere, non è ancora vera conoscenza o saggezza (prajnā). L’ignoto, pertanto, anziché attestare con la sua presenza una realtà che trascende l’atto del meditare, è una conferma della impossibilità di giungere alla visione del Buddha o dei Bodhisattva trascendendo questo atto: per esempio, con una visione semplicemente religiosa, fideistica, dualistica.
L’ignoto c’è in quanto è di continuo il limite superato nella contemplazione. E questo è il segreto dello Zen: che l’“al di là” si attua nell’essere, in quanto è il fondamento dell’essere: quello a cui gli uomini per solito guardano con sgomento e che non è se non il rovescio del ricamo di cui s’intesse la vita: la mancanza o la negazione di ciò che si sente come la sostanza della vita. Ecco perché lo Zen non può essere concluso in un sistema, non può essere dispiegato in un’analisi: che sarebbe la sua distruzione. La “via” o lo “stile interiore” Zen, eliminando ogni condizione preliminare della contemplazione, in quanto il satori è la possibilità eternamente presente, e identificando lo stato di tathāgata con lo stesso atto della contemplazione, fonda la realtà dell’essere nel vivo di questo atto, in un’attitudine identica a quella dello Spirito che è in procinto di creare: cosí gli restituisce sempre quella libertà metafisica che ogni formulazione intellettualistica, anche all’interno della corrente dello Zen, lungo il tempo e lungo l’avvicendarsi storico degli insegnamenti, tende naturalmente a sottrargli, col renderla oggetto, cosa, immagine.
 L’asceta – secondo l’insegnamento di Hui-neng – nell’atto autentico della conoscenza non è piú uno specchio della verità, un intelletto determinato dalle cose o dalle idee, o dai loro rapporti, ma è centro stesso della creazione. Egli stesso è principio di creazione. Volgendosi allora di nuovo all’esistenza, alla natura, alle cose, alle relazioni umane, egli, fondato nell’in-azione, opera come se lo stesso tathāgata operasse nel mondo. Il canone sabi – che non è in sostanza canone, ma interna tonalità – ha radici in questa esperienza trascendente: la semplicità e la freschezza che esso comporta non sono norme o modalità, ma sorgono da una spontaneità metafisica, che deriva da un continuo svincolamento dalle condizioni.
L’asceta – secondo l’insegnamento di Hui-neng – nell’atto autentico della conoscenza non è piú uno specchio della verità, un intelletto determinato dalle cose o dalle idee, o dai loro rapporti, ma è centro stesso della creazione. Egli stesso è principio di creazione. Volgendosi allora di nuovo all’esistenza, alla natura, alle cose, alle relazioni umane, egli, fondato nell’in-azione, opera come se lo stesso tathāgata operasse nel mondo. Il canone sabi – che non è in sostanza canone, ma interna tonalità – ha radici in questa esperienza trascendente: la semplicità e la freschezza che esso comporta non sono norme o modalità, ma sorgono da una spontaneità metafisica, che deriva da un continuo svincolamento dalle condizioni.
Assorbito nel fondamento, estinto alle categorie umane e perciò sorgente in sé per la misteriosa essenza che è fonte di ogni categoria, l’asceta si muove nel mondo, facendo risorgere il mondo in una relazione che egli ogni volta suscita, dandole forma, perché inesauribile nella sua creatività. Tutto ciò che lo lega al mondo sedimenta nel profondo della sua natura: egli, liberando la sua natura, è libero a sua volta dalla natura, cosí che essa, purificata, ritorna ad essere per lui aiutatrice, sollecitatrice. Riposando nel profondo di sé e attingendo in sé la forza della quiete originaria, inesauribile dinanzi ai traumi dell’esistenza, egli può continuare l’opera della natura, in ogni piano della vita quasi ripercorrendo il processo della creazione. «There is in every one of us – scrive l’Autore – a desire to return to a simpler form of living, which includes simpler ways of expressing feelings and also of acquiring knowledge. The so-called “way of the Gods” points to it. Although I do not know exactly what signification the advocates of Kaminagara no michi want to give to this term, it seems to be certain to my mind that by this they wish to mean going back to or retaining or reviving the way in which the Gods are supposed to have lived before the arrival of humankind. This way was one of freedom, naturalness and spontaneity. How did we go astray from this? Here lies a great fundamental religious problem. Its solution gives the key to understanding some aspects of Zen Buddhism and of the Japanese love of Nature». Ma è indubbio che la spontaneità originaria, che era possibile in quanto non si dava l’impedimento di una coscienza raziocinante, non possa risorgere se non a condizione che si estingua una tale coscienza, ma al tempo stesso se ne mantenga intatta la luce, o autonomia, che si è accesa appunto grazie al processo raziocinante. Se appunto un processo logico, nella prima fase della formazione spirituale, non è quello che media l’accostamento del discepolo allo Zen, come egli può farne la scelta, come può cominciare a intenderne l’insegnamento? Come dice Shrî Aurobindo, il pensiero è da prima l’aiuto, poi diviene l’impedimento: ma è l’impedimento a un elemento spirituale puro che si è acceso appunto grazie al pensiero.
Questi ed altri problemi pone l’opera di Suzuki. In definitiva egli, esaminando l’influenza dello Zen sull’anima nipponica, ha approfondito il tema della concretezza dello Zen: esperienza interiore che opera alle radici del “reale” come forza causante e che perciò, se veramente è, non può non manifestarsi come modo di vita, come forma dello Spirito. L’analisi è condotta con quel limpido ordine dei temi, che viene da una conoscenza personale dei loro nessi ideali.
Massimo Scaligero
Tratto dalla rivista «Giappone» N° 1 ‒ gennaio 1961
