 Un tempo possedevo un portasapone azzurro. A dire il vero, proprio azzurro non era, dava piuttosto sul celestino un po’ lattiginoso, quasi sbiadito. Immancabilmente mia madre lo introduceva nello zainetto, nella sacca, o lo riponeva a mia insaputa nella valigetta, a seconda delle gite extrascolastiche (in genere piccole trasferte che l’Opera Nazionale Degli Orfani Di Guerra effettuava in località della Regione, avvalendosi di pullman antidiluviani o camion militari ancora malconci del conflitto appena spento) alle quali, ragazzino imberbe, ero costretto a partecipare.
Un tempo possedevo un portasapone azzurro. A dire il vero, proprio azzurro non era, dava piuttosto sul celestino un po’ lattiginoso, quasi sbiadito. Immancabilmente mia madre lo introduceva nello zainetto, nella sacca, o lo riponeva a mia insaputa nella valigetta, a seconda delle gite extrascolastiche (in genere piccole trasferte che l’Opera Nazionale Degli Orfani Di Guerra effettuava in località della Regione, avvalendosi di pullman antidiluviani o camion militari ancora malconci del conflitto appena spento) alle quali, ragazzino imberbe, ero costretto a partecipare.
L’idea di andare in giro per il mondo con un portasapone, oggi, fa sorridere. Qualsiasi motel, B & B o alberguccio di modesta categoria ha tra gli accessori da bagno una saponetta, una schiuma, un liquido detergente; non si capisce perché uno dovrebbe portarsi dietro un sapone rinchiuso nel suo astuccio. Ma quella volta era cosí, l’intima igiene richiedeva uno sforzo personalizzato.
Piú o meno si sa come è fatto un portasapone; una scatoletta di plastica (allora si usava il prototipo, la bachelite) di circa 12x6x4 cm., chiusa da un coperchio che aderisce per attrito, con dentro una saponetta, o spesso i resti di quel che era stata una saponetta; nel caso mio si trattava sempre di una scaglia umidiccia che navigava in mezzo dito di acqua viscida e profumosa. Se per caso aprivi in modo maldestro il coperchietto, il contenuto liquido, sapone compreso, schizzava da tutte le parti.
Credo di aver trascorso una parte della mia infanzia recuperando saponi dispersi in bagni sconosciuti.
Ho estratto dall’archivio della memoria questo portasapone celestino per il fatto che esso è, ai fini della mia emotività, abbastanza neutrale; posso richiamarlo alla mente senza aggiungerci alcun sentimento, come invece normalmente succede con i ricordi in genere. Non dico di rimanere del tutto indifferente di fronte a questo oggetto, specie se lo lego a dettagli del passato; ma ho la convinzione che, se per decisione presa dovessi frugare tra gli accessori posseduti, questo portasapone sarebbe sicuramente l’oggetto meno suscitatore di fantasie (e quindi anche di emozioni) che abbia mai avuto.
Nessun maestro di scuola ha dato per compito “Parlami del tuo portasapone”; ma se ce ne fosse stato uno cosí spregiudicato ad impormelo, ci sarei rimasto male, e dopo aver sbuffato a lungo, avrei consegnato un temino di sí e no mezza paginetta.
Nulla spegne l’entusiasmo quanto mettersi a scrivere di un oggetto dismesso, anche se, tutto sommato, la sua utilità non è in discussione. Ma è un po’ come per la carta assorbente o per le pastiglie contro la tosse; servono, si cercano in caso di bisogno, si usano, e la cosa finisce lí.
Le riflessioni esposte hanno un carattere di perentorietà; si prevede, a rigor di logica comune, che dopo il parto mentale null’altro resti da dire. Di conseguenza, si prova un vago senso di ‘sconsapevolezza’ che sorge sempre quando si è convinti di aver fatto tutto ciò che c’era da fare. senza però provare una minima soddisfazione corrispondente. Con tale situazione si finisce per conviverci, e, come nel caso della propria ombra, da un certo punto in poi, si cessa pure di accorgersi che c’è.
Se il ricordo di una cosa esistita in passato, con la quale abbiamo avuto un rapporto diretto, non evoca in noi il minimo interesse, allora sembra lecito affermare che nulla al mondo può conferirglielo.
Fino a pochi anni fa, sostenevo quanto sopra a spada tratta; oggi non piú. Sia pure lentamente, ho maturato un’esperienza che mi ha portato dritto dritto a tutt’altra conclusione: quella opposta.
Tra i due stati di coscienza (l’antico e il nuovo) c’è di mezzo l’esercizio della Concentrazione. È l’esercizio che può cambiare radicalmente le cose, fino a sovvertire la scaletta delle priorità e dell’ordine di importanza secondo cui le abbiamo distribuite e classificate.
L’effimero, l’inutile, il non appariscente, il “dettaglio insignificante”, tutto ciò che abbiamo bollato come trascurabile, una volta recuperato quale oggetto di concentrazione, assume veste regale. Colto ed elaborato da un nostro pensare volente, trova la sua potenza di “convertitore delle forze”, trasformando il micro-tone in mega-tone, a un livello cui ovviamente la ragione astratta e l’esperienza dei sensi non hanno accesso.
Poco sopra, ho scritto che se una cosa è inerte, priva di potere, azzerata nel valore, “nulla al mondo” potrà concederglielo. È vero: ma per l’appunto è il nulla del mondo: di questo mondo.
Oltre questo ne esiste un altro; è verso tale secondo mondo, o dimensione, che ci dirigiamo ogni volta che ci mettiamo nelle condizioni di svolgere un esercizio interiore. Sappiamo tutti che tali condizioni sospendono, sia pure per breve tempo, il frastuono del mondo, le lusinghe del mondo e la logica del mondo. Quindi, di conseguenza, anche le unità di misura imposte dal mondo.
L’ascesi del pensiero richiede la conversione contemplabile di tutte le concezioni attraverso le quali abbiamo accolto quella realtà che, forse in un eccesso di entusiasmo, abbiamo voluto chiamare oggettiva.
 In effetti essa lo è nella misura in cui ci rendiamo conto della sua appartenenza agli oggetti, non a noi. A noi spetta il compito di oltrepassare il limite e di integrare l’oggetto di quel che gli manca, come segno o simbolo di uno sviluppo incompiuto, richiedente al pensiero umano un ulteriore intervento che lo richiami in vita dallo stato di morte latente in cui era immerso. E lo era proprio per poter apparire ai nostri sensi con l’inerzia dell’oggetto e non altro.
In effetti essa lo è nella misura in cui ci rendiamo conto della sua appartenenza agli oggetti, non a noi. A noi spetta il compito di oltrepassare il limite e di integrare l’oggetto di quel che gli manca, come segno o simbolo di uno sviluppo incompiuto, richiedente al pensiero umano un ulteriore intervento che lo richiami in vita dallo stato di morte latente in cui era immerso. E lo era proprio per poter apparire ai nostri sensi con l’inerzia dell’oggetto e non altro.
Anche un portasapone azzurro, sparito chissà dove, può risorgere; ne ha il diritto, ove in quanto uomo, io trovi il dovere di farlo risorgere nel mio pensare.
La Resurrezione non è soltanto un evento delle anime e dei corpi, secondo la liturgia narrata dalle tradizioni religiose; la resurrezione è un’azione liberatoria che indica il passaggio dall’era dei vincoli a quella in cui essi decadono per cessata funzione. L’intuizione della resurrezione avviene in conseguenza del superamento del limite della coscienza riflessa, dialettico-egoica.
Non esiste resurrezione piú grande e piú bella di quella che ogni uomo può coscientemente attuare col suo volere all’interno del pensiero: in tal modo il pensiero liberato porta in sé il principio vitale eterico per cui, nel suo scorrere senza limiti, accende di forza intrinseca la coscienza che gli ha offerto la propria disponibilità.
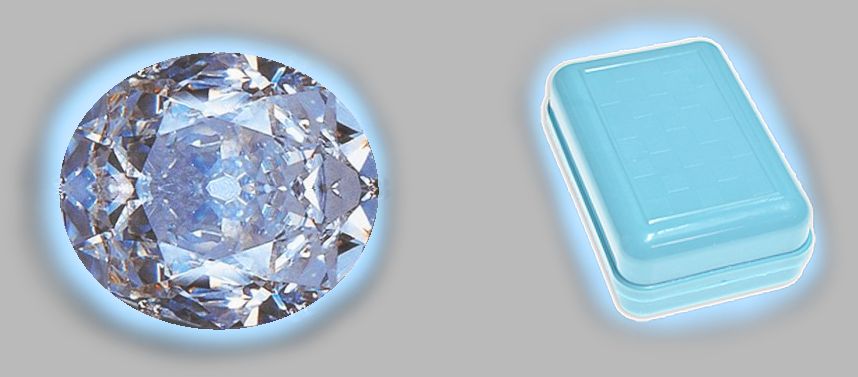 Contemporaneamente, l’oggetto dal quale si era partiti per iniziare la concentrazione si dissolve come oggetto; che prima, nel mondo, sia stato il diamante Koh-i-Noor o un povero portasapone azzurro, la cosa è perfettamente identica; la forza-pensiero racchiusa nell’oggetto (perché qualunque sia, prima di esistere, ha dovuto venir pensato) emerge dalle spoglie della dialettica che l’avevano fin qui rivestito e di sé rivela ora l’identità luminosa, in una con il pensiero che lo ha tolto dalla tomba della fisicità, là dove la vita si riduce alla sola percettibilità animico-sensibile.
Contemporaneamente, l’oggetto dal quale si era partiti per iniziare la concentrazione si dissolve come oggetto; che prima, nel mondo, sia stato il diamante Koh-i-Noor o un povero portasapone azzurro, la cosa è perfettamente identica; la forza-pensiero racchiusa nell’oggetto (perché qualunque sia, prima di esistere, ha dovuto venir pensato) emerge dalle spoglie della dialettica che l’avevano fin qui rivestito e di sé rivela ora l’identità luminosa, in una con il pensiero che lo ha tolto dalla tomba della fisicità, là dove la vita si riduce alla sola percettibilità animico-sensibile.
Anche parlando col senno del poi, dato che è impossibile argomentare su un avvenimento dell’anima senza il crescendo interiore da cui si è sviluppato, e quindi avanzando tutte le riserve del caso, resta pur sempre un fatto formidabile poter concettualizzare un’esperienza di questa portata: il pensiero umano, il mio pensiero, tanto per essere precisi, mi si rivela identico in forma e sostanza (i due termini non sono appropriati, ma spero lascino capire) al pensiero che stava nascosto dentro una percezione qualunque (spillo, ago, portasapone)!
Nel momento in cui questo accade, io non sono piú il solito “io-me”, un mucchio di ossa e visceri rinchiuso in un sacco di pelle, portatore di un’anima che amerebbe sentirsi effusa nell’universo ed è già tanto se – qualche volta, nelle grandi occasioni – riesce a staccarsi dalla stolidità collosa dell’ego, per compiere un breve svolazzo, tipico dei gallinacei da cortile.
 Il mio centro istintivo-sensibile-razionale sparisce, come è sparito l’oggetto dell’esercizio una volta scioltosi dai connotati che, per l’appunto, l’avevano fin qui tenuto assieme come oggetto. Ora la coscienza vive una nuova centralità, intuitiva, intima, fluente ed espansa nella sua massima potenzialità, in grado di darmi una nuova consapevolezza: sentirmi tutt’uno con l’asse attorno al quale, sulla volta della Terra, ruota il Sistema Planetario e l’Universo Sconosciuto.
Il mio centro istintivo-sensibile-razionale sparisce, come è sparito l’oggetto dell’esercizio una volta scioltosi dai connotati che, per l’appunto, l’avevano fin qui tenuto assieme come oggetto. Ora la coscienza vive una nuova centralità, intuitiva, intima, fluente ed espansa nella sua massima potenzialità, in grado di darmi una nuova consapevolezza: sentirmi tutt’uno con l’asse attorno al quale, sulla volta della Terra, ruota il Sistema Planetario e l’Universo Sconosciuto.
S’invera quanto scolpito dalla terza parte di un noto mantra antroposofico: «Cosí ritrovo il mondo in me e mi riconosco nel divenire del mondo».
Si può dire: io sono (in) quel centro attorno al quale converge ogni centralità; fintanto che la coscienza non vive questo suo momento, ogni altro riferimento è puramente provvisorio, immagine astratta, illusoria in quanto irreale.
Ho posto tra parentesi la preposizione “in” per una precisa ragione, difficile da spiegare perché estremamente delicata e pertanto fragilissima di fronte alla vis dialettica che tuttavia sono costretto ad usare per darne conto.
In effetti quell’ “in” può venir tolto: l’identità di cui parlo non sarebbe perfetta se rappresentata da una separazione tra lo sperimentatore e il locus in cui la sperimentazione si realizza. Ci sarebbe una ulteriore distanza da colmare, e in tal caso l’identità non si darebbe per compiuta.
Quando mai il portasapone azzurro in tutta la sua esistenza avrebbe potuto immaginare di essere la chiave che apre la porta su un nuovo universo? Mi viene da pensare cosí, quasi per riaccreditarmi presso la sua verità, avendolo io snobbato per cosí lungo tempo.
Ma comprendo bene che il senso dell’operazione è avvenuto tutto nel pensare, là dove il sottoscritto e il portasapone contano allo stesso modo, entrambi essendo, a diverso livello, frutto di un Pensiero Universale che da una parte ha voluto sperimentarsi in qualità di coscienza umana capace di ritornare alla sua scaturigine spirituale, concentrandosi sulla consistente inconsistenza di un oggetto abituale e inespressivo, dall’altra immobilizzandosi nell’artificiosità di una materia inventata dall’ingegno umano, cresciuto sulla scorta di infinite esperienze sensibili precedenti.
Il portasapone non ha mai immaginato nulla; è solo un portasapone, e non gli si può attribuire facoltà magiche che non siano strettamente collegate al suo esclusivo apparire fisico. Ma con l’uomo le cose stanno diversamente. Può andare oltre tutto quello che egli crede (o che gli vien fatto credere) essere un suo limite, anche se a volte ci vuole un’eternità per maturare e assimilare una convinzione di questa portata.
Con la mia vista riesco a vedere bene fino a duecento metri; l’amico Ninetto invece riesce a vedere nitidamente fino a duecentoventi metri. Risultato? Viviamo in due realtà che si possono considerare differenti; la sua è piú ampia della mia, e viceversa, quella mia è contenuta nella sua.
Ma sono per davvero due realtà diverse? Assolutamente no. La realtà visiva è una sola, ma ciò non toglie che quelli che ci vivono dentro vedono a seconda delle loro potenzialità ottiche, per cui per alcuni c’è solo il mondo fisico (quello che si vede fino a duecento metri), per altri la visione si allarga anche su ciò che i primi non possono vedere.
Da questo deriva una strana tendenza: considerare il mondo della fisicità sensoria e il mondo metafisico simili a due globi separati, tutt’al piú vicini, contigui, al massimo tangenti. Mentre la realtà diventa completa solo quando alla percezione si integra l’attività pensante, diretta da una coscienza che ha avuto il modo di conoscere bene l’utilità e le insidie del corpo, la virtuosità dell’ascesi nonché le cadute rovinose dell’anima.
Allora, forse, la nostra visione avrà quella completezza che normalmente si sgretola nel firmamento delle percezioni sensibili. L’Essenza porta sempre all’unità, il molteplice sta alla base dell’Esistenza. Se tra esse appare la delimitazione, ciò non è dovuto a una interruzione oggettiva di rapporto, ma alla nostra organizzazione, frastagliata e personale, che non ha ancora scelto se dirigersi verso l’una o disperdersi dentro l’altra.
È facile ricavare dalle percezioni il senso della separazione e del limite, per questo basta il pensiero ordinario. Molto piú complicato è invece accogliere in visione sinottico-integrativa un’unica realtà metafisica, la quale – ma solo per nostra provvisoria incompletezza – sul piano fisico si sdoppia: la prima essendo alla portata di chiunque, l’altra di chi la cerca e la vuole. La seconda possibilità si concede esclusivamente a un pensare coltivato secondo modalità particolari e il piú possibile disciolto dal legame attrattivo dei sensi.
Il portasapone azzurro, cessato il compito per cui è stato inventato, potrà confinarsi tra le cianfrusaglie senza che alcuna lacrima venga versata: fa parte della logica che riserviamo agli oggetti, per cui s’instaura quasi automaticamente l’ordine d’importanza in base al quale abbiamo fatto le nostre valutazioni sull’oggetto.
Ma da dove salta fuori questo O.d.I. (Ordine d’Importanza)? Dal pensiero? Dalla pura oggettività? Se cosí fosse, la scaletta sarebbe universale; ognuno darebbe alle cose il medesimo grado d’importanza.
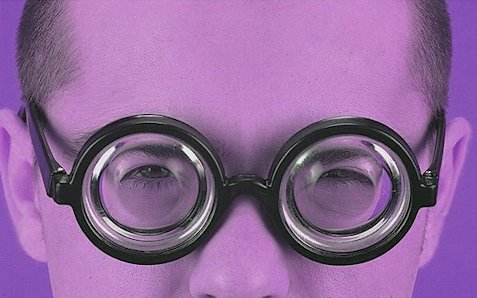 È evidente che qui entra in ballo la coscienza, coscienza pensante senza dubbio, e quindi portata a giudicare secondo “scienza ed esperienza”. Vale per essa quel che poco fa è stato detto sulla vista. Possiamo fare subito un distinguo. Chi ha maturato il convincimento che la Scienza dello Spirito sia una scienza vera e propria, la quale può figurare benissimo tra le varie scienze ufficialmente riconosciute, avrà un campo di valutazione aperto fino a duecentoventi metri, come Ninetto. Chi invece non ci riesce perché è un po’ “talpino”, dovrà accontentarsi di una visione riduttiva; non di molto, ma di quanto basta per ricavare un panorama nettamente inferiore.
È evidente che qui entra in ballo la coscienza, coscienza pensante senza dubbio, e quindi portata a giudicare secondo “scienza ed esperienza”. Vale per essa quel che poco fa è stato detto sulla vista. Possiamo fare subito un distinguo. Chi ha maturato il convincimento che la Scienza dello Spirito sia una scienza vera e propria, la quale può figurare benissimo tra le varie scienze ufficialmente riconosciute, avrà un campo di valutazione aperto fino a duecentoventi metri, come Ninetto. Chi invece non ci riesce perché è un po’ “talpino”, dovrà accontentarsi di una visione riduttiva; non di molto, ma di quanto basta per ricavare un panorama nettamente inferiore.
I guai cominciano quando chi vede meno non lo sa e pretende che la sua visuale sia quella esatta.
Rudolf Steiner insegna che vi sono quattro gradi conoscitivi con i quali la coscienza cresce e si sviluppa: quello materiale, quello immaginativo, poi successivamente, quello ispirativo e per finire quello intuitivo. Fintanto che essa resta nell’ambito della conoscenza materiale e immaginativa, la vita non cambia; non accade nulla di particolare in fatto di attività interiore atta a risvegliare le forze dell’anima; tutt’al piú il soggetto sarà caratterizzato da una feconda produzione immaginativa, la quale, però, senza un orientamento preciso e composto della Centrale Comandi, degenera in fantasticheria, il che non è assolutamente utile a uno sviluppo in senso evolutivo.
Giunto a questo traguardo etico-psichico, sarei di certo capace di esprimere l’abilità artistica, saprei perfino comporre delle poesie sul portasapone azzurro, decantando la modestia della sua utilità, il formato bellamente ergonomico o il colore da fiorellino delicato azzurrognolo. Ma come si può capire entreremmo nel patologico.
Solo con l’avvento della conoscenza ispirativa possiamo veramente dire di passare il consueto limite. Al di qua rimane l’ordinaria visione del mondo fisico-sensibile e delle molteplici percezioni che lo compongono. Oltre non è possibile parlarne, proprio perché viene compiuta un’integrazione coinvolgente i livelli esperiti, talmente vasta da sovvertire tutte le precedenti acquisizioni conoscitive; non le annienta (è importante rilevarlo!) bensí le amplifica, le sviluppa, penetrandole in profondità, portando lo sperimentatore a cogliere aspetti luminosi in ciascuna intrinseca percezione, che prima non potevano essere minimamente sospettati.
A chi appartengono questi “aspetti luminosi”? Cosa sono? Non appartengono esclusivamente al pensiero che, pensando, li percepisce. E nemmeno sono emanazioni della percezione-oggetto cui si sta pensando. Sono invece il risultato dell’azione volitiva di una coscienza umana (e pensante) che realizza la sintesi: essa avviene combinando tra loro due diverse potenzialità: da una parte il pensiero che ha deciso di compenetrare il dato percettivo, dall’altra l’entità-pensiero reclusasi nell’oggettivazione fisico-minerale, in attesa di una eventuale liberazione dall’incantesimo della materia.
 Il termine “aspetti luminosi” può sembrare inadatto, forse risibile, ricordando che siamo partiti da un portasapone azzurro, ma nel dire “aspetti luminosi” voglio riferirmi al conseguimento di un atto conoscitivo, e qui la luce c’è sempre. Ci siamo perfino abituati, fin da piccoli, quando leggevamo i fumetti, a vedere una lampadina lampeggiare sulla testa di chi aveva un’idea. Ci si dovrebbe stupire se anche in una ricerca indirizzata allo Spirito, l’elemento intuitivo-conoscitivo si manifesta con un irraggiare luminoso?
Il termine “aspetti luminosi” può sembrare inadatto, forse risibile, ricordando che siamo partiti da un portasapone azzurro, ma nel dire “aspetti luminosi” voglio riferirmi al conseguimento di un atto conoscitivo, e qui la luce c’è sempre. Ci siamo perfino abituati, fin da piccoli, quando leggevamo i fumetti, a vedere una lampadina lampeggiare sulla testa di chi aveva un’idea. Ci si dovrebbe stupire se anche in una ricerca indirizzata allo Spirito, l’elemento intuitivo-conoscitivo si manifesta con un irraggiare luminoso?
Per dare una migliore completezza alla disamina, torniamo a quanto è stato detto circa la natura dell’atto, o dell’azione, di conoscenza. Nell’impatto con il mondo, e con tutto ciò che lo compone, il nostro pensiero in definitiva non scopre mai niente; ove creda di farlo, trova sempre e solo se stesso in altre vesti, tuttavia a un livello non ordinario, non immediatamente riconoscibile. Quindi per arrivare a cogliere la sintesi col mondo, questo pensare deve rinforzarsi, deve sollevarsi dalla soggezione alle forze che normalmente lo paralizzano, attraverso l’incantamento dell’anima, alle categorie sensibili; per farlo, non c’è nulla di meglio che esercitarlo con gli esercizi basilari della Scienza dello Spirito, cosí come li concepí Rudolf Steiner piú di un secolo fa.
In particolare l’esercizio della concentrazione attua perfettamente la possibilità descritta dalla prima delle Massime Antroposofiche, là dove lo stesso Maestro esplicita: «L’Antroposofia è una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell’uomo allo spirituale che è nell’universo». Mi sembra che piú chiaro di cosí non poteva essere.
Tutto dipenderà però dalla verifica di alcune premesse:
- riconoscerà l’uomo che c’è una vita spirituale nel cosmo?
- riconoscerà l’uomo che c’è una pari vita spirituale in lui?
- concepirà l’idea (e l’impresa) che forse sarebbe il caso di cercare un collegamento tra questi due centri?
- potrà arrivare fino al punto d’intuire che il suo esistere nel mondo fisico gli è dato per questo preciso fine?
Nulla rispondendosi ad uno degli interrogativi, nulla accadrà d’importante: il portasapone azzurro finirà prima o poi nella spazzatura, assieme a oggetti, ricordi, affetti, emozioni, proposte, obiettivi e molte altre cose omesse, trascurate, vilipese e abbandonate. Del resto, il collettivo umano pare abbia cose ben piú importanti da fare che occuparsi delle inezie.
Deve affrontare la Grande Corsa per la conquista dello Spazio, anche se per ora mancano mezzi adeguati. Ma l’uomo lo farà con lo stesso indomabile slancio che caratterizzò un tempo i pionieri d’America, nella loro epica corsa verso l’oro del fiume Sacramento, sempreché non troviamo il modo di autodistruggerci prima. Qui, già oggi, i mezzi bastano e avanzano.
 Peccato che cosí facendo la nostra terra si riempirà di portasaponi azzurri sparsi per tutti gli immondezzai e le macerie del pianeta. Forse questa è la ragione per cui proviamo il bisogno di conquistare nuovi mondi: il mondo che abbiamo, invaso da rifiuti e detriti, non è piú sufficiente.
Peccato che cosí facendo la nostra terra si riempirà di portasaponi azzurri sparsi per tutti gli immondezzai e le macerie del pianeta. Forse questa è la ragione per cui proviamo il bisogno di conquistare nuovi mondi: il mondo che abbiamo, invaso da rifiuti e detriti, non è piú sufficiente.
L’unica salvezza in cui possiamo confidare sta nel pensiero che ancora pensi, che abbia voglia di capire, di indagare, di conoscere: non ai fini di conquistare un potere che lo metta in grado di soggiogare popoli, terre e pianeti, ma solo per provare l’intima sublime gioia di esercitare un pensare pulito, terso, capace di essere il punto di riferimento per ogni anelito dell’anima ed esigenza del corpo.
Un tale pensiero funziona anche se viene impiegato verso cose di basso profilo, verso l’oggetto meno significativo e piú trascurabile, come un vecchio portasapone azzurro. Non occorre neppure richiamare a sé l’importanza inevitabile degli esercizi interiori. Basta iniziare dal proprio silenzio e porre, in un attimo di autoisolamento, l’attenzione vigile per una parola, per un suono, un simbolo che riassumano tutto l’insieme degli oggetti dismessi, e reputati inutili: i “rifiuti”.
Con una piccola ricerca etimologica si viene a scoprire una cosa interessante: “rifiuto” viene dal verbo rifiutare, il quale non significa affatto ciò che in un primo momento siamo indotti superficialmente a credere, secondo la sonanza letterale, ossia “fiutare nuovamente”. Il naso non c’entra per nulla, ma tuttavia, facendo il ficcanaso filologico, troviamo che il rifiuto deriva dal latino “refluctum” (verbo: refluo); indica il movimento di una corrente, la quale inverte la propria rotta e quindi torna indietro. Vedi ad esempio il reflusso delle onde del mare sulla spiaggia.
Tra i significati di fiutare di nuovo e invertire la direzione di marcia passa una bella differenza; ma nell’uso comune della parola “rifiuto” non sono evidentemente andato oltre l’immediata interpretazione, a me almeno è accaduto cosí, e in questa trappola, per quanto superficiale e riconoscibile, ci sono rimasto. A lungo infatti mi chiedevo cosa c’entrasse l’odorato con l’atto di ricusa che è altrettanto un’espressione di rifiuto.
Quando se ne esce, grazie al pensare un po’ piú desto del solito, ci si accorge che l’ordine delle cose non è piú quello di prima; perfino i rifiuti non rappresentano solo la spazzatura, o la negazione, ma ci possono aiutare a capire che dal punto di vista evolutivo abbiamo invertito la rotta e, complice una coscienza piú indotta alla raccolta differenziata che non alla differenziazione del raccolto, stiamo tornando indietro: stiamo letteralmente regredendo.
Tuttavia cosí come il pensiero, in un attimo di affrancamento dal fardello esistenziale che normalmente lo affligge, riesce a intuire la confusione nell’uso improprio di un verbo e del suo participio, altrettanto bene saprà indicarci la via interiore necessaria per riportarlo al livello in cui esprimere degnamente se stesso, attingendo alla propria sorgente. Che è la via della Scienza dello Spirito, o dell’Antroposofia.
Questo pensiero deve quindi venir allenato da una coscienza volente e perseverante; capace, sia pure in assenza di riferimenti sensibili, nozionismi preconcetti e vademecum indicativi (spesso anche contro il groviglio dei razionalismi che pretenderebbero di governare il mondo) di trovare in se stesso il giusto orientamento nonché la direzione verso cui involarsi.
Angelo Lombroni

