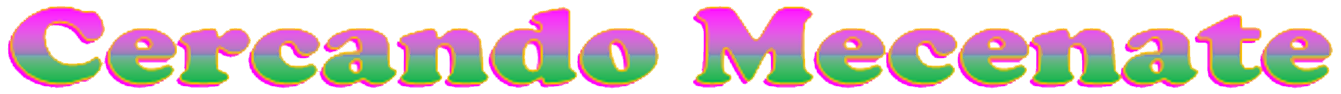L’Impero romano, una realtà geopolitica universale, ebbe al suo picco di eccellenza un sovrano, Augusto; un poeta, Virgilio; un filosofo, Seneca; un generale, Marco Agrippa; un uomo di Stato, Mecenate.

Stefan Bakałowicz «Il circolo di Mecenate»
Questi, lucumone etrusco, abile diplomatico, ricco di suo, avendo Roma degnamente soppiantato gli antichi mentori e maestri della dodecapoli dei Tirreni, era convinto che l’Urbe fosse il luogo migliore in cui un uomo degno di tale nome potesse vivere e operare per lo sviluppo di un progetto politico di largo respiro, a supporto del disegno ambizioso di Augusto di riportare Roma al rispetto dello Stato e della religione. In tale spirito, Mecenate aveva creato un thinktank di illustri personalità, la crème de la crème in ogni campo, dalla politica alla medicina, dalla scienza alla letteratura. Il salotto è passato alla storia come Circolo di Mecenate. Oltre ai citati, frequentarono l’illustre cenacolo intellettuale Ovidio, Orazio, Properzio e Tito Livio. Nella realtà topografica del presente, possiamo localizzare il circolo tra piazza Leopardi e il teatro Brancaccio, definiti Horti di Mecenate. Ciascuno dei frequentatori del Circolo aveva un solo scopo: celebrare Augusto e il suo progetto di recuperare gli antichi valori morali della società quirite, guastati da troppi anni di lotte civili, dalle pratiche abortive e dall’antigeneticismo, dal lassismo nelle famiglie e nella pubblica amministrazione. Mecenate fu il grande concertatore dei plauditores dell’Impero di Ottaviano: Orazio compose il Carmen saecularis, Virgilio l’Eneide, Tito Livio in centoquarantadue libri di storia, ab Urbe condita, esaltò il cives romanus, facendone un vir, un eroe di virtus e fides, assiduo praticante della humanitas.
Quello di idealizzare il tipo nazionale fino all’apologia, se non fino all’idolatria, è un vezzo antico quanto il mondo. Il modello di casa, per quanto imperfetto – e il cives romanus per tanti aspetti lo era – fa aggio su ogni altro tipo umano disponibile, avendo alle spalle, nello specifico, i trofei dell’impero piú vasto del mondo di allora, e tra i piú grandi dei tanti imperi e regni mai conquistati da un popolo. Essere romano significava realizzare un modello umano di eccellenza, il che serviva a giustificare le pretese, per l’Urbe e per i suoi cittadini, di godere della divina investitura di ammaestrare i popoli, di difendere i deboli e punire i superbi. Perciò ogni Romano era fiero di appartenere a una simile città. Tale fierezza è giunta a noi per via saprofitica e forza di inerzia storica. Quando passiamo ai Fori e vediamo i resti della grandezza romana, ce ne gloriamo e giochiamo la carta dell’illustre ascendenza come atout vincente nella partita giocata al tavolo delle nazioni che oggi danno le carte della civiltà dei numeri, delle quote, degli indici, dei profitti. Ma i nostri rilanci hanno del patetico. Nella tragedia del Ponte Morandi, all’infame vignetta del corrosivo settimanale “Charlie Hebdo”, che mostrava i tronconi del cervellotico manufatto crollato, guarnito della didascalia: «Questo lo hanno fatto gli italiani», non abbiamo saputo, e potuto, replicare che mostrando i resti del Ponte del Gard, in Francia, e dell’Acquedotto di Segovia in Spagna, essendo troppo abusati visivamente gli archi di acquedotti e ponti viari che costeggiano la via Appia, immortalati e sviliti da troppi film corrivi e oltraggiose invadenze. Portavano a Roma l’acqua dai Simbruini, e da ogni dove i sudditi dell’Impero. Che affluivano a Roma certi di trovarvi la propria religione e i propri Dei celebrati in templi e santuari, di parlare la propria lingua ed essere capiti, di portarvi le proprie idee e trovare ascolto e consensi.
Gli apolidi redattori di Charlie Hebdo non hanno argomenti per negare la grandezza di quei ruderi e di tanti altri che segnalano la presenza del Senato e del Popolo di Roma dalla Lusitania al Ponto, dalla Caledonia alla Cirenaica. Ma noi, ritenendoci di quella stoffa, commettiamo un abuso. Il modello quirite non si attaglia ormai piú a un popolo che ha saltato il fosso del pomerio di Romolo, finendo nel selvaggio West, tra le urla dei nativi Sioux e i muggiti delle mandrie di bufali in libertà.
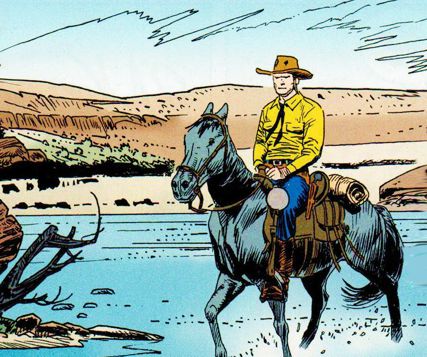 Il profilo dell’Italiano DOC, ovvero dell’Arcitaliano, tale per gene, genio e gesta. lo ha tratteggiato l’autore di un articolo sul tema, apparso su un quotidiano top del Nordovest, pronubo di nozze tecnofinanziarie italoamericane. Viziato da tali umori e amori, dopo una ricerca-studio, l’articolista ha fissato in Tex Willer, il ranger yankee, il modello che piú e meglio incarna l’italiano eroico. L’estensore del pezzo, corredato dalla riproduzione del disegno a colori dell’eroe, apparso sul primo numero del 30 settembre 1948, rivela che l’ideatore del personaggio, Gianluigi Bonelli, ricevette il ‘la’ ispirativo, riguardo all’ambiente del fumetto, per i ranch dalle masserie della Maremma, per i canyon dal Gennargentu e dalle Dolomiti, per i personaggi dai tipi umani della periferia milanese. Siamo contagiati, ormai in maniera irreparabile, da un americanismo esasperato: dalla musica alla scienza, dalla tecnologia all’arte, dal cinema al modo di vivere comune. Il che non sarebbe un male, se ciò non venisse inteso come rinuncia totale alle pecularità che sono alla base della nostra civiltà, per barattarle con valori essenzialmente meccanicistici che la ‘civiltà’ atlantica ha imposto al mondo.
Il profilo dell’Italiano DOC, ovvero dell’Arcitaliano, tale per gene, genio e gesta. lo ha tratteggiato l’autore di un articolo sul tema, apparso su un quotidiano top del Nordovest, pronubo di nozze tecnofinanziarie italoamericane. Viziato da tali umori e amori, dopo una ricerca-studio, l’articolista ha fissato in Tex Willer, il ranger yankee, il modello che piú e meglio incarna l’italiano eroico. L’estensore del pezzo, corredato dalla riproduzione del disegno a colori dell’eroe, apparso sul primo numero del 30 settembre 1948, rivela che l’ideatore del personaggio, Gianluigi Bonelli, ricevette il ‘la’ ispirativo, riguardo all’ambiente del fumetto, per i ranch dalle masserie della Maremma, per i canyon dal Gennargentu e dalle Dolomiti, per i personaggi dai tipi umani della periferia milanese. Siamo contagiati, ormai in maniera irreparabile, da un americanismo esasperato: dalla musica alla scienza, dalla tecnologia all’arte, dal cinema al modo di vivere comune. Il che non sarebbe un male, se ciò non venisse inteso come rinuncia totale alle pecularità che sono alla base della nostra civiltà, per barattarle con valori essenzialmente meccanicistici che la ‘civiltà’ atlantica ha imposto al mondo.
Civiltà che Steiner ha stigmatizzato in Come si opera con la tripartizione dell’organismo sociale (O.O. N° 338): «Se si prescinde dal suo belletto europeo trapiantato in America, che cosa è la civiltà americana? Detto in modo radicale è la sua selvatichezza; senza intenzioni sciovinistiche, se si vuole riconoscere l’essenza della vita americana, diremo che gli europei non hanno vinto interiormente i pellirossa; seppure li hanno materialmente vinti, interiormente si sono compenetrati della vita indiana. Gli istinti hanno predominato; l’essenziale è che gli immigrati europei sono stati contagiati dagli istinti indiani. Non è solo che l’europeo trapiantato in America finisca con l’avere per esempio braccia piú lunghe, come è stato provato antropologicamente, ma è che egli muta la sua costituzione animica. Non si tratta di concetti e di rappresentazioni, ma della costituzione complessiva umana. Si deve convenire che quanto piú si procede verso occidente, tanto piú l’elemento anglosassone si è fatto selvaggio».
Un bacino di valori assai distanti dai parametri di eccellenza riconosciuti agli uomini della provvidenza di casa nostra, i predestinati dal fato, gli eroi delle emergenze, ma gente tosta di mano e di cuore, disponibile a ogni accomodamento morale e strategico pur di portare acqua al proprio mulino.
Non piú quindi Cincinnato, Muzio Scevola, Furio Camillo, tanto per cominciare dai primordi della storia italiana sotto l’egida latina, per passare a Ferruccio, Fieramosca, Pier Capponi, Pietro Micca Balilla, Enrico Toti, e per suggello dell’eroica paranza, l’Eroe dei Due Mondi, il Generale Libertador Giuseppe Garibaldi. Di questi personaggi, e dei tanti altri che hanno fatto l’Italia nei secoli, omessi non per la loro minima importanza, ma perché l’eroismo non ha quozienti di valori, nessuno ha meritato di servire da modello per fissare il Superman italico. Garibaldi deve essersela presa a male per tanta disistima, sia da parte dell’articolista che del giornale. E se non lui personalmente, deve essersi offesa una qualche entità superiore che tutela l’onore e il valore bistrattati, o peggio, volutamente dimenticati. Tant’è che nella notte tra il 6 e 7 settembre scorso, durante un uragano su Roma, con l’aggiunta di una tempesta magnetica da record, un fulmine si è schiantato sul monumento dell’Eroe nizzardo, sul piazzale del Gianicolo, là dove opera, da tempo immemore, un salace teatrino di marionette, e a mezzogiorno della domenica sparano con il cannone, il cui rimbombo incrina lo scampanío del Cupolone. Che il fulmine fosse mirato ad ammonire e non a ferire, lo prova il fatto che la saetta ha divelto un lastrone alla base del monumento, lasciando illesi il prode cavaliere e la sua imperiosa cavalcatura. Un segno di rispetto, dunque. Quel rispetto che è mancato ai connazionali dell’Eroe, principali beneficiari delle sue imprese. Cosí come il fulmine che colpí la cupola di San Pietro, l’11 febbraio 2013, volle essere un segnale di fine spettacolo e di congedo di un vicario della divinità dal palcoscenico usurato da troppe recite a soggetto, da formule e parole in libertà, dalla perduta sintonia col Verbo: un segno di rammarico per l’occasione mancata dalla “religio” di religare l’uomo al Divino, operazione catartica mirante a supportare il desiderio umano di sublimazione. A dispetto dei vandali, come quei pagani che hanno destinato l’Ara Pacis di Augusto (nella sua nuova versione presto ribattezzata “Bara Pacis”) a operazioni mercantili di basso profilo, spacciate per mostre d’arte, come quella dedicata, tempo fa, al sarto Valentino.
Cosí come il fulmine che colpí la cupola di San Pietro, l’11 febbraio 2013, volle essere un segnale di fine spettacolo e di congedo di un vicario della divinità dal palcoscenico usurato da troppe recite a soggetto, da formule e parole in libertà, dalla perduta sintonia col Verbo: un segno di rammarico per l’occasione mancata dalla “religio” di religare l’uomo al Divino, operazione catartica mirante a supportare il desiderio umano di sublimazione. A dispetto dei vandali, come quei pagani che hanno destinato l’Ara Pacis di Augusto (nella sua nuova versione presto ribattezzata “Bara Pacis”) a operazioni mercantili di basso profilo, spacciate per mostre d’arte, come quella dedicata, tempo fa, al sarto Valentino.
Cosa può fare l’uomo della strada, l’inerme cittadino, il suddito esautorato di ogni diritto se non aderire anima e corpo, e bancomat, s’intende, al tristo progetto di riduzione a zombi iperconsumistico? Nell’ora piú cupa dell’impotenza umana come quella che stiamo vivendo, vengono dati i segni della potenza e presenza divina, che mai diserta il campo dove combattono da sempre il Bene e il Male.

«Saturnia Tellus» rilievo in marmo dell’Ara Pacis
E cosí, come la nave Concordia finita sulla secca delle Scole al Giglio finí per divenire allegoria tragica della discordia che alligna tra noi millantatori figli di Roma, allo stesso modo il vilipendio al memoriale di Augusto che inneggia alla Pace ci destina, per contrappasso, a una discordia perpetua: tra partiti, correnti, clan, lobby, tra mariti e mogli, genitori e figli, maestri e scolari, tra donne e uomini. Eppure, stando alle cifre, il nostro è un Paese che ha tutte le carte in regola per tornare a essere la “Saturnia Tellus” dei Romani. Un luogo caro agli Dei, e per l’umanità quel faro di civiltà e bellezza che da secoli illumina il mondo. E, parola di Carlino, non si tratta di “vendere sogni ma solide realtà”. Di là dall’enfasi, dunque, numeri e dati, come li troviamo esattamente precisati in rete:
«L’Italia occupa lo 0,5% della Terra e ci vive lo 0,83% dell’umanità. Le condizioni bioclimatiche sono uniche al mondo e permettono alla penisola di essere la prima nazione del pianeta per biodiversità: 7.000 differenti vegetali, segue il Brasile con 3.000. – 58.000 specie di animali, segue la Cina con 20.000. – 1.800 vitigni spontanei da uva, segue la Francia con 200. – 997 tipi di mele, in tutto il mondo ne esistono 1.227. – 140 tipi di grano, seguono gli USA con appena 6. – L’Italia possiede il 70% del patrimonio artistico e umano, il rimanente 30% è sparso in tutto il resto del pianeta».
Ma allora, alla luce di questi dati illuminanti, cosa impedisce agli italiani di essere come potrebbero? E questa lapalissiana domanda ne fomenta un’altra: «Ma non è che, sotto sotto, ce la tirano un po’ e magari anche ci invidiano tanta grazia di natura e di ingegno?». Troverebbero allora chiarimento tanti arzigogoli geofinanziari per rovinarci la festa e, cosa ancora piú trista, la nostra propensione a crederci e ad agire come tanti galli da combattimento chiusi nel recinto dello spread, del debito pubblico, dei titoli tossici, degli intrighi prodotti altrove e introdotti da spalloni e contrabbandieri prezzolati. E noi a cascarci, a beccarci di taglio e di striscio, di notte e di giorno, e loro a junckerare scommettendo quanti dei molti galli, galletti e capponi, di papere e oche giulive stramazzeranno alla fine tra piume e penne strappate, girati allo spiedo delle sanzioni della triade monetaria globale, dopo il verdetto di Standard and Poor che ci declassa a una categoria creata apposta per l’Italia: la z.z.z., che è poi, nel linguaggio dei fumetti, la nuvoletta del sonno. Nel nostro caso, del coma profondo.
Ma oltre al sadico piacere di arrostirci, c’è quello di veder rosolare, oltre ai comuni uomini italiani da strapazzo, quali siamo diventati a guerra persa, i veri incubi ansiogeni dei nostri persecutori: ed ecco allora lo spiedo per Raffaello, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, e poi per Dante, Tasso, Leopardi, Stradivari, Leoncavallo, Puccini, Respighi, Caruso, Pavarotti, e tante altre glorie rivisitate in biografie, film e documentari tesi a rivelarne segreti difetti, tare e manchevolezze.
 Il Maestro dei Nuovi Tempi ha detto che «l’Italia ha la missione di fondere la politica con la cultura e ordinare la prima secondo i princípi della seconda. L’Italia ha il compito di attingere alle sue tradizioni spirituali e diffonderle». E ancora: «Immaginando la Terra come un feto ancora avvolto e giacente orizzontalmente nell’utero materno, l’Europa rappresenta il cervello, la cui scatola cranica è separata dalla spina dorsale dalla grossa catena delle Alpi. L’Italia è la spina dorsale che scende e si estende verso Oriente: sicché è il vero ponte dell’Europa per l’Oriente. Per questo l’Italia continua sempre ad essere fonte di cultura, poiché il sistema nervoso passa quasi tutto per la spina dorsale e si dirama da essa». Ma poi, il Maestro precisa: «L’Italia è la spina dorsale, ma l’organizzazione delle parti del corpo la fa il cervello, piú che la spina. E cosí anche l’unità italiana è stata fatta piú per opera di agenti estranei all’Italia stessa, cioè da nazioni europee, che dalla sola Italia».
Il Maestro dei Nuovi Tempi ha detto che «l’Italia ha la missione di fondere la politica con la cultura e ordinare la prima secondo i princípi della seconda. L’Italia ha il compito di attingere alle sue tradizioni spirituali e diffonderle». E ancora: «Immaginando la Terra come un feto ancora avvolto e giacente orizzontalmente nell’utero materno, l’Europa rappresenta il cervello, la cui scatola cranica è separata dalla spina dorsale dalla grossa catena delle Alpi. L’Italia è la spina dorsale che scende e si estende verso Oriente: sicché è il vero ponte dell’Europa per l’Oriente. Per questo l’Italia continua sempre ad essere fonte di cultura, poiché il sistema nervoso passa quasi tutto per la spina dorsale e si dirama da essa». Ma poi, il Maestro precisa: «L’Italia è la spina dorsale, ma l’organizzazione delle parti del corpo la fa il cervello, piú che la spina. E cosí anche l’unità italiana è stata fatta piú per opera di agenti estranei all’Italia stessa, cioè da nazioni europee, che dalla sola Italia».
Ecco, il punto dolente: l’unità d’Italia, concepita da pulsioni animiche di alta spiritualità, entrò nel gioco degli interessi dinastici, geopolitici e da ultimo finanziari. Di assoluta materialità. Questi demoni ancora ci assillano e mettono discordia dove solo dovremmo operare con la sapienza del cuore.
Tra gli arcitaliani doc non possiamo però dimenticare chi ha profumato il nostro Paese di santità: Benedetto da Norcia, Bernardino da Siena, Francesco e Chiara d’Assisi, Rita da Cascia, Caterina da Siena, Antonio Abate, Francesco di Paola, Tommaso d’Aquino, Carlo Borromeo, Filippo Neri, Gemma Galgani, Giovanni Bosco, Luigi Orione, Giuseppe Benedetto Cottolengo e Padre Pio da Pietrelcina.
Cos’è che ci impedisce di essere come saremmo? Ci manca lo spirito di popolo e l’ideale che faceva del romano antico un tutt’uno con la Monarchia prima, la Repubblica poi e infine l’Impero. Non erano migliori di noi italiani di oggi e di qualunque altro popolo del passato e del presente. Quanto al futuro, esso, come dicevano i Romani, è sulle ginocchia di Giove. Perché le ginocchia e non le mani? Perché è sulle ginocchia che il pater familias, il buon padre di sempre, mette a sedere i figli. C’è in questo atto non solo protezione ma amore. Ottaviano venne definito ‘augustus’, ossia il padre che ‘accresce’ il benessere dei sudditi-figli. Mecenate lo capí e lo assecondò con tutta la sua dedizione e capacità. No, non erano migliori di noi, i Romani antichi, e Mecenate non piú abile di qualunque funzionario pubblico che si senta servitore e non sfruttatore dello Stato. Con i tempi che corrono, si è portati a temere che di uomini cosí, come dopo di lui Marco Aurelio e Antonino, si sia perso lo stampo: uomini praticanti la virtú non per dottrina, decalogo o statuto, ma perché conviene all’uomo, alla società tutta.
Quello stampo può rifarsi in ogni momento della storia di una nazione. Basta volerlo. Per noi, popolo di eroi, di santi, di poeti e quant’altro, è scelta obbligata, volendo essere quello che siamo.
Ovidio Tufelli