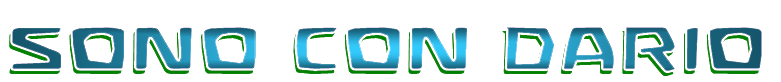Da qualche giorno l’amico Dario non c’è piú. Se ne è andato in uno di quei modi che fanno esclamare “invidiabile” a chi resta. In buona parte siamo indotti a pensare cosí: uno va a dormire alla sera e al mattino non si risveglia; al di là dell’inevitabile impatto emotivo, la cosa ci sembra positiva, quasi bella: «È morto nel sonno, senza dolori», «Non ha sofferto», si dice in giro, e siamo convinti che questa consolazione sia la cosa piú importante del teorico rapporto istaurato con la nostra dipartita.
Da qualche giorno l’amico Dario non c’è piú. Se ne è andato in uno di quei modi che fanno esclamare “invidiabile” a chi resta. In buona parte siamo indotti a pensare cosí: uno va a dormire alla sera e al mattino non si risveglia; al di là dell’inevitabile impatto emotivo, la cosa ci sembra positiva, quasi bella: «È morto nel sonno, senza dolori», «Non ha sofferto», si dice in giro, e siamo convinti che questa consolazione sia la cosa piú importante del teorico rapporto istaurato con la nostra dipartita.
Perché è inutile star lí a negarlo: nella morte degli altri, noi ravvisiamo, ricordiamo, paventiamo prevalentemente la nostra; e con essa, il fatto di essere biodeperibili, assoggettati ad una fine sicura, la quale, restando ignoti i dettagli e le modalità, potrebbe anche presentarsi lunga, difficile e tormentosa.
Come da prassi perfezionata nel tempo, all’evento è seguita la mesta trafila degli atti dovuti: le telefonate, le condoglianze, le parole di speranza, il desiderio caritatevole d’infondere a terzi quel conforto che probabilmente non sappiamo dare nemmeno a noi stessi. E poi il rito funebre; una marea di gente smarrita e recuperata in abito scuro. Dario era molto conosciuto in città, per il suo lavoro di assicuratore, perché aveva fatto parte per molti anni di una squadra regionale di rugby, e poi perché era presente come titolare o socio sostenitore in parecchi circoli sportivi e associazioni di tempo libero.
La bara di lucido legno rossiccio splendeva grazie a un raggio di sole, che filtrando da un finestrino del locale funebre, la illuminava con un angolo di 30 gradi, cosa insolita per una giornata grigia e nuvolosa fin dal primo mattino. Sopra al feretro il suo maglione da rugbista, e nel mezzo di una policromia di fiori, una recente foto bella grande, lo ritraeva in posizione da conquistatore in cima a una vetta, sorridente e sereno come il cielo e i prati alpestri che lo circondavano.
Durante la messa a seguito delle esequie, alcuni parenti ed amici si sono alternati al microfono per esternare l’ultimo saluto. Ho voluto farlo anch’io, anche se fino a quel momento non ci avevo pensato, ma in un attimo ho preso la decisione; avevo capito quel che c’era da fare, e per quanto lontano mille miglia da panegirici e rituali, volevo e dovevo farlo.
Ho raccontato in poche parole l’incontro con l’amico: «Ho conosciuto Dario molti anni fa; allora avevo appena messo in piedi un’attività assicurativa e cercavo collaboratori. Lui aveva già una piccola esperienza come produttore, venne da me, ascoltò il panorama che gli prospettavo, e senza pensarci su due volte, disse: “Ok, ti aiuterò”. Io avevo vent’anni piú di lui ed ero diventato da poco Agente Generale; rimasi divertito e impacciato per quella affermazione cosí perentoria. Non aprii bocca, però pensai: “Ma guarda questo giovanotto di belle speranze! Semmai sarò io ad aiutare te, con il mio insegnamento, con i mezzi e con le opportunità che ti offro!” Ebbene, non avrei potuto sbagliarmi maggiormente. Nel tempo Dario divenne non solo piú bravo di me, esperto in materia assicurativa e capacità professionale, ma col suo modo di agire, sempre intelligente, perspicace, conclusivo, e con la sua carica di generosità umana incredibilmente spontanea, direi quasi contagiosa, senza sottrarsi mai alle responsabilità anche le piú pesanti, ma anzi facendosi pure carico di oneri altrui quando vedeva qualcuno in difficoltà, m’insegnò – non a parole ma con l’agire – un modo nuovo di affrontare la vita. Con lui per la prima volta ebbi l’esperienza concreta che quando ami non hai nulla da temere e che l’amore è vero solo se lo dai senza chiedere mai nulla per te. Grazie, Dario!».
Nei giorni che seguirono, e fino a quello odierno, il mio pensiero spesso ripercorre in modo insistente gli anni passati assieme, le vicende umane trascorse e come, in tutte le circostanze condivise, Dario mi sia sempre stato accanto in modo adialettico e propositivo.
Non era un gran parlatore, preferiva agire, e su questo non aveva esitazioni. Sapeva per una sua speciale capacità innata qual era la cosa migliore da fare in una determinata situazione e si poneva subito all’opera.

William Barnes «Giocatori di palla ovale»
Conoscendolo bene compresi perché i suoi compagni sportivi lo apprezzassero molto. Pur essendo di piccola statura, al contrario dei soliti massicci giocatori di palla ovale, era tuttavia muscolosissimo, specie nelle gambe, e quindi veloce come una saetta. Nel suo ruolo di ala, quando portava pallone era pressoché impossibile arrestarlo; sapeva schivare, saltare gli ostacoli con finte, guizzi, improvvise accelerazioni e cambi di ritmo, che confondevano la difesa avversaria e rendevano vano ogni sbarramento. Non di rado, mi raccontarono, riusciva in piena velocità a passare tra una selva di gambe, tuffandovisi in mezzo e uscendo di corsa dal groviglio. Cercava sempre la mèta, la voleva; ne possedeva il fiuto. Credo che anche dopo aver smesso di giocare sul campo, abbia affrontato la sua vita come fosse un nuovo prato da rugby, di cui, stringendo gli occhi in vigile silenzio, egli già scrutava la linea d’ una possibile mèta.
Perché è facile – anche se non ce ne accorgiamo – giocare dove ci sono i segnali, le indicazioni e un arbitro a dirigere il tutto e a far rispettare le regole. Non lo è piú laddove ci si deve inventare ogni volta di nuovo le condizioni migliori per sostenere le proprie idee e portarle avanti con forza, volontà e tempismo.
In questo Dario era imbattibile; lentamente nel corso degli anni, quando agli inizi lavorava per me e poi anche quando divenne a sua volta agente generale per conto di un’altra società di assicurazioni, mi trasmise quella sua caratteristica che al momento mi aveva lasciato sorpreso e un po’ incerto, ma che nel seguito ebbi a riconoscere come una specialità sintetica del carattere umano. In particolare, di uomini capaci di credere nelle proprie idee e di portarle avanti contro ogni forza oppositiva.
Oggi, dopo averlo capito per una sorta di osmosi induttiva, posso dire che una simile specialità si trova, o giace, piú o meno sepolta, in ciascuno di noi. Non ce ne siamo mai curati, perché è impossibile coltivare un orticello ignoto in quanto non percepito, eppure – lo dico soprattutto per chi si sia in qualche modo avviato sulla strada della conoscenza interiore – i riferimenti ad una tale prerogativa cosí squisitamente umana non sono pochi né rari.
Dal momento che il mio amico mi ascoltava volentieri, e qualche volta in particolari circostanze aveva colto e valutato il mio parere, anche se questo andava in direzione diversa da quella che egli avrebbe intrapreso, mi ero fatto carico della funzione di padrino o di tutor, se vogliamo, nei suoi confronti; funzione alquanto ridicola sulla quale entrambi spesso scherzavamo, e che tuttavia aveva un suo senso: io possedevo delle cose che a lui mancavano, anche se, ripeto, resto convinto del fatto che in una contabilità comparativa risultavo di gran lunga perdente.
Non appena trovavo il tempo e lo spazio per poterlo fare, portavo i miei discorsi sulla Scienza dello Spirito e cercavo di attirare il suo interesse, dimostrando come ogni vicissitudine privata e di lavoro trovasse coronamento all’interno dell’insegnamento spirituale e che – pur non apparendo come elemento di facile comprensibilità – solo nello Spirito risiedono le vere cause di tutto quel che poi viene ad accadere nella dimensione ordinaria del fisico-sensibile.
Con la sua perspicacia, teneva buon conto delle mie parole; non le dimenticava, ma inevitabilmente avvertiva la necessità di avventurarsi nel mondo come gli piaceva e come si divertiva a fare. Non si risparmiava in nulla: fumava come un turco, si alzava al mattino molto tardi, spesso quando gli altri pranzavano, e in compenso lavorava senza sosta anche fin dopo la mezzanotte. Aveva formato due famiglie con due diverse unioni matrimoniali, da entrambe ebbe figli bellissimi e amorevoli, e con la sua personalità capace di delicatezza affettiva e di sensibilità spontanea, riusciva a far stare in equilibrio, abbastanza armonioso, tutto quel mondo di rapporti e di affetti che si era procurato.
 Pur guadagnando bene, grazie anche ai suoi molteplici slanci intuitivi in piú direzioni (possedeva il cosiddetto “bernoccolo degli affari”) non aveva mai una lira per sé in tasca. Parenti e amici, ben conoscendo la sua ampiezza di vedute, erano di continuo beneficiati dal suo affetto incondizionato. Chi lo ha conosciuto per poco e a distanza, potrebbe dire che era uno con le mani bucate, e sicuramente non sbaglierebbe. Bisogna però, prima di giudicare, vedere le ragioni di quei buchi alle mani: potrebbero esserci tante di quelle attenuanti, cosí valide, cosí onorevoli, da cancellare il difetto e trasformarlo in virtú.
Pur guadagnando bene, grazie anche ai suoi molteplici slanci intuitivi in piú direzioni (possedeva il cosiddetto “bernoccolo degli affari”) non aveva mai una lira per sé in tasca. Parenti e amici, ben conoscendo la sua ampiezza di vedute, erano di continuo beneficiati dal suo affetto incondizionato. Chi lo ha conosciuto per poco e a distanza, potrebbe dire che era uno con le mani bucate, e sicuramente non sbaglierebbe. Bisogna però, prima di giudicare, vedere le ragioni di quei buchi alle mani: potrebbero esserci tante di quelle attenuanti, cosí valide, cosí onorevoli, da cancellare il difetto e trasformarlo in virtú.
Venne un tempo di crisi: si era ammalato seriamente e i medici non concedevano molte speranze. Mi aveva affidato delle lettere in busta chiusa, da recapitare ai suoi cari al momento che si suol dire opportuno, anche se qui l’aggettivo suona del tutto fuori posto. Mi sentii allora ancora piú incline a impartirgli delle considerazioni di Scienza dello Spirito, che, in quel frangente, ritenevo fossero davvero importanti.
Con poche parole spiazzò le mie buon intenzioni: «No, grazie – mi disse. – Scusami, non è per me». Da allora è passato molto tempo. Dario comunque guarí, e guarí bene. Pochi anni or sono, gli rammentai delle lettere affidate. Mi guardò sorridente, come se gli avessi raccontato qualcosa di divertente, poi, accesa l’ennesima sigaretta, aspirate due o tre boccate, mi rivolse un semplicissimo: «Buttale via», che io non ignorai.
Ora, senza la possibilità di avere il mio amico vicino nella sua presenza fisica, mi ritornano in mente i molti discorsi svolti con lui nei quali innestavo sempre i temi spirituali di cui ero e sono convinto. Erano discorsi tronchi, spezzettati, che non mi riusciva mai di portare a termine, o per la sua pur cordiale refrattarietà o per le urgenze di tempo che la nostra professione imponeva, e alle quali ne lui né io volevamo sottrarci.
Stranamente mi riesce di compierli adesso. Posso concluderli. Mi pare di averlo accanto come un tempo, avvolto nel pungente odore di tabacco, e – cosa questa ancora piú strana – ora le parole cominciano a spiegare con chiarezza quel che prima, proferendole, non mi era stato possibile focalizzare. Non posso dire che sia Dario stesso, da una sconosciuta dimensione extraterrestre, a fornirmi in qualche modo l’imbeccata giusta; lungi da me questo aspetto un po’ torbido con il quale troppe volte, tra suggestioni e rimpianti, crediamo di svolgere quel rito che chiamiamo con il nome un po’ pomposo di “elaborazione del lutto”.
Tra le tante cose buone, Dario ed io abbiamo condiviso il gusto della semplicità, e – voglio rivelarlo qui – non di rado l’abbiamo fatto in modo cosí schietto da sembrare dissacrante. Ma l’ironia diventa cattiva solo se maschera il sarcasmo. Noi non mascheravamo nulla, ci piaceva creare sul momento una serie di battute che secondo il nostro gusto ritenevamo spiritose, qualsiasi fosse l’argomento in questione, e quando eravamo in forma potevamo andare avanti in un ‘botta e risposta’ che non finiva piú, come fossimo una coppia di comici d’avanspettacolo bene allenati. Le nostre frecciatine, i nonsense, i giochi di parole, s’intrecciavano in modo vorticoso e sbeffeggiante, tale da disgustare le persone cosí dette seriose ed impegnate.
 Solo in un vecchio film di Fellini ho trovato una corda che suonasse questo tipo di musica: “I Clown”, una ricerca sulla vita circense svolta dal regista che fin da bambino era stato affascinato dalle magie e dai segreti dei circhi itineranti.
Solo in un vecchio film di Fellini ho trovato una corda che suonasse questo tipo di musica: “I Clown”, una ricerca sulla vita circense svolta dal regista che fin da bambino era stato affascinato dalle magie e dai segreti dei circhi itineranti.
In un preciso punto de “I Clown” si parla dei “pagliacci”. Come in uno specchio deformante e grottesco della nostra vita, Fellini ci fa conoscere il Clown Bianco, bello elegante, ben vestito, di portamento altero, pieno di sussiego, che sa suonare, cantare e ballare sempre con grande grazia e abilità. Poi c’è, in contropartita, l’altro pagliaccio, il Clown Rosso, ed è un mondo totalmente all’opposto del primo. Il Clown Rosso è uno scemo-citrullo-rimbambito, sporco, malvestito, spesso semi-ubriaco, ignorante, fracassone, con le scarpe sfondate, una parruccaccia vermiglia in testa, truccato con la maschera del cretinetti che ride di continuo, specie se non c’è nulla da ridere.
Tuttavia, il pallino del Rosso è – naturalmente – quello di emulare il Bianco, di raggiungerlo e, chissà, magari di superarlo nelle sue spiccate bravure. Il risultato, non occorre dirlo, è disastroso: tutti i tentativi del Rosso gli finiscono inesorabilmente male; egli cadrà piú volte rovinosamente a terra a gambe all’aria, subirà i calcioni del Bianco, che certo non gliene risparmierà, e finirà dietro le quinte, non senza prima aver fatto almeno tre volte il giro della pista, inondando gli spettatori delle prime file con zampilli di lacrime, rutti e altri suoni indecenti ancorché tragicomici.
Ma ad un certo punto la parodia cambia registro. Le luci si attenuano, la musica attacca un valzer lento, che zittisce lo sghignazzo di prima e ci introduce nella tenera penombra della riflessione: la notizia è che il Clown Bianco non c’è piú, è morto; rimane solo il Rosso in mezzo alla pista, e …ed è impacciato, non sa piú cosa fare; commenta l’accaduto, in un linguaggio ovviamente dialettale e sgrammaticato, ma per la prima volta, sommesso e timoroso. «Ma come? – parlotta fra sé e sé. – Com’è che uno prima c’era e ora non c’è piú? Ma non è mica giusto! Non si fanno queste cose! E adesso io qui che faccio? Siamo sempre stati assieme, per tanto tempo… Oddio! Lui era un po’ quel che era, ma si andava d’accordo. Si litigava, è vero, ma si faceva pace. E adesso, come si fa? Gli avevo pure prestato delle salsicce l’altro ieri… e ora, dove vado a riprenderle? Però, adesso che ci penso mi viene un’idea: noi facevamo sempre quel numerino musicale in cui lui prendeva la sua tromba e si metteva a suonare quel pezzo che mi cavava le budella dagli occhi, tant’ era bravo con la musica, e io gli andavo dietro come potevo, un po’ canticchiando e un po’ volteggiandogli attorno, schivando le sue pedatone. Alla gente piaceva, applaudivano, si commuovevano tutti, grandi e piccini… Allora, dico io, magari se prendo in mano la sua tromba e cerco di suonare quel motivo… chissà forse, per una sorta di magia… un incantesimo… lui sentirà che io sono qui, che lo cerco, e forse ricomparirà… Ecco, io mi metto a suonare ’sta tromba e poi vediamo… Non so se ci riesco, ma ci voglio provare. Se ce la faccio, io… io gli posso anche abbonare le salsicce…».
Forse le cose succedono proprio cosí. Certo, il mondo non è un circo equestre e gli esseri umani non sono dei pagliacci. Ma da come abbiamo trasformato il nostro esistere e da come abbiamo gestito i nostri comportamenti, non ne siamo lontani. Anche se un elemento di separazione si può distinguere nettamente: il circo e il suo apparato tentano di essere divertenti, gli uomini invece non sanno nemmeno in cosa consista questa finalità: vogliono semmai venir divertiti, farsi divertire, e per questo sono disposti a pagare un prezzo che, guarda caso, non è mai quello giusto.
Con l’aiuto del pensiero di Dario che mi lavora dentro, vedo questa vicenda in maniera diversa da quella che sarei stato normalmente propenso a vedere. Tutto quello che aleggia attorno alla scomparsa di un uomo, dai riti, ai convenevoli, alle partecipazioni, mi pare privo di senso. O per dire meglio, un senso ce l’ha, ma non è quello verso il quale dovremmo tutti indirizzare le menti e i cuori.
Il fumo nasconde il fuoco, lo smog deturpa la purezza dell’aria, e la trasparenza dell’acqua s’intorbida per sporco di superficie: come può l’anima dell’uomo non confondersi?
 Quest’ ultima è la parafrasi di una metafora indú, ma se ci sono dei dubbi di comprendonio, se risulta poco pertinente, possiamo trasporla immediatamente sul piano molto moderno del c.v.d., della dimostrabilità senza equivoci.
Quest’ ultima è la parafrasi di una metafora indú, ma se ci sono dei dubbi di comprendonio, se risulta poco pertinente, possiamo trasporla immediatamente sul piano molto moderno del c.v.d., della dimostrabilità senza equivoci.
Quante volte abbiamo sentito: «Oggi il cielo è nuvoloso, il sole non c’è». Chi ci pensa su per un attimo, con un atteggiamento anche parzialmente obiettivo, capisce subito l’errore, la pacchiana corbelleria insita nell’affermazione. Se il sole non ci fosse, pure per pochi secondi, avverrebbe il finimondo, e non metto lí la parola “fini-mondo” come decorativo sostantivato.
Manca una vera cultura della morte fisica. Per la nostra ignoranza siamo costretti a dipingercela sempre come una cosa brutta, spaventosa; meglio non pensarci proprio. Ma inevitabilmente il soffrire, i lutti, le esequie càpitano, ci scuotono dal quel sogno ad occhi aperti con il quale sogniamo la vita; ci chiedono una comprensione piú elevata, piú misericordiosa (e anche un pochino piú onesta) della morte. Quella che abbiamo, che il nostro ego si è consolidato per lustri, è un’illusione, Babbo Natale e Halloween compresi. Veramente troppo ingannevole per farci cogliere l’aspetto reale di una delle due maggiori evenienze del nostro transito terrestre. “Dall’Alfa all’ Omega” stava scolpito sulle antiche lapidi, ma interpreti very trendy sostengono si trattasse di pubblicità ante litteram per automobili e orologi…
Parlando con l’amico scomparso, o ritenendomi consapevole di saperlo fare, il che è secondo me la stessa cosa, siamo dunque giunti al momento in cui dobbiamo decidere se tutta la faccenda riguardante il reparto “Lutti, Funerali & Piagnistei” sia soltanto un’inutile commedia che i vari ego coinvolti recitano in se stessi e per se stessi, e quindi sarebbe forse il caso di smetterla e di adoperare quelle risorse, quelle energie che vengono spese in vasi funebri, ghirlande e coroncine, per qualche cosa di piú bello ed importante, qualcosa di tonificante, non di deprimente. Oppure ci adeguiamo pure noi, e seguiamo mesti mesti i feretri, le omelie, i dolcetti post ritum accompagnati col vin santo, e gli immancabili leggendari epitomi cadenzati al ritmo di “quant’era buono, quant’era caro”.
Non abbiamo (parlo di noi, Dario ed io) risolto completamente la faccenda; non vogliamo coltivare la pretesa di strappare le bambole dalle mani delle orfanelle in lacrime; sarebbe assurdo, sarebbe delittuoso. Quasi quanto lo è l’azione di quella supplente scolastica negli USA che recentemente ha voluto spiegare ai bambini l’inesistenza di fate, folletti, Babbi Natale e in generale di tutte le parvenze metafisiche della tradizione, in quanto scientificamente infondate e deplorevoli per un paese leader e una civiltà d’avanguardia.
Anche se la nostra visione riesce ad attingere a panorami sconosciuti e meravigliosi, nascosti dietro la stratosfera, sentiamo l’impulso morale di avere il pudore della nostra felicità, di capire e metterci allo stesso livello di quanti continuano a portare nei loro cuori presepi, angioletti, stelle comete, Bambinello, pastori e pecorelle. Se in questa loro evoluzione non possono avere nulla di meglio, se vogliono restare attaccati alle percezioni piuttosto che ai pensieri che esse sollecitano, se preferiscono ascoltare le conferenze sullo Spirito piuttosto che attivarsi in nome dello Spirito, è meglio lasciarli stare. Anche per loro verrà il momento in cui potranno rivalutare sapere, nozioni e cultura a favore di un novello stato di coscienza, il cui processo tuttavia non può venir affrettato da mani e predicozzi altrui.
Modificando istrionescamente Il Magnifico, si potrebbe qui dire «Chi vuol esser triste sia, del doman non v’è certezza». D’altra parte, il povero ego che dovrebbe fare? Rallegrarsi perché in quanto ego è predestinato a soccombere? Hai voglia a dirgli che l’anima immortale proseguirà la sua corsa fuori dallo spazio e del tempo per poi ritornare in altre vesti, forme e coscienza, dentro lo spazio ed il tempo. Per lui, ego, sperimentarsi in quel determinato aspetto, esplicativo di un codice fiscale ben rifinito, e operare in conseguenza nell’effimero traguardo di recludersi in una formazione provvisoria, isolata e isolante, è tutto; non ha altro, né potrebbe averlo, altrimenti cesserebbe d’essere quel che è. Se gli pare incombente una minaccia di trasferimento in un’altra dimensione, si dibatterà, si difenderà con tutte le sue forze: che sulla terra sono potenti; non di rado pre-potenti.
 Preoccupato in tale prospettiva, assisto con Dario ai fenomeni epocali provocati nel settore del lavoro da un ostinato caparbio disconoscimento delle forze egoiche, nonché della portata dei loro danni; impongono esclusivamente la difesa dei diritti e, per contro, non accennano mai ai doveri. Se i proprietari di un’attività lavorativa vogliono chiudere (a volte sono costretti a farlo) o ridurre, o delocalizzare, in poche parole vogliono risparmiare, allora – apriti cielo! – non si può, è impossibile, è inumano; io ho appena aperto un mutuo per la casa; io ho due figli e ne aspetto un terzo; lo Stato che fa? Il governo dorme? Le autorità devono intervenire, non si possono mettere sul lastrico le famiglie in questo modo! Pane e lavoro! Non chiediamo altro!
Preoccupato in tale prospettiva, assisto con Dario ai fenomeni epocali provocati nel settore del lavoro da un ostinato caparbio disconoscimento delle forze egoiche, nonché della portata dei loro danni; impongono esclusivamente la difesa dei diritti e, per contro, non accennano mai ai doveri. Se i proprietari di un’attività lavorativa vogliono chiudere (a volte sono costretti a farlo) o ridurre, o delocalizzare, in poche parole vogliono risparmiare, allora – apriti cielo! – non si può, è impossibile, è inumano; io ho appena aperto un mutuo per la casa; io ho due figli e ne aspetto un terzo; lo Stato che fa? Il governo dorme? Le autorità devono intervenire, non si possono mettere sul lastrico le famiglie in questo modo! Pane e lavoro! Non chiediamo altro!
E ai proprietari sul punto del fallimento, il pane chi glielo dà? Non potrebbero avere anche loro dei mutui in corso, o dei figli a carico? Ma questa campana evidentemente non favorisce l’audience di quanti sanno solo strillare, perché hanno imparato che strillando forte prima o poi qualcosa si ottiene.
La matassa s’ingarbuglia e diviene spinosa nella misura in cui non riusciamo, stando al di fuori delle vicende, a capire quanto, nel ritirarsi dei proprietari, sia dovuto alla necessità effettiva di fare risparmio e quanto invece possa essere prodotto da una ricerca spasmodica di maggior profitto. Da una parte non si possono processare le intenzioni, dall’altra non è possibile permettere ai furbastri di passare impuniti attraverso le maglie di leggi e regole messe assieme alla garibaldina da politicanti pasticcioni.
Dario ha lavorato come agente di assicurazioni per trentaquattro anni; a mia volta ne ho fatti quarantadue e sette mesi; non abbiamo mai saputo cosa fosse uno stipendio fisso, una paga garantita a fine mese; abbiamo sempre vissuto di sole provvigioni; se facevi, prendevi, se non facevi, ti succhiavi il pollice. Per giunta, come tutta la categoria dei rappresentanti, agenti di commercio e ausiliari d’impresa, i nostri mandati erano soggetti a revoca da parte della società preponente; nessuno se ne stava al sicuro, tranquillo, prosperando sul lavoro costruito. Scusate lo sfogo ma era solo per chiarire una questione che col passar del tempo si va oscurando facendosi minacciosa.
Nei forum centrati su società e lavoro (ce ne sono a iosa) non si ama parlare di scelte di vita, di karma, di ostacoli e di Ostacolatori. Non si ha questo coraggio; le vere forze in gioco è meglio lasciarle nascoste dietro i paraventi dell’ipocrisia. Meglio che i “necessitati”, rabbiosi al punto giusto, scatenino ire e rivendicazioni, picchiandosi tra loro. Oppure, sí, si discute, si analizza, si studiano programmi di approfondimento, ma nei salotti élitari, bevendo il tè, o in incontri opinionistici nei caffè del centro con qualche luminare del momento disposto a conferire.
 Perciò Dario ed io preferiamo lasciare alla “Compagnia Piagnoni & Strilloni”, la loro perfetta vocazione a soffrire, ad alzare i pugni al cielo e pestare i piedi in terra; vale a dire a considerare l’esistenza in vita come un Paese dei Balocchi, e la morte come un’indecente proposta appositamente studiata da qualche Entità malvagia, che ci strappa, a volte anche in tenera età, da questo Paradiso Terrestre che i seguaci di detta Compagnia hanno fin qui abbellito e curato con guerre, sangue, malattie, pestilenze, droghe, smog e inquinamenti vari.
Perciò Dario ed io preferiamo lasciare alla “Compagnia Piagnoni & Strilloni”, la loro perfetta vocazione a soffrire, ad alzare i pugni al cielo e pestare i piedi in terra; vale a dire a considerare l’esistenza in vita come un Paese dei Balocchi, e la morte come un’indecente proposta appositamente studiata da qualche Entità malvagia, che ci strappa, a volte anche in tenera età, da questo Paradiso Terrestre che i seguaci di detta Compagnia hanno fin qui abbellito e curato con guerre, sangue, malattie, pestilenze, droghe, smog e inquinamenti vari.
Ci permettiamo tuttavia un piccolo dissenso, naturalmente con i nostri ego personali, sempre ben radicati in noi (almeno in me è cosí, per Dario forse ora qualcosina di meno) partecipiamo pure noi al grande banchetto delle sensazioni fisiche e, secondo impulso e circostanza, siamo disponibilissimi al riso e al pianto, quando ci vogliono, senza nascondercelo per pavide ritrosie o reconditi pudori.
In compenso desideriamo considerare la vita terrena come una continua fonte di luce e di gioia per le quali ogni cosa ha un suo prezzo da pagare; un corrispettivo. Ogni possibilità conoscitiva s’incarna nell’esperienza dell’umano, e da essa è capace di risorgere come nuova conoscenza intuitiva e creatrice di mille altre esperienze. La vita ci viene elargita gratis; anche intellettivamente parlando, e quindi pure la vita delle idee che produciamo. Ma la loro gestione richiede un costo. Questo costo non viene espresso dalla sola caducità, dal deperire, dal tramonto delle forze psicofisiche che tengono funzionante e desto (almeno potenzialmente) l’involucro, ma viene espressa massimamente nella qualità delle idee e delle azioni morali che – fintanto siamo qui (e solamente stando qui) – possiamo accogliere in ispirazioni e pensieri, per poi operare e realizzare a piacimento.
Si tratta in sostanza di accorgersi d’essere cresciuti, che il Bambinello dei Presepi è sempre stato il Logos che era nel Principio, che il Sole continua imperterrito a splendere dietro alle nuvole, e fate, maghi e folletti, compresi Babbo Natale e Befana, devono poter sopravvivere nel mondo dei piú piccoli, perché i nostri bambini hanno il diritto di non vedersi sfiorire la breve stagione della loro innocenza, e noi adulti abbiamo il dovere morale di non guastargliela precocemente. Ogni anima ha diritto al suo mondo di percezioni; che è il suo stato di coscienza; portarglielo via in anticipo è impedirle di crescere armoniosamente.
Ma non per questo dobbiamo rivolgerci al Grande Passaggio della Morte come fosse un male da cui fuggire. Il male è solo ciò che combiniamo noi quaggiú (in questo caso, io sottoscritto, senza Dario) disattendendo il compito evolutivo e sciupando la nostra esistenza rincorrendo le ombre e le fantasie di un ego che cerca in tutti i modi di non ipotizzarsi mai come l’IoSono della nostra individualità; come Spirito unico e irripetibile sceso sulla terra per trasformare l’umano nell’essere divino che potenzialmente è. Giungere all’altra sponda per il tramite della morte è sempre cosa degna della nostra gioia e della nostra letizia piú elevate e profonde; molto meno lo è dei nostri pianti e lamenti, che sono quasi sempre ad uso e consumo dell’entità egoica. Intendiamoci bene, versare lacrime sui propri defunti è una reazione dell’anima da non impedire. Al momento non ci si può sottrarre, ma l’anima ha in sé la forza per valutare la situazione nella verità che la regge e la illumina. Sa vedere, riconoscere la Bontà eterna e infinita anche nell’evento luttuoso; può non afferrarne con immediatezza le ragioni, ma può glorificarlo portando incontro al fatto tutto l’amore di cui sa di poter disporre.
Io sono rimasto qui senza Dario, ma da bravo Clown Rosso, nel quale stavolta non esito a identificarmi, dopo il solito quarto d’ora di lacrimucce e mestizie ho preso in mano la tromba che lui sapeva suonare cosí bene. Non so se arriverò al punto di riprodurre quella melodia che, grazie a lui, siamo riusciti a costruire su questa terra, ma non vedo proprio cosa mi può impedire di provarci. Anzi, credo che provarci sia il modo migliore per aiutarci ancora una volta l’un l’altro. Lo sento sorridere felice, e scoccarmi l’ennesima frecciatina-shock: «Su questa terra, o impari a usare la tromba, o sei trombato».
Angelo Lombroni