Tutti gli eventi accadono a seguito di azioni. Molte di queste ci appartengono, hanno la nostra impronta. Tentare di formulare un numero per contarle, anche avvalendoci dei piú sofisticati elaboratori, sarebbe assurdo prima ancora che impossibile. Ma certamente queste azioni hanno un peso. Segnano il corso della storia dell’uomo e quella del mondo che le fa da palcoscenico.
Spesso mi diletto in considerazioni fantasiose come questa: non mi chiedo quante possano esser state le azioni che noi uomini abbiamo compiuto, ma quante invece siano state quelle che non abbiamo compiuto; che non abbiamo voluto compiere. Naturalmente quando eravamo nella piena possibilità di attuarle. Delle altre non avrebbe senso riferire.
Pongo cosí una questione d’avvio: questa seconda parte (il cumulo cioè delle azioni da realizzarsi ma non realizzate per pigrizia, paura, trascuratezza, ignoranza o malafede) non hanno forse determinato un danno maggiore per una corretta evoluzione del sistema-uomo, di quello apportato da azioni concrete divenute quindi fatti accaduti?

Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata…
«Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur». Non me lo ricordavo piú, eppure ai vecchi tempi avevo studiato Tito Livio. Pensandoci, mi pare anche di aver preso un buon voto traducendo alcuni passi degli Annali. Ora invece, incalzato da personaggi politici e da giornalisti di settore, vengo a riscoprire l’antico detto, che poi non è esattamente quello espresso dall’autore, ma ne è una sintesi, devo ammettere, piuttosto efficace. Suppongo tuttavia che a Tito Livio interessasse maggiormente l’obiettività della cronaca che non l’esibizione formale della stessa. Dunque, mentre si perde tempo a chiacchierare, dei fatti avvengono e a volte sono dei veri e propri guai. Non mi importa in questa sede dell’avvenuta espugnazione di Sagunto, e mi importa ancor meno del perché la citazione rispolverata da improvvisati latinisti del terzo millennio venga trasferita di peso, con furbesca malizia, sull’attuale situazione economica e sociale del paese.
Per contro m’interessa ciò che sta alla base di tutti i detti e li trasforma in aforismi, perpetuando in tal modo l’elemento universale e imperituro che essi solitamente contengono. È là che vive e palpita come una fiammella quel soffio di verità capace di trasformare brevi parole in luce duratura. Il suo senso, che è il senso del vero, si estende ad ogni uomo, in qualsiasi circostanza, in ogni epoca e sull’intera superficie terrestre.
Dove c’è un’abdicanza, non c’è dunque nulla? Invece no, qualcosa c’è, ed è il nulla. Pare un gioco di parole, ma se si sta attenti, ci si accorge senza difficoltà che ogni volta che si forma un vuoto, un nulla, qualcosa c’è: ed è proprio quel nulla.
Che esso abbia poi la caratteristica dell’impercettibilità è conseguenza diretta della natura che gli abbiamo attribuito; la quale non è fisico-sensibile; non riguarda pertanto il rapporto conoscitivo che di norma l’uomo può avere con quel che compie lungo il cammino terreno.
Io posso eseguire un’azione come posso anche non attuarla; in questo sono (mi sento) libero. Nel pensare cosí dimentico tuttavia che il fare (cioè, nel caso, il mio aver fatto) è un qualcosa che esiste, è un segno che rimane, e, magari in modo minimo, ha portato nell’esistere una cosa nuova, una cosa che prima non c’era.
Se rinuncio, se mi astengo, se abdico alla mia funzione del fare, del compiere, quella creazione verrà a mancare, e al suo posto ci sarà un vuoto, un nulla.
Un vuoto però, concettualmente parlando, ha lo stesso diritto di esistere quanto un pieno.
«Un momento, un momento – interverrà a gamba tesa il mio amico, dottor de Busillis, che di professione fa l’Ob-Iettatore e ci riesce pure con successo – qui il ragionamento derapa. Se faccio una cosa, potrei, anche senza volerlo espressamente, danneggiare qualcuno; se invece non faccio niente non provoco danni o torti a chicchessia. Ergo; il non fare, l’astenersi, il produrre zero, va sempre bene. Mentre non si può dire altrettanto delle azioni concrete, compiute; quelle sí che possono arrecare conseguenze negative, forse a parti e in tempi insospettati».
Cosa si può rispondere all’ottimo de Busillis (che il Cielo me lo conservi!)? La sua prerogativa fondamentale è quella di non avere mai tutti i torti; lui lo sa bene, e per questo se ne approfitta, facendo passare il resto per oro colato. Lo conosco bene e so che di fronte ai suoi cavilli devo stare in guardia.
Visto cosí sic et sempliciter (lo direbbe pure Tito Livio) se si continua a ritenere il nulla come un inesistente, c’è poco da dire. Chi non fa, non sbaglia, perché lo sbaglio riguarda soltanto quello che si può percepire con i sensi ordinari. Quindi l’assioma vale per l’ambito della ordinarietà, che è lo zoccolo duro del mondo in cui viviamo. E se rifiutiamo di incontrare ogni forma di sviluppo conoscitivo, esso resta l’unico in cui ci possiamo definire vivi, vegeti e concretamente presenti.
Presenti a che? Al mondo ordinario, alla sua apparenza, ai suoi limiti, che per l’appunto vengono assunti e rispettati come fossero sacri. Naturalmente parlo qui di una sacralità basata sul timore, anzi sulla superstizione; che sono una distorsione del concetto di vita e quindi sul rifiuto della sofferenza e della morte che alla vita sono intimamente connessi. Avvinghiati all’ego in modo indissolubile, ci siamo intrappolati nella concezione esistenziale corrispondente, e a tale livello, ma solo a quello, possiamo trovare il coraggio di dirci che il non fare nulla non è un male: mai.
Qui, per correggere questo rachitismo interiore, si potrebbero affermare molte cose; esse inviterebbero ad accedere ad una visione piú ampia della vita e del mondo, a vedere (se non a percepire con l’anima) quel che succede nei risvolti del karma soggettivo e collettivo, di fronte ad una nostra presa di posizione, ovvero di abbandono della medesima.
Bisognerebbe prima convincere i dissenzienti; e ancor prima convincerli di esserlo, giacché non esiste orecchio peggiore di quello che resta chiuso ai silenzi della logica. Tenteremo quindi una strada diversa.
 Chi getta un sasso sull’acqua, osserva fino ad un certo punto il formarsi delle onde concentriche, dopodiché esse non sono piú visibili, e questo autorizza in qualche modo l’osservatore a credere che si siano esaurite; che il suo gesto cioè, abbia definitivamente cessato di produrre effetti consequenziali. Astutamente, fin da qui, l’ego comincia a prepararsi l’assoluzione.
Chi getta un sasso sull’acqua, osserva fino ad un certo punto il formarsi delle onde concentriche, dopodiché esse non sono piú visibili, e questo autorizza in qualche modo l’osservatore a credere che si siano esaurite; che il suo gesto cioè, abbia definitivamente cessato di produrre effetti consequenziali. Astutamente, fin da qui, l’ego comincia a prepararsi l’assoluzione.
La scomparsa visibilità di un fenomeno determina forse la fine del fenomeno stesso? Pensiamo al manifestarsi di una malattia corporea; siamo in grado di seguire l’ingresso o la formazione di virus e batteri estranei al nostro organismo? E una volta guariti, li possiamo forse osservare ritirarsi e andarsene da noi, avviliti per la sconfitta?
Se ci limitiamo ai sensi fisici, viviamo passando ininterrottamente da cause ad effetti che poi ci riportano ancora ad altre cause, senza fermarci mai, e soprattutto senza cogliere l’avvertimento di quel che ci sta succedendo se non quando esso raggiunge il livello della sua maturazione; allora l’informazione diviene esplicita: «Ahi, mamma! Quanto sto male!».
Per quanto riguarda invece il non corporeo, possiamo facilmente immaginare come esso rappresenti il regno di cause ed effetti latenti, striscianti, forse anche cronici o comunque persistenti, dei quali solo terapeuti e psicologi, cosí dicono, sono capaci di svelare l’esistenza e la natura.
Quindi, abbiamo gli elementi sufficienti per comprendere che il non-far-niente, prima cosí acclamato come innocuo e causalmente infecondo, può benissimo venir annoverato come un qualcosa di altrettanto solido e concreto quanto il fare, quanto il commettere.
Un giudice che condanni un imputato ad una certa pena, compie nella storia degli uomini e del mondo un’azione ben precisa; questa avrà tutta la forza e la consequenzialità di quella di un Capo di Stato che conceda la grazia a un condannato che ne abbia avanzato richiesta. Anche se la logica ci dice che il primo fa e il secondo impedisce che una cosa venga fatta, si tratta sempre di due azioni che modificano il corso degli eventi.
La differenza rilevabile nelle serie degli effetti, intendo in tutte le loro ramificazioni, è percepibile con il pensare solo all’origine di quanto si fa o non si fa. Se l’azione nasce sotto la spinta di una volontà condotta e favorita dalla coscienza, allora tutte le ripercussioni future troveranno in questa il loro punto di riferimento. La coscienza le capirà, troverà il modo di spiegarsele e le accoglierà, magari obtorto collo, ma comunque sempre con cognizione di causa, e anche di effetto.
 Se per contro l’azione, oppure la non azione, nel caso che non si voglia compiere un determinato gesto, sarà priva dell’apporto della coscienza, se la capacità di questa è stata affievolita, appositamente smorzata, per evitare quella determiminata decisione, allora gli effetti collaterali, seguendo il planare del boomerang, ritorneranno al mittente, ma non essendo stati prima opportunamente voluti, risulteranno sconosciuti, privi di paternità, e il loro mancato riconoscimento aumenterà il peso della mazzata che si abbatterà sull’improvvido produttore.
Se per contro l’azione, oppure la non azione, nel caso che non si voglia compiere un determinato gesto, sarà priva dell’apporto della coscienza, se la capacità di questa è stata affievolita, appositamente smorzata, per evitare quella determiminata decisione, allora gli effetti collaterali, seguendo il planare del boomerang, ritorneranno al mittente, ma non essendo stati prima opportunamente voluti, risulteranno sconosciuti, privi di paternità, e il loro mancato riconoscimento aumenterà il peso della mazzata che si abbatterà sull’improvvido produttore.
Non si scappa; non è questione metafisica sulla quale poter sollevare obiezioni e contro-obiezioni; le onde concentriche del nostro sassolino gettato nell’acqua non cessano, né cesseranno di prodursi, a livello sempre piú infinitesimale, s’intende, ma questo poco importa. Sono entrati a far parte della rete degli eventi, e per il loro ingresso tutti gli accadimenti del futuro porteranno nei loro corsi la nota impressa della variante subita.
Che dopo tale antefatto l’intreccio dei corsi degli eventi si riposizioni su un nuovo equilibrio, secondo una volontà e una saggezza che sovrasta le umane possibilità di veduta e di comprensione, non cambia la logica del discorso, la quale suggerisce una considerazione che mi permetto di ritenere piuttosto importante.
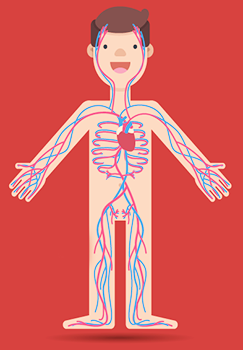 Tutto quello che non viene fatto (ma che si sarebbe potuto fare, in quanto intuibile, concepibile, in parte anche desiderabile e fosse, in via naturale, alla nostra portata) diventa una vera e propria partita recante un segno negativo davanti. In tal caso lo spazio concesso agli eventi dal nostro tirarci indietro, dal chiamarci fuori, viene istantaneamente riempito da altre forme di volontà agenti nel mondo; forme (o forze) che non attendono altro se non un nostro passar di mano; esse allora intervengono e prendono concretezza agendo sulla catena degli accadimenti fino alle ramificazioni piú lontane e rarefatte, mutandone però segno e valenza.
Tutto quello che non viene fatto (ma che si sarebbe potuto fare, in quanto intuibile, concepibile, in parte anche desiderabile e fosse, in via naturale, alla nostra portata) diventa una vera e propria partita recante un segno negativo davanti. In tal caso lo spazio concesso agli eventi dal nostro tirarci indietro, dal chiamarci fuori, viene istantaneamente riempito da altre forme di volontà agenti nel mondo; forme (o forze) che non attendono altro se non un nostro passar di mano; esse allora intervengono e prendono concretezza agendo sulla catena degli accadimenti fino alle ramificazioni piú lontane e rarefatte, mutandone però segno e valenza.
Sbalorditivo! Con il mio voluto non-far-niente ne combino invece di tutti i colori. Quando leggerò sul giornale che Sagunto è crollata, fossi solo un pochino piú saggio, non dovrei stupirmi. Addolorarmi, preoccuparmi, certamente sí, ma non stupirmi.
Tutto ciò può a qualcuno, come ad esempio al dr. de Busillis, apparire esagerato, eppure è bene che anche un Ob-Iettatore di mestiere come lui, si ricordi che un semplice informicamento alle dita dei piedi è sintomo di cattiva circolazione e quindi, se il cuore non ha pompato la quantità di sangue necessaria a percorrere tutti i reticoli dell’apparato, oppure si è verificata in essi una ancorché minima ostruzione, una porzione del corpo, per quanto relativamente distante e non direttamente collegata, ne risente reagendo con immediatezza.
Se parliamo del punto, tutti siamo in grado di capire a cosa alludiamo; ma se diciamo il centro della circonferenza, abbiamo fatto molto di piú: abbiamo caratterizzato l’ambito per cui quel punto vale in quanto punto, ossia l’incontro di tutti i possibili diametri tracciabili all’interno della circonferenza.
La stessa cosa è trasportabile sul non fare; da solo non sta in piedi; erratamente crediamo che non sia cosí, che si regga da sé, che abbia un suo senso. Se sapessimo fin dall’inizio che tale senso non appartiene all’ordine dell’umano, ma diventa alimento per introdurre nel mondo potenze ostili ad ogni evoluzione che non sia puramente fisico-sensibile (ammesso in questo caso che si possa ancora usare il termine “evoluzione”) forse allora potremmo rappresentarci il ruolo giocato dalla nostra coscienza in una visione piú ampia, verace e liberatoria di quella mediante la quale di solito separiamo la realtà concreta dalla rappresentazione astratta.
Ma arrivati al dunque ci troviamo ora di fronte ad un nuovo, piú grande problema; il che dovrebbe confermare la bontà della strada intrapresa, giacché l’opinione di essere pervenuti ad una meta definitiva è già sintomo di malessere interiore, sul quale magari abbiamo fatto consistere e riposare un nostro sogno di vita. Peggio per noi; anche qui in fondo, abbiamo abdicato al pensare, e di conseguenza permesso all’anima un rinsecchimento improprio perché contrario alla sua natura.
La sostanza dell’etica (non s’inorridisca per l’esplicativo materialistico usato, che comunque dovrebbe trovare una sua ragione d’esistere presso una umanità avvezza ai controsensi del linguaggio comune, come il “troppo poco” o l’ “accadere realmente” o lo “spirito consumistico”) viene di continuo formata dalle nostre azioni, dai fatti che ciascuno di noi ha compiuto e sta compiendo. Infatti, anche se reticenti o assenteisti, non possiamo uscire dal settore del fare e del non-fare; quanto andiamo cosí compiendo ha un suo peso in tutti i casi, prevedibili e imprevedibili; in questi ultimi, poi, il peso sarà di gran lunga superiore.
Oggi ho mangiato troppo? Mi sento pesante e svogliato. Oggi ho saltato il pranzo? Il mio stomaco si ribella e reclama cibo. Tutto quello che andrò a compiere partendo da entrambe le condizioni, avrà un suo percorso nel mondo e influirà sull’andamento generale. Il fatto che io non riesca, o non voglia, o non trovi interesse a seguire il progresso effettuale delle mie azioni, è completamente privo di significanza, ai fini del succedersi degli avvenimenti.
Intendo all’accadere di questi, al loro consolidarsi; non al loro valore, non alla loro qualità, non alla loro possibilità di fornire una risposta alla domanda che, compiendo io quell’azione o non compiendola, ho comunque esposto e immesso nel circuito karmico. Ove e in quanto consapevole, ne ricaverò un responso; da inconsapevole, mi troverò solo con un ulteriore evento da subire e con il quale sarò certo di non aver nulla da condividere, tanto per la buona che per la cattiva sorte.
 Eccola qua: la Sorte. Cosí abbiamo deciso di chiamare l’inverarsi di un futuro che ci è sconosciuto perché volutamente assenti a quella parte del suo formarsi che ci compete non per destino ma per destinazione.
Eccola qua: la Sorte. Cosí abbiamo deciso di chiamare l’inverarsi di un futuro che ci è sconosciuto perché volutamente assenti a quella parte del suo formarsi che ci compete non per destino ma per destinazione.
Non è mio desiderio entrare nell’argomento etico, non saprei cosa dire e in tutti i casi, qualsiasi cosa dicessi, molti l’hanno già detta prima e meglio di me. Ma il tema che mi appassiona oggi è questo: come fa l’uomo a produrre karma? Fino a quale punto è in grado di farlo? Perché lo fa? Vi è forse costretto?
Come si vede l’argomento è vasto, supera di molto le mie possibilità, questo tuttavia non è un buon motivo per impedirmi di ragionarci sopra. Sono stato instradato verso questo particolare compito da letture, studi e considerazioni che ho potuto recentemente svolgere dopo aver incontrato la famosa opera di Jacques Monod, Il Caso e la Necessità, e altri libri di scienza divulgativa, redatti pochi anni or sono, che in qualche modo hanno fatto le chiose al primo, ponendo in evidenza le parti obiettivamente condivisibili e quelle ancora non esaurientemente spiegabili.
Forte delle tecniche e delle esperienze attuali, la Scienza si chiede quale possa essere il segreto della materia; come sia possibile la trasmissione tra particelle elementari di informazioni in tempi, forse, ancora piú rapidi della velocità della luce; come sia possibile che la Seconda Legge della Termodinamica, ritenuta principio valido e operante in tutto l’universo conosciuto, possa, a volte, venir contraddetta anche attraverso semplici esperimenti di laboratorio; e, tanto per finire, a quale scopo, verso quale meta, la materia agisce come agisce, dal momento che la teoria genericamente diffusa di un universo privo di qualunque traguardo, è diventata sempre piú ardua da affermare.
Parto dalle informazioni: dicono che le particelle comunicano fra loro, ignorando tempo e distanze; che sappiano adeguare i loro andamenti alle informazioni ricevute. Si parla quindi di comunicare e di informare. Tuttavia ho la netta sensazione che qui si debba introdurre un verbo che descriva un’azione diversa da quelle dell’informare e del comunicare. Intendo, l’apprendere.
Mi pare evidente che se comunico qualcosa a qualcuno, il quale, in base alla mia notizia, assume un nuovo atteggiamento e s’induce ad azioni che senza la mia comunicazione non avrebbe fatto, costui debba avere in sé la caratteristica essenziale non limitata al capire, ma anche dell’apprendere. Questo apprendere è un’applicazione del capire, ma non è necessitata, in quanto è sempre possibile capire una comunicazione, e di seguito ignorare ciò che essa suggerisce.
Apprendere significa afferrare il senso di una cosa, accettarla, accoglierla e decidere di trasferirla nel proprio comportamento. Mentre soprappensiero cammino in mezzo alla strada e sento qualcuno che grida: «Attento al bus!», mi fermo di colpo. Non so se ho fatto bene o male, ma qui volevo soltanto illustrare il mio cambiamento immediato di programma dovuto all’avvertimento. Frutto dell’istintività, di un riflesso poco cosciente.

Gianni Fochi «La cavallina storna»
Quando, per contro, a scuola l’insegnante dette a tutti l’ordine d’imparare a memoria “La Cavalla Storna” di Giovanni Pascoli, io – ricordo bene – mi rifiutai di eseguire la comunicazione perché non amavo quel tipo di poesia e mi rifiutavo di mandarla a memoria. Questa fu una decisione cosciente di non fare.
L’apprendimento è quindi un sostantivo in cui interviene la volontà; non basta essere informati, non basta capire, bisogna anche volere, ossia ritenere la notizia buona, giusta e utile per i propri interessi, e di conseguenza farla nostra per favorire il cammino cui i nostri impegni mirano.
Sarà forse questo l’elemento, tanto ricercato ma sempre sfuggente, che separa la categoria dell’inanimato da quella del vivente consapevole d’esserlo?
Non desidero discorsetti sulla moralità; voglio tuttavia capire come essa sorga in corrispondenza a comunicazioni e informazioni che la situazione in cui siamo immersi ci porge costantemente.
Sappiamo, almeno quanti seguono l’Antroposofia di Rudolf Steiner sanno, come il molteplice mondo delle percezioni attivi la nostra facoltà pensante. Mi pare che si possa trarre un’analogia con il mondo delle relazioni transindividuali. Dal momento che esisto, mi relaziono senza sosta con la vita, con gli esseri, con i fatti e le vicende che la riempiono e la compongono. Da queste relazioni derivano i vari aspetti della mia condotta; ogni atteggiamento umano si attiva grazie alla sollecitazione di presenze con le quali bisogna prendere, mantenere o chiudere un contatto.
Tutto questo ricorda i recenti risultati della meccanica quantistica. Nessuno scienziato si è mai sognato finora di attribuire a particelle di materia le facoltà del pensare, sentire e volere; tuttavia gli esperimenti fatti, sia nel microcosmo sia nel macrocosmo, fanno intuire che quando la materia passa da uno stadio che potremmo definire d’inerzia, a quello vitale (almeno vegetativo) i suoi comportamenti possono in certi casi cessare di seguire le regole, che per lo status precedente erano invece rigide e invalicabili.
Soffermandoci ancora un momento sulla Teoria dei Quanti, impariamo che il flusso di energia (qualunque energia, nucleare, termica, eolica, ma io ci aggiungerei anche l’energia vitale, lasciando ciascuno libero di interpretarla come vuole, purché estesa alla massima potenzialità) non procede in modo continuativo, bensí “a salti”, o per dir meglio, “a pacchetti”: i famosi “quanti”.
Mentre nella nostra abituale dimensione quotidiana, tale fatto non è minimamente recepibile, e luce, calore, vitalità sembrano aumentare o calare in modo progressivo e graduale, nel “micro” e nel “macro” le cose si dispongono in modo che quella benedetta continuità alla quale ci siamo abituati, sparisca. E l’energia – ci dicono – si propaga tramite “pacchetti”, ognuno dei quali rappresenta una sua porzioncina, un quantum. Se fosse da meno, non sarebbe piú energia operativa, ma probabilmente solo energia allo stato potenziale.
Ho cercato nella mia testa un ricordo della mia esperienza esistenziale, con la quale mi dibatto da parecchi anni e spesso col dott. de Busillis, un aggancio per poter paragonare questi “quanti” a qualche cosa di già noto, qualche cosa di simile, con il quale poter tirare una connessione, un parallelismo: rinvenire insomma una traccia.
Cosí mentre a Roma si perde tempo in consultazioni autoreferenziali, c’è chi muove i pensieri in direzioni insolite e sostanzialmente irrilevanti. Ma mi sono convinto che è proprio qui che si entra in quella dimensione (se a qualcuno apparirà del tutto astratta, non sarò io a dargli torto) dalla quale traggono origine i fatti, gli accadimenti, con i quali – spesso costernati – ci troviamo a dover affrontare.
Venire a sapere che Sagunto è caduta con il concorso della mia inettitudine, non lenisce la batosta, ma è il costo da pagare per l’ampliamento del mio stato di coscienza. D’ora in poi sarò in grado di vedere un po’ piú in là del mio naso, e al momento opportuno avrò un maggior pudore nel dire: «Qui io non c’entro; me ne sono astenuto e quindi non ho fatto proprio nulla».
Questo rinnovato sperimentare ha l’obiettività, e oserei dire la purezza, del non pretendere nulla, del non voler modificare il corso degli eventi, ma solo poterli contemplare, normalmente si usa dire “in controluce”. Voglio precisare meglio: poterli contemplare “tra due luci”, quella primaria, da cui vengono, e quella del tutto secondaria, ma forse piú importante perché volontaria, emessa dal ricercatore che indirizza loro il suo pensare.
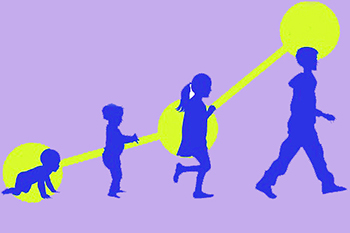 Seguire un’evoluzione in corso di sviluppo ci fornisce l’esperienza di porre volta per volta dei punti fermi e affermare: fin qui è cosí, ma d’ora in poi si cambia registro. Vale ad esempio per le stagioni, per i mesi, per tutto quello che procede nel tempo e che noi disponiamo a scomparti. La stessa cosa si potrà asserire per l’istruzione, o l’apprendimento scolastico da parte dei bambini. Nelle elementari si studia in un dato modo, che verrà poi ripreso nelle medie inferiori, nelle medie superiori e cosí via; ma ogni volta ad un livello che non esclude quelli precedenti, però li integra in una prospettiva piú ampia e articolata. Non sarà essa la definitiva; tuttavia per il quadro culturale stabilito dalle leggi e dalle regole di condotta della società, appare sufficiente.
Seguire un’evoluzione in corso di sviluppo ci fornisce l’esperienza di porre volta per volta dei punti fermi e affermare: fin qui è cosí, ma d’ora in poi si cambia registro. Vale ad esempio per le stagioni, per i mesi, per tutto quello che procede nel tempo e che noi disponiamo a scomparti. La stessa cosa si potrà asserire per l’istruzione, o l’apprendimento scolastico da parte dei bambini. Nelle elementari si studia in un dato modo, che verrà poi ripreso nelle medie inferiori, nelle medie superiori e cosí via; ma ogni volta ad un livello che non esclude quelli precedenti, però li integra in una prospettiva piú ampia e articolata. Non sarà essa la definitiva; tuttavia per il quadro culturale stabilito dalle leggi e dalle regole di condotta della società, appare sufficiente.
Chi vuole potrà anche vedere in questo percorso dei segmenti, delle frammentazioni ben pronunciate, intervallate da esami e da passaggi di livello alquanto notevoli. Sono i gradi che misurano in qualche modo la maturazione degli scolari e degli studenti, e, sia pure per grandi linee, ha una sua attinenza con la crescita dei soggetti, intesa non solo in senso fisico ma soprattutto interiore e psicologico. Alla fine degli anni dedicati all’apprendimento, ci si ritrova pressoché adulti; guardando indietro si accoglie l’insieme del percorso compiuto come elemento portante indispensabile al raggiungimento di un livello standard di formazione culturale e gnoseologica.
Quindi, come per i quantum d’energia, anche noi maturiamo “a pacchetti”; e gli intervalli tra un pacchetto e quello successivo sono l’attesa del suo realizzo. Attesa che è preparazione, mai afferrabile in quanto tale, perché il suo formarsi goccia a goccia, resta celato ai sensi comuni, un po’ come la crescita impercepita, ma continua, di capelli e unghie. Arriva il giorno in cui ci si dice: «Guarda che roba! Devo assolutamente darmi una regolata». Ci si accorge cioè del fenomeno fatto, non del suo farsi.
Cosa pensare se tale pensiero viene adesso rivolto per analogia a quell’alternanza di spirito e materia che l’antroposofia chiama “il succedersi delle ripetute vite terrene”? Non è forse una singola vita, essa stessa una parte (lascio perdere il termine “pacchetto” che qui sinceramente svilisce l’assunto) di una lunga trafila di fattori con i quali andiamo a comporre, dentro l’eternità, la strada verso l’IoSono? E l’esistere di ciascuno, non è l’occasione (probabilmente ogni volta unica) di apprendere il segreto di fare, o di rinunciare a fare, dentro le leggi della materia e quelle della dimensione spazio-temporale, incidendole e lasciandovi in tutti i casi ampia traccia di sé?
In conclusione, Max Planck è stato in grado di rilevare che nell’universo l’andamento dell’energia-materia, o della materia-energia (datasi la reversibilità ampiamente dimostrata) funziona secondo un principio che all’inizio non si direbbe appartenere al mondo fisico fin qui noto e conosciuto; eppure essa è già in atto (e da tempi remoti) anche nel mondo degli uomini, ove però questi ultimi considerino se stessi non solo come semplici aggregati molecolari autogestiti, ma come organismi vitali capaci di riflettere in sé misteri remoti di forze ancora sconosciute e di dirigere a quelle la loro piú intima essenzialità. In qualunque modo: anche sbagliando, anche tradendo, anche recuperando.
In ultima analisi, il macrocosmo ci presenta sistemi complessi cui riferiscono determinati processi e percorsi, non confrontabili con quelli in cui ci destreggiamo; altrettanto dicasi di quel che siamo venuti a conoscere del microcosmo, ove molecole, atomi, elettroni e compagnia bella continuano il loro modus operandi secondo le regole infinitesimali dei sistemi semplici, che ci appaiono ancora in gran parte estranee.
Eppure proprio come gli umani, come le loro epoche e le civiltà via via costruite, aspirando al progresso e al miglioramento, precipitano talvolta in situazioni per cosí dire totalmente involute e regressive, cosí i sistemi complessi tendono nel tempo a frantumarsi in sistemi semplici, e altrettanto fanno questi ultimi, quasi insoddisfatti della loro situazione, con il mirare a riunirsi e a sviluppare in tal modo sistemi complessi del tutto nuovi.
Il fatto (uno dei pochi da cui possiamo escludere in toto la nostra ingerenza) di essere destinati a mantenere un particolare equilibrio tra queste due sconfinate dimensioni extraumane e tuttavia contigue, fino al punto di doverlo ricercare solo attraverso un progredito pensare volente, potrebbe già offrirci una chiave per interpretare quelle grandi domande che nel 1897 Gauguin volle stigmatizzare nel celebre dipinto “dei tre interrogativi”.
 Se a Roma si perde tempo in chiacchiere e battibecchi inutili, e nel frattempo da qualche parte accadono disastri irrimediabili, non è soltanto una frase indicante la concomitanza di una causa col suo effetto; è piuttosto un monito da cui possiamo ricavare un significato profondo, obiettivo e inesorabile: se non smetti di cincischiare, non ti rimbocchi le maniche e non cominci ad agire di prima persona, altri esseri (non necessariamente umani) prenderanno il tuo posto e compiranno a loro modo quelle azioni alle quali ti sei negato.
Se a Roma si perde tempo in chiacchiere e battibecchi inutili, e nel frattempo da qualche parte accadono disastri irrimediabili, non è soltanto una frase indicante la concomitanza di una causa col suo effetto; è piuttosto un monito da cui possiamo ricavare un significato profondo, obiettivo e inesorabile: se non smetti di cincischiare, non ti rimbocchi le maniche e non cominci ad agire di prima persona, altri esseri (non necessariamente umani) prenderanno il tuo posto e compiranno a loro modo quelle azioni alle quali ti sei negato.
Qui farò bene a concludere perché da un po’di tempo in qua, l’amico dott. de Busillis sta dando segni inequivocabili d’insofferenza. “Incompleto, ambiguo, impreciso” e oltretutto anche “inconcludente” sono gli aggettivi meno duri che sta elevando nei miei confronti.
Vorrei rassicurarlo: non miro a grandi cose, in fondo questo mio scritto, come molti altri che l’hanno preceduto, rappresenta solo dei momenti di sfogo, di temi appena abbozzati, parziali, ma pure intimi come le pagine di un diario. O magari di un manoscritto che un naufrago infila in una bottiglia prima di buttarla in mare e affidarla alle onde.
Mi rimane però il dubbio di volerlo fare per poter osservare meglio i cerchi concentrici sollevati nell’impatto con l’acqua e studiarli da vicino ancora una volta.
Angelo Lombroni
