 «Ma dell’albero della Conoscenza del Bene e del Male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti» (Genesi 2, 17).
«Ma dell’albero della Conoscenza del Bene e del Male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti» (Genesi 2, 17).
Discorso, quello che Jahve tenne al primo uomo, Adamo, per questi poco comprensibile, dato che la morte non esisteva nel mirabile Giardino dell’Eden, al cui centro, tra gli altri alberi carichi di frutti, oltre a quello dei frutti proibiti, troneggiava l’Albero della Vita. Ma fu proprio la morte, oltre ai dolori del parto per la donna e al sudore della fronte per il faticoso lavoro della terra per l’uomo, la pena terminale inflitta per la disobbedienza. Pena derivata dalla caduta nella tentazione luciferica.  Da quella insubordinazione nacque, nell’interiorità di Adamo e di Eva, e in seguito dei loro discendenti, la possibilità di ergersi con arroganza contro l’ordine universale delle cose e della vita planetaria. Al punto che se un altro individuo confliggeva con il loro essere, potevano arrivare a contrastarlo fino a dargli la morte, stabilendo cosí il proprio predominio.
Da quella insubordinazione nacque, nell’interiorità di Adamo e di Eva, e in seguito dei loro discendenti, la possibilità di ergersi con arroganza contro l’ordine universale delle cose e della vita planetaria. Al punto che se un altro individuo confliggeva con il loro essere, potevano arrivare a contrastarlo fino a dargli la morte, stabilendo cosí il proprio predominio.
Questo il perverso, quanto risolutivo pensiero che armò la mano di Caino, quando si accorse che le offerte del fratello Abele erano gradite agli dèi piú delle sue, insidiando i suoi disegni suprematisti. Iniziava in tal modo la dolente catena degli omicidi che una altrettanto perversa idea della necessità avallava. Chi uccideva, per quanto assurdo, obbediva a un principio di ripristino del diritto egualitario alla vita: della propria persona all’inizio, poi del proprio clan, della famiglia, della comunità, e via via fino alla difesa di princípi egualitari di genti e paesi che con la sua persona poco avevano a che fare.
Ci fu poi il grande diluvio. A quei tempi la Divinità ristabiliva l’ordine universale mediante castighi catastrofici, di vasta portata, che facessero tornare la creatura insubordinata all’osservanza delle regole geocosmiche. Ma l’uomo, mangiando il frutto proibito, aveva voluto chiaramente indicare quale sarebbe stata la sua scelta in ogni frangente della sua vicenda umana, in particolare il suo diritto a contrapporsi ai dettami impostigli dall’Alto. A spalleggiarlo, il Consigliori dell’Albero delle Mele, presente ormai al suo fianco, per ogni necessità. E quale necessità piú stringente per l’uomo in divenire che la tutela della propria facoltà di esistere!
La vicenda è nota: dopo quaranta giorni e quaranta notti di pioggia a catinelle – la prima quarantena – l’Arca costruita e pilotata da Noè, una promiscua convivenza di umani e animali, abbordò l’Ararat. Chi abbia viaggiato in Turchia, ha presente nella memoria, in modo indelebile, il culmine del favoloso monte, oltre il quale si indovinano il Karakorum e l’Hindukush, le steppe mongoliche e i grandi fiumi dell’Asia, che il mito assegna alla formazione della Terra originaria da cui tutti veniamo.
 Ebbene, l’Arca galleggiava con il suo carico promiscuo, belante, ruggente, stridente, sibilante, insieme ai suoni che in cadenza, ora morbidi e suadenti ora aspri e taglienti, formavano il primitivo linguaggio degli uomini di quell’epoca, espressivo di pensieri e sentimenti che le traversíe esistenziali suscitavano in loro. Quelli che Noè traghettava fuori dal Diluvio, al di là della contrizione per la scarsa fiducia in Dio e nel nocchiero dimostrata durante la costruzione dell’Arca e sul criterio che aveva ispirato il carico, avevano molto da ridire, assolta la disagiata convivenza, sulle vettovaglie, risicate in quantità e gusto. E piú grande fu la frustrazione allorché, ancorata l’Arca alla montagna fatale dell’Ararat, ci si accorse che, buone o cattive che fossero nel sapore, erano del tutto esaurite nella quantità. E ancor peggio, scesi dall’imbarcazione, si resero conto che l’acqua caduta dalle cataratte del cielo per quel lungo periodo, aveva annacquato la Terra rendendola inadatta a fornire mezzi di sostentamento. Dunque, la fame, ecco cosa tormentava i trasportati, piú ancora della collera dell’Altissimo.
Ebbene, l’Arca galleggiava con il suo carico promiscuo, belante, ruggente, stridente, sibilante, insieme ai suoni che in cadenza, ora morbidi e suadenti ora aspri e taglienti, formavano il primitivo linguaggio degli uomini di quell’epoca, espressivo di pensieri e sentimenti che le traversíe esistenziali suscitavano in loro. Quelli che Noè traghettava fuori dal Diluvio, al di là della contrizione per la scarsa fiducia in Dio e nel nocchiero dimostrata durante la costruzione dell’Arca e sul criterio che aveva ispirato il carico, avevano molto da ridire, assolta la disagiata convivenza, sulle vettovaglie, risicate in quantità e gusto. E piú grande fu la frustrazione allorché, ancorata l’Arca alla montagna fatale dell’Ararat, ci si accorse che, buone o cattive che fossero nel sapore, erano del tutto esaurite nella quantità. E ancor peggio, scesi dall’imbarcazione, si resero conto che l’acqua caduta dalle cataratte del cielo per quel lungo periodo, aveva annacquato la Terra rendendola inadatta a fornire mezzi di sostentamento. Dunque, la fame, ecco cosa tormentava i trasportati, piú ancora della collera dell’Altissimo.
«Ma io, allora, che ci sto a fare?» sibilò il Tentatore, che dopo il colpo barbino dell’Albero dal Frutto Proibito si era assunto il compito di fare dell’uomo un contestatore alla potenza. E fu certamente lui che insinuò nella mente degli occupanti dell’Arca la possibilità di reclamare lo stato di necessità, il diritto di sopravvivenza della specie, che tra l’altro rappresentava la posta in gioco nella contesa tra Cielo e Abisso, tra Luce e Tenebra, tra Morte e Vita. E stando sempre alle Scritture, l’Eterno consentí all’uomo, pena il fallimento per inedia del progetto di angelicazione della creatura umana, di cibarsi degli animali, proprio quelli che Noè aveva salvato dal Diluvio. Si eresse allora un altare all’esterno del naviglio, e si fece del mattatore un sacerdote che, uccidendo la vittima, compiva un atto sacro.
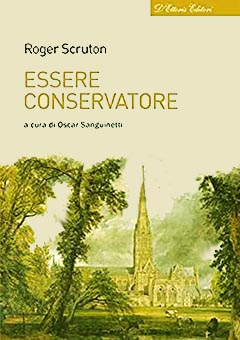 Che l’uccisione della vittima fosse un atto sacro lo ha affermato il filosofo inglese Roger Scruton. Nel suo libro Essere conservatore Scruton afferma che i diritti sono come le briscole, “vincono sempre”, secondo il concetto che se in tribunale si può dimostrare che il proprio interesse nella causa è riconosciuto come diritto, la causa è vinta. Nelle sue Riflessioni filosofiche per un’apologia dell’ars venandi Scruton dà il colpo di grazia alla volpe, riconoscendo che il diritto a essere dell’animale devastatrice di pollai confligge con quello degli allevatori di polli, quindi la caccia stabilisce il principio del diritto romano che dice “ubi maior minor cessat”.
Che l’uccisione della vittima fosse un atto sacro lo ha affermato il filosofo inglese Roger Scruton. Nel suo libro Essere conservatore Scruton afferma che i diritti sono come le briscole, “vincono sempre”, secondo il concetto che se in tribunale si può dimostrare che il proprio interesse nella causa è riconosciuto come diritto, la causa è vinta. Nelle sue Riflessioni filosofiche per un’apologia dell’ars venandi Scruton dà il colpo di grazia alla volpe, riconoscendo che il diritto a essere dell’animale devastatrice di pollai confligge con quello degli allevatori di polli, quindi la caccia stabilisce il principio del diritto romano che dice “ubi maior minor cessat”.
Si è persa una buona occasione per un discorso animalista serio alle prime avvisaglie del Coronavirus, sul finire del mese di dicembre 2019. Venne denunciato il sistema delle macellazioni dei mercati all’aperto cinesi, nel caso specifico a Vuhan, supposto focolaio del virus, in cui ha luogo la mattanza di animali a sangue caldo , come gibetti, pangolini e altri animali fornitori di carne a basso costo. Da uno o piú di questi animali, uccisi sul posto, sarebbe partito uno spillover, un getto ematico portatore del fattore patogeno dal quale sarebbe partita la pandemia. Il condizionale è d’obbligo, essendo il Dragone sotto schiaffo per la crescita fenomenale dovuta all’aumento dei redditi: due miliardi di persone approdate in un tempo brevissimo a un benessere che nel 2010 ha superato quello degli USA, calcolando il consumo energetico.
Ecco allora invocare a livello internazionale punizioni esemplari contro la Cina, che non ha capito la lezione, riaprendo i mercati alimentari all’aperto con le macellazioni non protette di cani, pipistrelli, zibetti e simili, parlando apertamente di torture inflitte prima della macellazione. Insomma, si è preferito spostare il discorso sull’animalismo ecologico, massimamente dietetico. Ecco allora tirare fuori Plutarco, il patriarca dei vegetariani, e Pitagora, idem, e poi Porfirio, col suo trattato Astinenza dagli animali, il primo testo filosofico dell’antichità sulla dieta vegetariana. E che dire poi del grande Leonardo da Vinci, i cui bozzetti di gigantesche macchine culinarie, come il trita-manzo, vero arnese di sevizie, appaiono nel Codex Romanoff, un reperto considerato dagli esperti non autentico, contenente ricette dedicate ai fastosi banchetti imbanditi per Ludovico il Moro, un manuale edito dall’editore inglese Voland, Note di cucina di Leonardo da Vinci.
Scrive Omraam Mikhael Aivanhov nel suo libro Il vegetarianesimo e il veleno contenuto nella carne prodotto dalla paura: «Avete mai pensato a cosa sentono gli animali nei macelli? Sono sensibili, a volte molto piú dell’uomo. Quale paura, che spavento e che rivolta li agitano e li turbano! Percepiscono ciò che li aspetta! Non possono esprimerlo ma le loro ghiandole reagiscono, secernendo ed emettendo degli umori carichi del loro odio e della loro angoscia: è un vero e proprio veleno che immettono prima nel loro sangue e poi in tutte le cellule del loro corpo. I Maestri conoscono quel veleno e gli scienziati lo scopriranno presto. Ogni discepolo deve osservarsi per diventare cosciente di ciò che accade in lui. A seconda di ciò che mangia, beve e respira. Quel veleno, che è il risultato della paura, non può essere neutralizzato o eliminato dalla carne né con la cottura né con il lavaggio, si diffonde ed agisce nell’organismo dell’uomo.
 In apparenza, la guerra è dovuta a questioni economiche o politiche, ma di fatto è il risultato di tutto il massacro che facciamo degli animali. La legge di giustizia è implacabile e obbliga l’umanità a pagare versando tanto sangue quanto quello che gli uomini hanno fatto versare agli animali. Quanti milioni di litri di sangue sparsi sulla terra gridano vendetta verso il Cielo! L’evaporazione di quel sangue attira non solo dei microbi, ma anche miliardi di larve e di entità inferiori del mondo invisibile. Noi uccidiamo gli animali, ma la Natura è un organismo, e uccidendo gli animali è come se toccassimo certe ghiandole di quell’organismo; a quel punto, le funzioni si modificano, e dopo qualche tempo scoppia una guerra tra gli uomini. Sí, perché si sono massacrati milioni di animali per farne cibo, senza sapere che essi erano legati a degli uomini, e quegli uomini devono quindi morire con essi. Uccidendo gli animali, si uccidono gli uomini. Tutti dicono che deve regnare la pace nel mondo, che non devono esserci guerre. …Ma la guerra durerà finché noi continueremo a uccidere gli animali, perché uccidendoli, è in noi stessi che distruggiamo qualcosa».
In apparenza, la guerra è dovuta a questioni economiche o politiche, ma di fatto è il risultato di tutto il massacro che facciamo degli animali. La legge di giustizia è implacabile e obbliga l’umanità a pagare versando tanto sangue quanto quello che gli uomini hanno fatto versare agli animali. Quanti milioni di litri di sangue sparsi sulla terra gridano vendetta verso il Cielo! L’evaporazione di quel sangue attira non solo dei microbi, ma anche miliardi di larve e di entità inferiori del mondo invisibile. Noi uccidiamo gli animali, ma la Natura è un organismo, e uccidendo gli animali è come se toccassimo certe ghiandole di quell’organismo; a quel punto, le funzioni si modificano, e dopo qualche tempo scoppia una guerra tra gli uomini. Sí, perché si sono massacrati milioni di animali per farne cibo, senza sapere che essi erano legati a degli uomini, e quegli uomini devono quindi morire con essi. Uccidendo gli animali, si uccidono gli uomini. Tutti dicono che deve regnare la pace nel mondo, che non devono esserci guerre. …Ma la guerra durerà finché noi continueremo a uccidere gli animali, perché uccidendoli, è in noi stessi che distruggiamo qualcosa».
Eppure, sempre dalle Scritture apprendiamo che all’origine l’uomo era un raccoglitore di bacche, frutti e verdure. Un fruttariano, dunque, un raccoglitore prima e un agricoltore poi: un contadino. Nello scenario primordiale, la natura nutriva imparzialmente uomini e animali con la stessa materia: il frutto della terra. Quasi un idillio campestre, che tuttavia cozzava sia con il disegno finale del Divino sia con la strategia di dannazione che il Tentatore covava, insonne e infaticabile. Nell’atto di ricavare dalla Madre Terra di che nutrire se stesso e gli esseri che dividevano con lui le risorse naturali, cibo agricolo e acqua, non c’era intento distruttivo, annichilente. Cibandosi del pomo e della pianta, l’uomo non causava la morte di un essere vivente, anzi spesso ne aiutava la crescita e persino il miglioramento della specie.
 Su questo punto, gli anti-vegetariani imbastiscono da anni una polemica con chi si astiene da una dieta carnea, adducendo il fatto che sradicare una rapa per cibarsene equivale a causare la morte di un vivente, con un’implicita sofferenza, un dolore materico dovuto a uno strappo, un distacco dal complesso vitale in cui la pianta vive e vegeta. Un cavillo strumentale cui Rudolf Steiner risponde nel suo Il sangue è un succo peculiare: «Alcuni scienziati moderni affermano che anche alle piante sia da attribuire direttamente la sensazione. È però solo un gioco di parole. Per certe piante avviene senz’altro che reagiscano a delle sollecitazioni, se qualcosa viene loro vicino, se qualcosa agisce su di loro, ma questo non è ancora sensazione. Perché lo sia, occorre che nell’interiorità dell’essere sorga un’immagine, quale riflesso della sollecitazione. Se anche in certe piante avviene una reazione a seguito di un’azione esterna, questo non è ancora una prova che la pianta abbia portato interiormente la reazione a diventare sensazione, che essa interiormente senta. Quel che si sente interiormente ha la sua sede nel corpo astrale».
Su questo punto, gli anti-vegetariani imbastiscono da anni una polemica con chi si astiene da una dieta carnea, adducendo il fatto che sradicare una rapa per cibarsene equivale a causare la morte di un vivente, con un’implicita sofferenza, un dolore materico dovuto a uno strappo, un distacco dal complesso vitale in cui la pianta vive e vegeta. Un cavillo strumentale cui Rudolf Steiner risponde nel suo Il sangue è un succo peculiare: «Alcuni scienziati moderni affermano che anche alle piante sia da attribuire direttamente la sensazione. È però solo un gioco di parole. Per certe piante avviene senz’altro che reagiscano a delle sollecitazioni, se qualcosa viene loro vicino, se qualcosa agisce su di loro, ma questo non è ancora sensazione. Perché lo sia, occorre che nell’interiorità dell’essere sorga un’immagine, quale riflesso della sollecitazione. Se anche in certe piante avviene una reazione a seguito di un’azione esterna, questo non è ancora una prova che la pianta abbia portato interiormente la reazione a diventare sensazione, che essa interiormente senta. Quel che si sente interiormente ha la sua sede nel corpo astrale».
Tenendo il filo del discorso su azioni che possono produrre la condizione di ‘non essere’ in un vivente, c’è da aggiungere al pensiero del Dottore la precisazione puramente organica del fatto che l’insalata, la carota, la patata, la mela e qualunque creatura arborea, se recisi, espiantati, brutalizzati posseggono la virtú eterica del rinascere, del rifiorire e riprodursi da un semplice lacerto radicale, da un seme, da un innesto.
 Ciò non dato (finora?) alle specie animali se non grazie al mistero della fecondazione genetica. Un dito amputato non ricresce. Cosí come non risorge da morte la figlia di Giairo, o Lazzaro dal buio di un sepolcro, a meno che un segno della Mano, la vibrazione di una Voce non richiami alla vita anime che già si erano incamminate verso la vera Luce. Dal non essere piú all’essere ancora. Riprendere la vita del corpo, e piú ancora quella arcana dell’anima nella pulsione dell’eterico.
Ciò non dato (finora?) alle specie animali se non grazie al mistero della fecondazione genetica. Un dito amputato non ricresce. Cosí come non risorge da morte la figlia di Giairo, o Lazzaro dal buio di un sepolcro, a meno che un segno della Mano, la vibrazione di una Voce non richiami alla vita anime che già si erano incamminate verso la vera Luce. Dal non essere piú all’essere ancora. Riprendere la vita del corpo, e piú ancora quella arcana dell’anima nella pulsione dell’eterico.
Solo un Dio può comandare alle forze immateriche perché vivano o resuscitino. Sono i miracoli di potenza che appartengono agli Dei. All’uomo, non ancora divinizzato, preda del delirio di onnipotenza indotto dall’antico Tentatore, non riesce di sottrarsi alla smania di provocare, scambiando il delitto per potestà sulla materia, l’annullamento della vita nella natura, nelle creature, in se medesimo.
Le Scritture e il mito ci dicono che la mattanza degli animali iniziò alla fine del Grande Diluvio, ed ebbe come causa lo stato di necessità: mors tua vita mea. Furono ragioni invocate dall’uomo per la sopravvivenza, ma a scapito della mancata sopravvivenza di altri esseri senzienti. Sopprimendo la vita, qualunque forma di vita animata, come appunto quello degli animali, cosí chiamati non solo perché dotati di movimento, ma perché dotati di un’anima, l’uomo infrange il comandamento “non uccidere”, il cui danno al contesto creativo è irreparabile. Una vita recisa non si ricompone, né si replica nella sua irripetibile sostanza ed essenza. Non rubare è riparabile, restituendo al proprietario il bene sottratto. Cosí il rispetto che si deve al padre e alla madre, se mancante oggi, può darsi domani, e cosí un atto impuro può essere redento con la contrizione del cuore. Ma togliere la vita offende il fine ultimo della creazione: permettere ad esseri senzienti, tabernacoli viventi dell’Io Sono, di compiere la missione per la quale sono venuti al mondo.
 Il macellaio cinese di Wuhan non è piú crudele e irresponsabile del suo collega romano che reclamizza la sua abilità nel togliere la vita a un essere vivente per la goduria gastronomica di uno sconosciuto gourmet. Negli abatoires francesi decine di anatre, già prima torturate negli allevamenti, vengono soppresse per il “foie gras”, e altrettanti maiali finiscono nei “cru” in Italia dopo trattamenti che disturberebbero persino il norcino cinese di Wuhan. E il vegetarianesimo, anche se virato in una piú severa dieta vegana, non rende migliore colui che pratica quel regime, se lo fa solo dal punto di vista dietetico e non da quello etico.
Il macellaio cinese di Wuhan non è piú crudele e irresponsabile del suo collega romano che reclamizza la sua abilità nel togliere la vita a un essere vivente per la goduria gastronomica di uno sconosciuto gourmet. Negli abatoires francesi decine di anatre, già prima torturate negli allevamenti, vengono soppresse per il “foie gras”, e altrettanti maiali finiscono nei “cru” in Italia dopo trattamenti che disturberebbero persino il norcino cinese di Wuhan. E il vegetarianesimo, anche se virato in una piú severa dieta vegana, non rende migliore colui che pratica quel regime, se lo fa solo dal punto di vista dietetico e non da quello etico.
È la vita che lo esige.
Leonida I. Elliot

