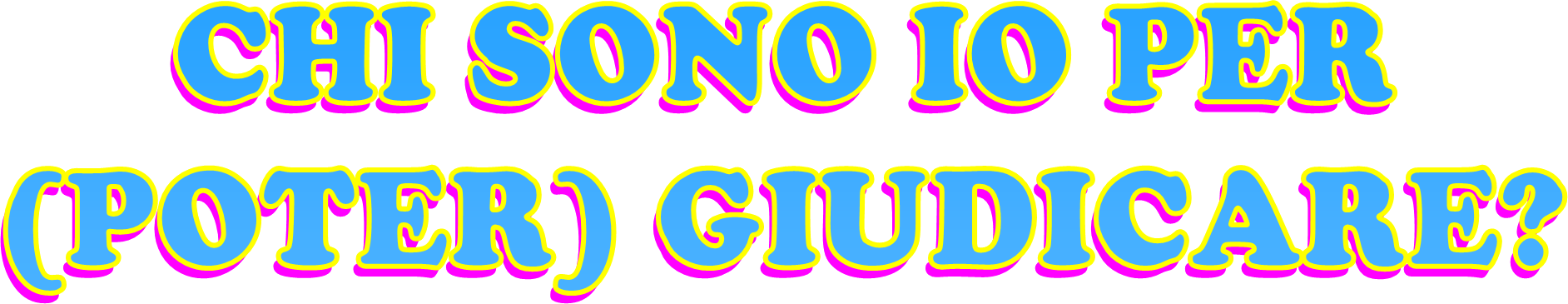Bella domanda: impegnativa. Specialmente se rivolta alla propria coscienza in una di quelle particolari situazioni in cui essa sembra aspirare ad un momento tutto suo. Sono un giudicante o sono un giudicatore? C’è una differenza non da poco tra le due posizioni; la prima infatti è caratterizzata dalla estemporaneità (sono capitato lí per caso e mi è stato richiesto un parere per dirimere una questione); la seconda, giudicatore e/o giudice, riferisce a uno status, a un incarico che, apparso un tempo utile alle società umane in via di sviluppo, onde stabilire un po’ d’ordine tra pubblici traguardi e mire personali, sia stato in seguito riconosciuto come dotta professione cui ricorrere qualora le mire e i traguardi accennati si scontrassero per caso o confliggessero di necessità.
Il verbo “potere” che appare nel titolo (prudentemente tra parentesi) è la discriminante con la quale vorrei oggi capire qualcosa di piú in merito a questa faccenda; una specie di semaforo che si mette agli incroci per contenere le intemperanze degli automobilisti indisciplinati. È un rimedio parziale, lontano dalla soluzione definitiva del problema, ma in mancanza di maturazione civile e protocolli efficaci, nel frattempo aiuta e collabora.
L’atto del giudicare è insito, direi connaturato, nell’essere umano. Si percepiscono le cose, e quindi si valutano, si scelgono, si distinguono, si classificano; si costruiscono regole, teorie, leggi, che poi vengono modificate nel corso del tempo se non ribaltate, e cosí via; ma il fondamento rimane intatto; “veni, vidi, iudicavi”.
Non occorre riandare con la mente ai grandi procedimenti giudiziari della storia, non serve tirare in ballo il Caso Dreyfuss o il Processo di Norimberga; basti ricordare cosa abbiamo dovuto fare per scegliere l’ultimo paio di scarpe o come abbiamo felicemente individuato il regalino giusto, per l’onomastico di un nostro amico, noto per i gusti raffinati e difficili.
Abbiamo cercato; abbiamo riflettuto; abbiamo comparato. In sostanza abbiamo dovuto compiere delle scelte. Rovistando tra le numerose possibilità proposte dal mondo, individuata una singola cosa fra tante e ci siamo detti: «Ecco, questa va bene».
Molti diranno: «Beh, niente di strano; abbiamo espresso la nostra preferenza!». E invece no; per un criterio logico che ha parecchio a che vedere con il senso della verità, dovremmo prima di tutto dire: «Ho giudicato». Di sicuro lo abbiamo fatto in quanto volenti; ma, per il semplice motivo che siamo stati in grado di attivare la facoltà corrispondente, necessita ammettere che quest’ultima stava già di casa dentro di noi e al momento opportuno l’abbiamo tirata fuori, senza il minimo sforzo. Anzi, non di rado, accompagnato da un pizzico di compiacimento.
Perché mai l’impulso a giudicare dovrebbe venir considerato come un cugino di periferia rispetto ad altre istanze interiori che stanno alla base d’ogni nostra quotidiana esplicazione esistenziale?
Eppure, mentre in alcune situazioni non ci è solamente facile ma proviamo addirittura soddisfazione nell’esternare il nostro giudizio, ci sono moltissimi altri casi in cui questo atteggiamento viene totalmente abolito, capovolto, e ci troviamo bene attenti e vigili affinché nessuno venga a sapere ciò che stiamo pensando attorno ad un certo argomento. Chiamiamo questo modus cogitandi con la voce di “riserva mentale”; un eufemismo dialettico, molto intellettualistico e poco etico, dietro al quale si nascondono le solite umane manchevolezze, a volte veniali, perdonabili, a volte incomprensibili e invereconde.
Credo non esista un solo caso in cui la frase: «Chi sono io per poter giudicare?» possa venir usata con la disadorna verecondia con la quale tenta di coprirsi; peggio ancora poi se volta anche in forma d’interrogazione pleonastica, in quanto chi la proferisce non può non sapere d’essere un Io, che per natura, o per deliberazione, è portato ad intendere, quindi a distinguere, quindi a comparare e perciò a giudicare.
Attività questa, che viene svolta continuativamente entro certi limiti. Ma quali limiti?
Si potrebbe, tutt’al piú, senza volerne fare un motivo di cassazione, portare a coscienza il fatto di essere un Io Superiore, di aver incaricato il suo rappresentante inferiore (ego) ad avventurarsi nei meandri della caduca frammentarietà del mondo, svolgervi una lotta senza quartiere con i marasmi esistenziali, per conseguire, tramite conoscenza piú vasta e oggettiva, un’esperienza di vita non esclusivamente effimera; ma il rappresentante inferiore, a furia di destreggiarsi nella marea degli impatti fisico-sensibili, ha cosí ben appreso l’arte di schivare i colpi, che da almeno un paio di millenni, se non piú, ha cominciato ad esibirsi nel ruolo di “colui che può lavarsene le mani”; di far capire a tutti (urbi et orbi?) che non è sua intenzione assumersi la responsabilità di fatti accaduti, o in fieri, quanto meno non in modo totale. Per cui ci si può spiegare l’odierna smania del reo alla ricerca di altre correità, per un condivisibile alleggerimento del carico etico.
Anche se qui, tutto sommato, di etico rimane ben poco; perdura semmai la preoccupazione di “perdere la faccia “ di fronte alle proprie clientele, la fedeltà delle quali, come ben risaputo, esprime la massima affezione, nella misura in cui il prescelto, configuratosi nell’immaginario collettivo, sappia reggersi sulla cresta dell’onda.

Un detto popolare, un po’ moralistico (ma ai detti popolari va perdonato questo ed altro) raccomanda di dire pane al pane e vino al vino; può diventare, a scelta, uno spuntino, oppure uno spunto per le nostre riflessioni in corso.
Cosa sono il pane e il vino? Due cose? Due oggetti? Due percezioni? O due rappresentazioni? Possono essere ciascuna delle voci elencate, ed anche piú, se la nostra coscienza pensante si mette in moto e comincia ad indagare. Importante è fare il primo passo, poi il resto viene di conseguenza; attenzione! È una conseguenza non meccanica, ossia non provocata da una forza sconosciuta ed esterna, ma è l’attivarsi di qualcosa di nostro, molto intimo e personale, lo stesso che ci dà la puntuale conferma di essere un soggetto pensante ogni volta che ci poniamo una domanda di questo genere: ammesso che lo facciamo; ma se non lo facciamo è meglio ancora, perché sta a significare che il fatto di essere un soggetto che pensa è talmente ovvio da costituire un fondamento non bisognoso di venir dimostrato.
Prendo un pezzo di pane; lo abbino a qualcosa di semplice ed immediato, qualcosa che per la mia esperienza sia privo di difficoltà, per esempio, alla marmellata; pane e marmellata; pure un bambino capirebbe subito, anzi, in questo caso piú bambini si è, e meglio si capisce.
Non c’è bisogno qui di dare giudizi; il che non vuol dire che i giudizi siano momentaneamente sospesi o scomparsi; è la fulmineità contestuale dell’accadimento che ci offre la garanzia totale di sapere alla perfezione quel che si è, quel che stiamo facendo e quel che, nel caso in esame, resta da fare. Siamo talmente incentrati nel nostro io comune, da dominare la scena senza ulteriori esigenze esplicative.
E se al posto della marmellata mettessimo la parola “libertà”? Sentite come suona bene: «Pane e Libertà!»; come slogan immagino sia stato usato piú di una volta. La libertà è un concetto notevolmente diverso dall’oggetto-marmellata, anche se dal punto di vista storico e sociale la libertà qualche volta è stata ridotta ad una specie di marmellata e non certo delle migliori.
Per unire il pane alla libertà, la coscienza ordinaria deve arrampicarsi, salire in alto; deve iniziare a destreggiarsi con il mondo degli ideali, che non sono proprio entità metafisiche ma per lo meno ci vanno vicino. Abbiamo a che fare con degli oggetti smaterializzati, e questo ci può confondere non poco, abituati come siamo alla forma precisa, al peso esatto e alla misurabilità millimetrica, tipici della dimensione fisica.

Di conseguenza, mentre sul “pane e marmellata” c’è poco da dire (e quasi tutto da masticare), sul sentiero del “Pane e Libertà” c’incamminiamo in punta dei piedi e con una certa circospezione. Dopo (anche qui l’esperienza ha il suo peso figurativo), col tempo si familiarizza pure con i pensieri astratti e con le idee, a patto però di trascinarli verso il basso, verso il nostro laboratorio interiore, che è un baricentro di profondità; grazie alla facoltà di rappresentarci in immagini quel che non possiamo contenere nell’ambito della sensibilità corporea, e che invece ci sopravanza come spinta intellettiva, ecco apparire un intero universo di possibilità supponibili e argomentative con le quali produrre valanghe di teorie, supposizioni, modelli concettuali e via dicendo, che giorno e notte intrattengono in dispute, contrasti, risse e litigi senza fine, la parte d’umanità consapevole di disporne e di volerle usare; giacché è evidente che ciascuno darà, a quel che ha intravisto in seno allo scibile conquistato, un determinato valore e una collocazione sua propria, mai uguale o pari a quello d’altri.
Naturalmente potranno esserci delle buone convergenze di opinione, una concertazione d’intenti e varie forme di giochi di squadra volti a un agire condiviso. Questo non toglie nulla a quanto detto poc’anzi. La disparità estremamente variegata delle rappresentazioni, delle sensazioni, delle opinioni, portano allo sconcerto, oppure, nel caso fossero segretate (il che non migliora la situazione) all’esercizio frustrante della riserva mentale.
Da qui in poi la degenerazione potrebbe prendere uno sviluppo irrefrenabile.
All’epoca corrente – tale è la mia opinione ma sono sempre pronto a cambiarla con una nuova vincente – questa è l’autentica minaccia ancora da scoprire in tutta la sua drammatica portata e quindi da debellare qualora nell’ anima degli uomini prevalga nitidamente l’amore per il senso della vita considerata sotto il profilo evolutivo.
Bisogna anche tenere ben presente che se Libertà avrà da essere, allora è impensabile pretendere che, nel suo primo affiorare, essa non si presenti con i caratteri del disordine, del caos, delle diseguaglianze e delle ingiustizie. Come nel decorso delle malattie, i momenti di maggior difficoltà sfociano nelle crisi: queste, o vengono in qualche modo superate grazie ad una risposta vincente dell’apparato organico, oppure la natura fisica impone la legge del processo disgregativo.
Quando però si parla di riserve mentali di quel che si pensa, ma contemporaneamente si vuol tener celato al mondo intero compresi se stessi, la natura non c’entra piú; la cosa sta al di fuori del suo ambito; se la si vuol rimuovere in qualche modo, è necessario avviare un percorso interiore di cui noi soltanto possediamo la chiave.
È curioso vedere come molte persone afflitte da questa tendenza (chiamiamola provvisoriamente cosí) al punto di non ammetterla e di non riconoscerla per propria, alla fine della giornata si sentano stranamente stanche pur senza aver dovuto fare nulla di particolarmente gravoso. In casi come questi, non mancano poi amici premurosi in veste di saggi consiglieri che a turno suggeriscono vitamine, integratori alimentari e medicinali antistress.

Basterebbe invece dirsi (e dire) la verità; in ogni situazione, in tutti i casi; a qualunque costo; whatever it takes, ovvero ad ogni costo, sentenziò tempo addietro Mario Draghi, frase divenuta celebre e inserita persino nella Treccani. Il bivio è tuttavia evidente: da una parte si ritiene opportuno il non dire per timore di suscitare risentimenti, offese o incomprensioni altrui; dall’altra non si è cercato abbastanza nel bagaglio della propria facoltà discorsiva, per trovarvi le parole giuste, il tono aperto, e quel sincero intento di chiarezza, di fronte al quale ogni opposizione tace perché si scopre superflua.
Marco Tullio Cicerone ci ha insegnato che rem tene verba sequentur. Se si è veramente convinti che quanto si sta per dire è necessario per il bene di tutti, allora le parole per dirlo verranno da sole. Se invece mente, cuore e bocca rimangono congelati, vuol dire che abbiamo delle riserve da studiare e da valutare, forse a lungo termine, e soltanto dopo prenderci la briga di esternare le parole bloccate.
Ma Cicerone all’epoca era un principe del foro, un avvocato, e quindi prima di seguire il suo prezioso consiglio, dovremmo svolgere qualche riflessione sul tema annoso di “Pulpiti & Prediche”, giacché è pur vero che non si racconta tutto, ma è altrettanto vero che non tutto quel che si racconta è del tutto vero.
Poiché le cose belle viaggiano a tre, e anche per il gusto di complicare ancor piú questi nostri ragionamenti, introduco ora un terzo tema che tuttavia si ricollega perfettamente con quelli fin qui illustrati. Riprendiamo il “Pane”, prosolviamolo dalla marmellata e dal vessillo della libertà e completiamolo invece con l’aggettivo “quotidiano” ; diventa quindi “il pane quotidiano”; non ci vogliono grandi sforzi per giungere cosí al “Nostro Pane Quotidiano” che ricorda la preghiera del Padre Nostro. Anzi, per amore di verità, io direi che è la preghiera stessa a farcelo ricordare; pregando, offriamo lo stoppino dell’anima nostra a quel lumignolo e la preghiera puntualmente interviene ad accenderlo.
Come collocare questo Pane Quotidiano? Non è una percezione, non è un ideale, non è rappresentazione e nemmeno sensazione; forse è un’intuizione? Neanche; è facile dire quello che non è, ma in compenso diventa estremamente difficile capire (e dire) quel che dovrebbe o potrebbe essere.
Mi soccorre una cognizione appresa molto tempo fa, quando mi dilettavo (almeno cosí credevo) di astrologia. Tra le varie letture di allora, c’erano in primo piano gli studi sui Segni Zodiacali, e poi anche sulla simbologia in genere, mitologica, pagana e veterotestamentaria.
Ho cosí imparato che nei linguaggi scritti dagli uomini esistono tre grandi classi o livelli cui ricondurre gli incisi e graffiti primitivi; la suddivisione piú elementare e comprensibile è che essi sono o segnali, o simboli, o segni.
I segnali rispondono a chiunque (usiamo quelli moderni per meglio esemplificare: l’ALT, lo STOP ecc.). I simboli sono per una cerchia ristretta di individui legati da una comune esperienza; esempio: conservo un cerchietto dorato da appuntare al risvolto della giacca con incisa la sigla del sindacato degli agenti d’assicurazione cui ero iscritto durante gli anni della mia professione.
I segni: qui il discorso cambia: ci vuole un salto di qualità, un volo pindarico. Perché i “segni” non sono né per tutti né per pochi; sono per alcuni; per chi sa vederli e interpretarli. I segni sono una fonte di rivelazione continua, ma non è possibile ai giorni nostri avere una cultura dei segni, né tanto meno una scuola o un praticantato basato su di essi.
In certe condizioni e su particolare sollecitazione di un momento di vita, ognuno di noi può accedere ai segni, con tutti i rischi che possono poi derivare da un eventuale abbaglio, da interpretazioni incoerenti e da ulteriori corruzioni interiori.

Non per nulla i miracoli attribuiti al Cristo Gesú dai resoconti evangelici vengono giustamente tradotti in lingua italiana corrente come “segni”. Questo ulteriore arricchimento ci proviene dall’indagine spirituale promossa dalla Scienza dello Spirito; non da altre parti.
Personalmente c’è voluto parecchio tempo prima che me ne avvedessi e potessi afferrare l’importanza del cambio richiesto dalla progressione esegetica, in gran parte ancor oggi da esplorare. In sostanza facevo come tanti altri, leggevo un episodio del Nuovo Testamento senza pormi il problema del perché e del percome. Non avvertivo la necessità di capire: quelle rare volte che essa s’insinuava nella testa, mi sentivo rispondere che si trattava di miracoli, ergo! di misteri divini, che non dovrebbero indurre un buon cristiano a tentare ulteriori divagazioni sul tema, bensí a riporseli nel cuore traendo da quelli calore e conforto.
L’esercizio del giudicare richiede venir analizzato almeno secondo i tre medesimi livelli che abbiamo or ora adoperato con il pane; partendo dall’oggetto e abbinandolo prima alla libertà e arrivando poi al pane dell’Eucaristia. Per farlo, tutta la nostra anima, la nostra coscienza e il nostro pensiero si sono innalzati fino ad una dimensione che forse non potremmo ancora definire straordinaria, ma non è piú certamente quella ordinaria che conosciamo perfettamente bene, per essere il nostro continuo riferimento cognitivo.
Il giudizio può venir rivolto a un oggetto inanimato; oppure a una situazione coinvolgente uomini e cose; e infine può essere diretto sull’essere umano, su un suo comportamento o su una sua azione.
A questo punto la domanda si fa pressante: «Ma allora, giudicare è un bene o è un male?».
«O uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile perché nel giudicare gli altri condanni te stesso».
«(O Signore) concedi al tuo servo un intelletto capace di giudicare il tuo popolo e di distinguere il bene dal male».
«Piú si giudica e meno si ama».
«Pensare è difficile; per questo la maggior parte delle persone giudica».
Per la prima volta mi permetto di attingere al calderone dei motti e degli aforismi senza dare indicazioni sulla loro provenienza, ma sono cosí noti e facilmente reperibili che chi vorrà sapere qualcosa di piú sulla loro origine potrà porvi subito rimedio.
Come si vede, nel corso del tempo l’uomo ha veduto nella facoltà giudicante un duplice decorso; si può giudicare per assolvere e si può giudicare per condannare; questo è stato però il punto in cui l’indagine si è arrestata, contenta quasi di aver terminato il suo lungo percorso e di essere giunta al punto d’arrivo.
Osservando con la lente d’ingrandimento la citazione che ho indicato per seconda tra le quattro riportate, giudicare vorrebbe anche distinguere il bene dal male. Distinzione quanto mai ardua al giorno d’oggi, ove per bene s’intende l’appagamento immediato di un proprio interesse, magari a scapito altrui, e contemporaneamente si ritiene che il male o non abbia una consistenza reale oppure tutt’al piú rappresenti un accidente di percorso, un intoppo casuale e sfortunato come, ad esempio, il propagarsi dell’epidemia del Covid 19.
Stretti in tale condizione, o per dir meglio cosí condizionati, non solo è difficile distinguere il bene dal male, ma diventa complicato perfino separare l’essenziale da ciò che non lo è.
Secondo la cultura del secolo e il corrispondente tipo d’istruzione impartito, troppo spesso le cose minime, futili, vanesie vengono ingigantite a dismisura; occupano in modo del tutto ingiustificato una gran parte dei nostri delicati, intimi processi psicofisici, alterandoli, violandoli e finendo per dettar legge sulle decisioni, sui sentimenti e di conseguenza sulle azioni.
Viceversa per quanto potrebbe esservi di bello, buono e giusto, che rappresentano il vero e unico tonico ricostituente l’equilibrio e l’armonia interiori, non abbiamo piú occhi che vedano né orecchie che sentano, perché gli organi animici mediante i quali potevamo coglierli e contemplarli, si stanno atrofizzando.
Col discorso precedente del pane e marmellata, siamo passati attraverso la libertà, alla preghiera del Padre Nostro; in questo inciso, ho voluto accostare l’oggetto-pane all’Eucarestia. Perché? C’entra o non c’entra? Sono andato fuori tema? Potrebbe essere; non sarebbe la prima volta.
A me, l’idea del pane quotidiano che diventa pane eucaristico, piace molto; la riaffermo. Certamente tra i due aggettivi qualificativi, c’è una distanza tutta da colmare. Potrebbe essere questo il coronamento cercato per sperimentare il passaggio di qualità che la vita d’oggi richiede, se si vuole veramente penetrarla con la forza e la dose di coraggio disponibili; anzi, lo reclama a gran voce, attraverso l’incalzare dei fatti e degli avvenimenti.
A sé stante, la raffigurazione del pane (con o senza il vino) può venir riconosciuta dai viandanti, quale segnale per una sosta di ristoro; legato invece all’ideale della libertà, diventa un’impresa epico-romantica che sventola tra i rivoltosi; pretendono lavoro, eguaglianza sociale e tutela dei diritti; dalla semplice materialità (segnale), siamo saliti alla dimensione degli idealismi (simboli) legati in questo caso alla conflittualità e alla belligeranza.
Entrambe le fasi, poiché di fasi di crescita si tratta, sono estremamente insidiose; nella prima si tende a un’acquiescenza soporifera e paciosa, incapace di aderire ai ritmi della vita; con la seconda, le forze dell’anima vengono letteralmente stravolte da possenti ondate di avversione e di ostilità, sí che non si arrestano neppure davanti alle tragedie innescate; tuttavia, anche se i due periodi si presentano nettamente distinti nelle loro negatività, sono comunque necessari, e mi costringo pure a dirli indispensabili alla formazione e al perfezionamento dell’esperienza umana. In caso contrario, niente di quelli potrebbe aver luogo in chiave esistenziale.
Ma – ed è qui il punto centrale della presente ricerca – né la serenità amena del quieto vivere, né la lotta spietata di uomini contro uomini a fini di far prevalere mete tanto astratte e ambiziose quanto confuse e utopistiche, raggiungono il livello dei “segni”. La loro utilità essendo puramente preparatoria; cosí come la sintesi che possono accendere in una coscienza d’uomo, il valore non è garantito ma solo offerto all’evenienza individuale.

Come molti altri, conoscevo la cosí detta parabola del Vangelo, relativa al “cieco nato”. E devo ammettere che la risposta data dal Cristo Gesú ai Suoi interroganti sulla natura dell’infermità, non mi era mai stata chiaramente comprensibile. La sentivo strana, avulsa dal testo; in pratica una risposta estremamente generica, da sembrare, ai miei occhi, un espediente, o quasi, per evitarla.
Solo molti anni dopo, e con l’aiuto essenziale di chi si era addentrato a fondo nell’Antroposofia, cominciai a capire. La risposta del Cristo Gesú sul cieco nato era un “segno”; mentre i suoi interlocutori si aspettavano un segnale o un simbolo. Non potevano accogliere il segno, perché per accoglierlo avrebbero dovuto dismettere la loro misconosciuta cecità; ma rimossa questa, ovviamente non avrebbero nemmeno formulato la domanda.
Nell’ambito maggiormente modesto della presente ricerca, va rilevato e rimarcato che il passaggio dal pane quotidiano al pane dell’Eucarestia riguarda la medesima possibilità di evolversi del pensiero, ove sia capace di darsi quale oggetto della propria attività. Il pensiero si rende conto d’esser stato cieco e di colpo sa di poter vedere! Per realizzarlo dentro di noi non servono scienze esegetiche né fervide orazioni; necessita l’esercizio della meditazione, che è l’unica attività in grado di elevare l’anima nel modo corretto, di farla fiorire e di congiungerla consapevolmente, anche solo per un breve tratto, alla luce dello Spirito.
La verità che in tale maniera può rivelarsi è la Risposta che non risponde mai alle singole domande dialettiche dalle quali e tra le quali è pur emersa. Le supera invece, le abbraccia tutte, le integra a un livello superiore, le avvolge in una comprensione allargata nella quale ci si ritrova con la mente e con il cuore in uno stato di grazia; si sperimenta di essere immersi in un silenzio illuminato da tutte le Risposte possibili: un firmamento di Risposte. E per una volta, almeno per questa volta, si avverte di non aver bisogno d’altro.
Chi sono io per (poter) giudicare? Siamo partiti da qui e ora ridiscendiamo dalle nuvolette per trovare una conclusione al nostro interrogativo; una conclusione semplice, ragionevole, obiettiva; che tuttavia abbia la caratteristica particolare di mettere d’accordo pensieri, sentimenti e volontà differenziate e contrastanti. Sembra difficile, ma dopo la breve trasferta in quota, si può tentare una sintesi.
Se giudico (le forme sono tante: sentenzio, credo, suppongo, affermo, reputo, sostengo, ribadisco ecc.) ai fini di una migliore conoscenza sopra un fatto, un oggetto, una situazione, ho speso la mia capacità in modo positivo; non ho offeso, né accusato o denigrato qualcuno. Ho soltanto criticato qualcosa in cui mi sono imbattuto e che, secondo il mio giudizio, sarebbe stato meglio se fosse stata fatta in modo diverso.
Quando invece l’oggetto del mio giudicare è un essere umano in carne ed ossa, relazionato ad un atto (atteggiamento, comportamento, discorso ) da lui manifestato, ecco allora il guasto estendersi in tutta la sua portata. Perché cosí facendo ho posto il mio veto sul karma altrui, e tale pretesa, oltre ad essere sconsiderata e priva di rispetto per quella vita che ci accomuna entrambi, diventa un elemento di negatività che dilaga, penetra, s’introduce furtiva nel corso del mio karma personale, e va a comporre lentamente una compensazione, di cui, secondo le sue leggi, mi presenterà il conto.
Poter giudicare è una facoltà dell’uomo liberamente esercitabile; se l’uomo ha però saputo guadagnarsi un sufficiente livello nella sua ascesa verso la libertà individuale, si asterrà, oppure non giudicherà secondo i canoni attesi, nei quali solitamente si esplica il giudizio. Dirà forse qualcosa che gli altri stenteranno a capire, ma quel momento d’imbarazzo che sorgerà tra quanti si attendono il verdetto, potrà indicare la via per farli eventualmente uscire dalla necessità del dover giudicare.
È il comportamento dell’Io; il quale non vive del pane cosparso di marmellata, né di quello inzuppato nell’intingolo ideologico dei miraggi delle libertà astruse. Di fronte alla sua presa di posizione, gli ego rimangono spiazzati, interdetti. L’ego, infatti, è vincolato a giudicare, criticare, bacchettare tutto e tutti, perché ancora non sa, o forse finge di non sapere, che quanto da lui percepito come altro da sé è – spiritualmente – sempre e solo se stesso, in forme e in vesti spaziotemporali diverse.

Fintanto che non arriva il turno, finché non matura il momento dell’autorivelazione, la verità rimane celata nell’intreccio delle vicissitudini; allora il Brutto Anatroccolo continuerà a fissare in cielo il volo mirabile e maestoso dei cigni, e a piangersi addosso la sua miserevole situazione terrena.
Preferisce giudicare a costo d’infliggersi un’autocondanna: «Forse è giusto cosí. In fondo chi sono io per poter giudicare?».
Ma io non sono un Brutto Anatroccolo; sono un Uomo. Oggi non volerò, probabilmente domani neppure. Ho però il pensiero e quello vola già piú alto dei cigni.
Angelo Lombroni