Politica di Bonifacio VIII
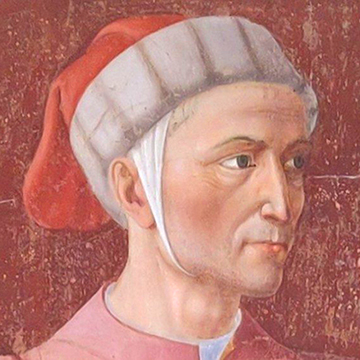
Andrea del Castagno «Ritratto di Dante»
Dopo il provvedimento della cacciata di Corso Donati, Bonifacio VIII, col pretesto di mettere pace, ma in realtà allo scopo di secondare la politica dei Neri, pensò di mandare nel settembre 1300, a Firenze, Carlo di Valois, fratello del Re di Francia, venuto in Italia per combattere gli Italiani rivoltatisi contro il dominio angioino. In tale occasione la signoria di Firenze di parte bianca, impressionata dell’atteggiamento del Papa, stabilí di inviare tre ambasciatori a Roma, uno dei quali fu Dante.
Ora, la fede politica dell’Alighieri in quel drammatico periodo era stata duramente provata. Allorché egli poté constatare che il Pontefice Bonifacio VIII, allo scopo di estendere il suo dominio sui municipi italiani, contribuiva a diffondere tra essi la discordia civile; e avendo visto Firenze tradita dai Guelfi e venduta a Carlo di Valois, fratello del Re di Francia, chiamato in Italia dal Papa allo scopo di cacciare dalla Sicilia Federico d’Aragona che i Siciliani avevano voluto loro re, Dante, che per la sua visione universale della vita e per la sua mentalità nazionalistica, in sostanza si era mantenuto al di sopra di ogni corrente faziosa, si risolse di parteggiare decisamente per i Ghibellini, senza tuttavia sciogliere i suoi legami con la parte Bianca.
Dante ambasciatore a Roma

Giuseppe Bezzuoli «L’entrata a Firenze di Carlo di Valois»
Veniva a questo punto inviato come ambasciatore presso la corte del Pontefice. Egli stette in dubbio se dovesse accettare tale missione, dato il suo atteggiamento interiore nei riguardi di Bonifacio VIII, ma, essendosi reso conto che in sostanza l’ambasceria concerneva la possibilità di un miglioramento delle condizioni di Firenze, si accinse ad assolverla con onore. Ora, secondo i cronisti e gli storici che danno per certa la visita di Dante a Roma in tale occasione, il Poeta avrebbe perorato la causa della sua città pregando il Pontefice di ritornare alla moderazione e alla tradizionale saggezza cattolica, e di cooperare con la sua autorità alla conciliazione dei diversi partiti.
Mentre Dante si trovava con tutta probabilità a Roma, il giorno di Ognissanti del 1301, faceva il suo ingresso in Firenze Carlo di Valois «con la lancia con la quale giostrò Giuda» (Purg. XX, 73). Fu quella una giornata tragica e luttuosa per Firenze, perché i Neri, sentendosi appoggiati dal potente straniero, superarono ogni limite nel prendere le loro vendette, trucidando i Bianchi e saccheggiandone le abitazioni. Elessero in pari tempo un nuovo loro governo.
Le vendette dei Neri
La vendetta dei Neri contro Dante fu tipica per viltà e per eccessività: dei suoi beni si impossessò un certo Boccaccio Adimari appartenente ad una famiglia plebea proveniente da Mugello, seguace fanatico di Corso Donati ed esaltatore della potenza di Carlo di Valois: la sua ambizione e la vocazione politica erano tali da non contrastare con certe forme legali di rapina. Ma la famiglia degli Adimari verrà bollata a sangue nel ventunesimo canto del Paradiso.
Trascorsi i primi giorni delle vendette di Corso Donati, i nuovi Priori rappresentanti la parte nera nominarono come podestà, per ordine di Carlo di Valois, Cante dei Gabrielli da Gubbio. Questi, secondo che riferisce il Venturini, era un giudice rivoluzionario che trovava il delitto anche nella piú pura innocenza e si appagava dei piú lievi indizi. Innumerevoli furono perciò le condanne a morte, gli esili, le confische dei beni e le pene pecuniarie, il cui provento poi veniva diviso con il principe francese.
Dopo questo ulteriore sfogo, la persecuzione assunse altre forme. «Sfruttata questa vena – scrive Isidoro Del Lungo – pei contumaci, pei nascosti, pei fuggiaschi, si ricorse ad un tumultuario ostracismo. Nel gennaio, presenti tuttavia nella città, non uno, ma due paciari papali, poiché v’era ritornato per la seconda volta il Cardinale di Acquasparta, si pose mano alle proscrizioni che verso questi giorni ultimi del mese fioccavano. Basta aprire il tremendo Libro del Chiodo il quale ne conserva gli atti e leggere… In tutto (fatta ragione dei nomi che ricorrono in piú di una sentenza) sono oltre seicento uomini quali condannati nel capo, di scure i magnati, alla forca i popolani, quali nell’avere, quali mandati ai confini».
Condanna di Dante
I particolari di queste atroci condanne si possono ritrovare nel citato Libro del Chiodo, voluminoso codice custodito nell’Archivio Fiorentino, contenente i nomi delle persone e delle famiglie che si ribellarono al Comune di Firenze dal 1268 al 1379.
Mentre Dante, dunque, presso la corte papale nobilmente si adoperava per le migliori sorti della Patria, i suoi concittadini, accecati dalla passione politica e dalla brama di vendetta, lo tradivano e lo rinnegavano. Il 27 gennaio 1300, Cante dei Gabrielli da Gubbio, podestà di Firenze, pronunziava contro l’Alighieri e contro messer Palmieri degli Altoviti, Lippo Becchi e Orlanduccio Orlandi, una sentenza di condanna all’esilio e ad una multa di cinquemila fiorini piccoli.

Antonio Maria Cotti «Dante esiliato e deriso»
La casa del Poeta fu saccheggiata e incendiata, e piú tardi l’odio di parte guelfa si accaní talmente contro di lui, che le autorità di Firenze, poiché egli non aveva pagato entro il termine prescritto la multa inflittagli e si era mantenuto contumace (il che significava per i giudici che si riconosceva reo confesso), non si peritarono di condannarlo, con una nuova sentenza del 10 marzo 1302, ad essere bruciato vivo insieme con altri dieci colpevoli degli stessi reati.
Tale ingratitudine e tali avversità, se turbarono lo spirito di Dante, non giunsero ad alterarne la fede nei destini della Patria e la volontà di combattere per essa. Si ritirò dapprima a Siena e poi ad Arezzo dove si riuní con molti suoi concittadini che avevano subíto una consimile sorte.
Tentativi di riscossa dei Bianchi
Nel giugno del 1302, Dante partecipò attivamente al movimento che gli esuli preparavano per prendere la rivincita e rientrare in Patria: intervenne perciò all’adunata che ebbe luogo nella remota chiesetta di S. Godenzio, in Valdisieve, alle pendici dell’Appennino, e fu tra i promotori di un’intesa con gli Ubaldini, potente famiglia ghibellina di quella contrada, allo scopo di condurre una comune azione contro i Neri. Ma questa impresa, iniziata con tanto fervore, non ebbe esito felice, sia per il tradimento di Carlino dei Pazzi, sia per la insufficiente capacità di coloro che la capeggiavano militarmente.

Annibale Gatti «Il mancato ritorno»
L’anno seguente, pertanto, il Poeta non partecipò a una seconda impresa del genere tentata da Scarpetta degli Ordelaffi da Forlí. Anche questa fallí, perché le forze armate degli esuli furono sconfitte e ricacciate violentemente, il 18 marzo, a Pulicciano, da Fulcieri dei conti Paolucci da Calboli, podestà di Firenze. Dante in effetti aveva consigliato di rimandare il tentativo, ritenendo prematura cosí ardua impresa; questa veniva ritentata qualche mese dopo con identico insuccesso. E allora qualcuno dei compagni del Poeta non esitò ad attribuire a lui la colpa di tale sequela di sconfitte.
Anche questa accusa fu per Dante motivo di cordoglio. Trovandosi perseguitato dai suoi concittadini e incompreso da coloro cui era accomunato da un’identica sventura, egli piú che mai cercò la solitudine e andò ramingo di terra in terra senza tuttavia rinunciare all’idea di una degna rivincita.
Ma i Bianchi fuorusciti non intendevano subire passivamente la loro triste sorte e nell’esilio preparavano una nuova riscossa. Nel 1304 essi tentarono un’azione armata per riprendere Firenze. Non si è certi che Dante partecipasse a questa impresa. Furono messi insieme novemila fanti e milleseicento cavalieri, i quali mossero contro la città e dopo qualche combattimento riuscirono ad occuparla. Ma la vittoria non ebbe frutti duraturi: a causa del mal governo e della mancanza di disciplina, i Bianchi furono costretti nuovamente a lasciare Firenze.
L’esilio
Dante perdette allora ogni speranza di ritornare in Patria e di poter cooperare alla ricostituzione civile e politica della sua città. Cominciò a vagare di paese in paese, recando con sé l’amarezza delle avversità subite e l’assillante pensiero degli stenti in cui si trovavano sua moglie e i suoi figli, i quali sarebbero veramente finiti nella miseria se la carità dei parenti non li avesse soccorsi.
Dopo aver lasciato Verona, dove era stato ospite gradito di Bartolomeo della Scala, al quale era succeduto il fratello Alboino I, il cui trattamento per il Poeta non era stato altrettanto benevolo, si recò presso altri amici.
Sembra che in questo periodo stringesse amicizia con Gherardo da Camino signore di Treviso e con Guido dei Roberti da Castello.
Molte altre regioni della penisola conobbe durante questo suo nuovo pellegrinaggio, sempre accolto con la stima che ormai ovunque veniva professata alla sua celebrità, dovute sia alle poesie giovanili, che alla Vita Nova e alle Rime allegoriche. Ma nonostante la sua vita errabonda. Dante non rinunciava ad esprimere le immagini e le intuizioni della sua vita interiore, e andava cosí preparando nuove opere.
De vulgari eloquentia
Dal 1304 al 1308, tra le altre opere che concepisce e prepara, compone il trattato di filologia e di poetica in latino dal titolo De Vulgari Eloquentia. In esso il Poeta si propone di esaminare i rapporti della lingua con tutte le forme della poesia; ma la trattazione si arresta a metà del secondo dei quattro libri che egli intendeva scrivere.
Messa in evidenza l’unità originaria di tutti i linguaggi, e riconosciuti tra essi tre gruppi fondamentali, Dante dedica particolare attenzione al complesso delle lingue neolatine, l’italiana, la francese e la provenzale.
Egli pertanto riconosce la lingua italiana come la piú degna delle lingue derivate dal latino; indi rivolge il suo esame ai diversi dialetti della penisola, e afferma che nessun volgare italiano può identificarsi col linguaggio «illustre, cardinale, aulico, curiale» usato dagli uomini di corte, dai grandi dotti e dai poeti, pur riconoscendo che motivi e radici di esso si ritrovino ovunque. «Questo volgare illustre che risuona nelle opere dei poeti piú insigni e nelle materie piú nobili, le armi, l’amore, la rettitudine: che è in fondo lo stile della piú alta forma della poesia, cioè della canzone, deve serbarsi distinto dal volgare piú umile, che è lo stile della ballata e del sonetto, di cui il poeta nell’opera compiuta aveva intenzione di parlare» (Turri).
Dante, la cui essenziale aspirazione era la creazione di una unità nazionale di tipo imperiale, volle cooperare a questa creazione, formando anzitutto una lingua nazionale la quale venisse a sostituirsi a quella caotica mescolanza di dialetti con cui si parlava e si scriveva al suo tempo.
Dante iniziatore della lingua italiana
A questo scopo egli, giovandosi degli elementi che gli venivano forniti dalla lingua parlata – secondo l’osservazione del Fraticelli che riassume le dichiarazioni fatte dal Poeta nel Convivio e nel Volgare Eloquio – selezionando le voci piú esatte e concependo per esse norme morfologiche ben definite, cominciò a realizzare un tipo di idioma tale che potesse venir capito in tutte le regioni della penisola come linguaggio unico degli Italiani in cui si potesse esprimere infine il pensiero italiano.

Giorgio Vasari «Sei poeti toscani illustri» (da sin.: Cristoforo Landino, Marsilio Ficino, Petrarca, Boccaccio, Dante, Guido Cavalcanti)
Nell’accingersi a questa nobilissima impresa, Dante ebbe a notare, come egli stesso riferisce nel libro del Volgare Eloquio, come nei due versanti dell’Italia, ossia di qua e di là dell’Appennino, le lingue erano diverse: i Siciliani si diversificavano dai Pugliesi, questi dai Romani, questi dagli Spoletini, dai Toscani, dai Genovesi, dai Sardi, e cosí via, per cui l’Italia presentava quattordici variazioni fondamentali del volgare, mentre in una stessa città, o regione, lo stesso dialetto presentava notevoli differenziazioni.
È facile comprendere quali difficoltà si presentassero al Poeta nel momento di tradurre in atto il suo proposito; purtuttavia, egli non si sgomentò, e benché, come nota il Fraticelli, tutti i migliori maestri di lettere del suo secolo credessero fermamente essere ciò un proponimento di temeraria stoltezza, si accinse a purgare il volgare linguaggio dalle barbare costrizioni, dalle maniere e voci sconce e pedestri e, trovati nuovi modi, nuovi costrutti, nuove forme originali, lo rese bello e ricco, con le gravi e peregrine sentenze lo vestí di dignità, con l’affetto e col sentimento lo fece caro ed accetto a chi pure lo dispregiava; e ben conoscendo che le sole cose agevolmente comprese possono trionfare sugli animi, mirò soprattutto alla proprietà e alla chiarezza.
E qui cade acconcia l’osservazione di Domenico Venturini, il quale ritiene che, riguardo alla correzione dei dialetti, Dante avrebbe saputo fare ancor questo, se avesse avuto il potere politico di stabilire norme obbligatorie, affinché dall’esempio costante dei pubblici funzionari di qualunque categoria, il popolo avesse a mano a mano appreso a dimenticare tutte le sconce locuzioni proprie di ciascun paese e ad usare un linguaggio uniforme intelligibile a tutti.
Il “Volgare”
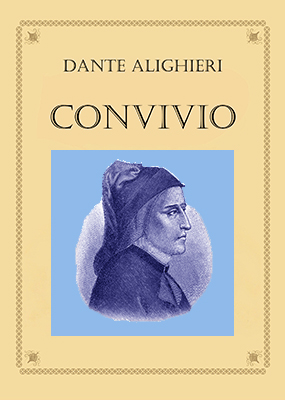
Anche in questa opera Dante trovò ostinati avversari che non intendevano arrendersi dinanzi alle piú eloquenti dimostrazioni. A essi intendeva rispondere il Poeta nel Convivio con questi termini: «A perpetuale infamia e depressione delli malvagi uomini d’Italia che commendano lo volgare altrui e lo proprio dispregiano, dico che la loro mossa viene da cinque abominevoli cagioni. La prima è cecità di discrezione, la seconda maliziata sensazione, la terza cupidità di vanagloria, la quarta argomento di invidia, la quinta e ultima viltà d’animo, cioè pusillanimità». Coloro che sono affetti da queste colpe «sono gli abominevoli cattivi d’Italia, che hanno a vile questo prezioso volgare lo quale, se è vile in alcuna cosa, non è se non in quanto egli sona nella bocca meretrice di questi adulteri».
Con questa resistenza interiore e con questa virile fermezza di propositi, Dante poté compiere la sua opera creando nella forma piú limpida e piú rispondente alle profonde qualità di equilibrio della razza, l’idioma che doveva divenire il patrimonio nazionale, e tramite di un nuovo pensiero e di una nuova tradizione italica. «Dante – osserva il Parini – fu il primo che, trasferendo l’entusiasmo della libertà politica anche negli affari delle lettere, osò scuotere il giogo della venerata latinità dei suoi tempi e levare da terra il peraltro timido volgare della sua città e condurlo di sbalzo a trattare in verso l’argomento piú forte e piú sublime che a scrittore ed a poeta cristiano potesse convenirsi giammai».

È pur vero che Dante non raggiunse pienamente lo scopo di estirpare i mille dialetti che, nelle variazioni fondamentali, permangono ancora oggi in Italia; ciò non di meno egli ebbe il potere di far adottare la nuova lingua a tutti i letterati e gli scrittori d’Italia, e d’introdurla nelle chiese, nelle scuole, nei tribunali, negli uffici di pubbliche amministrazioni, nei testi legislativi e nelle corrispondenze epistolari.
Creò in sostanza una lingua nazionale, la quale in definitiva andò a sostituire tutti i dialetti, i quali rimasero soltanto con una funzione limitata che tutt’ora hanno: quella di preparare alla migliore e piú certa conoscenza della lingua italiana.
Di terra in terra
Esule di terra in terra, nel 1306 probabilmente si rifugiò a Padova e nell’anno seguente in Lunigiana, presso i marchesi Malaspina, i quali si giovarono della sua opera, affidandogli delicate missioni diplomatiche. Tra l’altro, infatti, lo nominarono loro procuratore per definire i patti di pace col vescovo e conte di Luni, Antonio da Camilla: incarico che Dante assolse onorevolmente. In casa dei Malaspina, forse Dante conobbe Cino da Pistoia, squisito poeta, col quale, legato da fraterna amicizia, scambiò molti sonetti.

Domenico Petarlini «Dante in esilio»
Fu poi ospite dell’amico Busone a Gubbio; quindi, ritornando da Roma, si recò a Verona presso Alboino della Scala che lo accolse con cordialità e con onore. Ma, per quanto i signori e i principi accogliessero presso i loro castelli il Poeta, rendendo omaggio al suo alto intelletto e alla sua dottrina, Dante taciturno e triste passava attraverso i fasti, le sontuose feste e le cerimonie che si svolgevano presso le corti dei sovrani, senza potervi partecipare con lo spirito, il quale era continuamente rivolto alla patria, al ricordo di Beatrice, alla sua famiglia e al tempo stesso era impegnato in severi studi.
Anche quando si recò al monastero di Corvo, dove forse gli sarebbe stato possibile riacquistare la calma e aver tregua al combattimento interiore, egli continuò a sentire la tragica potenza del suo destino. Al monaco di Corvo che gli chiese che cosa cercasse nel monastero, allorché Dante si presentò alla porta, dopo il lungo pellegrinaggio, «Pace» egli rispose.
Trascorse nella quiete della cella del monastero diversi giorni immerso nella meditazione e talora nella contemplazione, ora passeggiando nella piccola stanza, ora passeggiando per il chiostro ove si incontrava con il monaco il quale, colpito dall’aspetto austero di quel pellegrino e riconoscendo nel suo volto gli indubbi segni di una forte intelligenza e di una vita eccezionalmente vissuta, gli rivolgeva continue domande per conoscere chi fosse e quale fosse il suo passato. Cosí il monaco conobbe che era il già famoso Dante, ed esprimendogli la sua ammirazione tentò di confortarlo.
Prima di ripartire, Dante si trasse dal seno un libro e lo porse al buon anacoreta dicendogli: «Frate, ecco parte dell’opera mia, forse da te non vista; questa ricordanza ti lascio, non obliarmi».
Enrico di Lussemburgo
A quel tempo, poiché era morto l’imperatore Alberto d’Austria, ucciso per tradimento di un suo nipote, Filippo il Bello, re di Francia, mirava a porre sul capo del fratello Carlo di Valois la corona imperiale; ma papa Clemente VII, considerando che il dominio francese in Europa sarebbe divenuto troppo potente, invitò a un incontro segreto gli elettori di Lamagna per fare in modo che la corona d’Austria venisse conferita a Enrico di Lussemburgo. Il Pontefice voleva naturalmente trarre partito da quella situazione per giovare agli interessi della Chiesa; perciò tenne segreto consiglio con Messer d’Ostia Cardinale da Prato e con gli elettori di Lamagna e con tutti coloro che si erano sdegnati per le iperboliche mire del re di Francia, allo scopo di dare la corona d’Austria a Enrico di Lussemburgo, «Io sento – disse in tale occasione il saggio cardinale – che il conte di Lussemburgo è oggi il migliore uomo della Magna e il piú leale e il piú franco e il piú cattolico, e non mi dubito se viene per te a questa dignità che egli non sia fedele obbediente a te e a Santa Chiesa, e uomo di venire a grandissime cose».
Massimo Scaligero (3. continua)
Tratto da: Dante, Domenico Conte Editore, Collana “Vite”, Napoli 1939.
