
Hermann Hesse
Hermann Hesse, nato a Calw nel Württemberg nel 1877 e morto a Montagnola nel 1962 nel Ticino, è uno dei protagonisti della grande stagione della letteratura tedesca del Primo Novecento. Calw è un paesino sulla Nagold e fa parte della regione storica e linguistica (ma non amministrativa) della Svevia. Ma di paesano la famiglia aveva ben poco, ché il padre Johannes era un tedesco baltico, suddito dello zar, la madre Marie Gundert era nata in India a Talasseri dove suo padre Hermann Gundert era a capo della missione pietista, mentre la madre era una calvinista svizzero-francese. La famiglia era caratterizzata dalla comune fede e pratica pietista decisiva nella formazione del giovane che da ragazzo superò brillantemente un severo esame di latino per essere ammesso al seminario di Maulbronn, la cui frequentazione era indispensabile per essere ammesso alla facoltà di Teologia, allo “Stift” dell’Università di Tubinga. Era una celebre istituzione a suo tempo frequentata da Hegel, da Hölderlin, da Schelling e piú tardi dal poeta romantico Eduard Mörike. Ma il giovanissimo Hesse si ribellò presto, fuggendo dal seminario. Riacciuffato, era ormai chiaro che era svanito l’ambizioso programma della famiglia di farne un pastore come il padre, e soprattutto come il nonno materno, patriarca, nonché affermato studioso di indologia.
Seguono anni di ribellione, dolorosa, che trascina il giovane fino alla soglia del suicidio. I genitori, credenti e anche alquanto bigotti, non ci si raccapezzano con questo figlio recalcitrante e insubordinato, che non ha alcuna intenzione di dedicare la sua vita a Dio e alla comunità cristiana. Sono disorientati e spaventati, non riescono a comprendere il ragazzo e lo rinchiudono in diversi convitti pietistici, persino in uno che è un manicomio diretto da un pastore, che è pure esorcista. Certo, che il ragazzo pensa al suicidio. Ma i genitori stupidi non sono, e cosí accettano che il giovane torni a casa e addirittura cominci a lavorare in una fabbrica di orologi per campanili: la ditta Perrot, non a caso siamo nella patria degli orologi a cucú. E cosí Hermann compie a sua prima esperienza lavorativa da operaio con gli operai che lo prendono cordialmente in giro per avere un collega cosí bravo in latino.
E proprio il latino diviene la salvezza: il padre legge un annuncio di una libreria universitaria di Tubinga alla ricerca di un commesso che sappia il latino. E Hermann si reca come apprendista librario in quella città in cui potrebbe, e dovrebbe, studiare teologia. Ma la libreria – come la biblioteca del nonno ricca di volumi di orientalistica e di oggetti e preziosi tessuti serici indiani – è una miniera di letture sempre piú orientate verso la letteratura universale. E nella libreria Heckenbauer si rafforza quella vocazione di dedicare la vita alla letteratura. Programma assai vasto e precario, eppure il giovane commesso, che lavora fino alle dieci ore in libreria, spesso anche di domenica, legge e comincia scrivere e infine pubblica un suo libretto a proprio spese. Nel frattempo frequenta un piccolo gruppo di amici universitari, s’innamora e infine accetta un altro impiego in una libreria antiquaria a Basilea, che gli concede piú tempo libero.
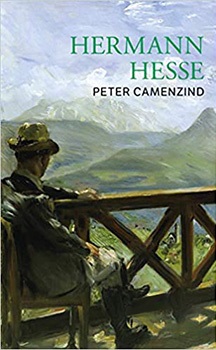
Basilea, la Svizzera, è estero, ma non del tutto. Già da bambino Hermann aveva seguito per alcuni anni i genitori proprio a Basilea, inoltre lo Schwyzerdütsch, lo svizzero tedesco è un parlare affine ai dialetti alemanni, quelli della Svevia, dell’Alsazia, del Baden e del Württemberg. Sia la lingua sia la mentalità sono alquanto affini di quella zona che è l’Alemannien, e la lingua è la sua vera patria. A Basilea Hesse comincia frequentare anche i circoli culturali. Compie viaggi in Italia e scrive, scrive. Un suo nuovo libro viene notato dalla nuova casa editrice di Samuel Fischer di Berlino (quella in cui erano usciti i Buddenbrook) in ascesa; l’editore gli propone di scrivere un romanzo. È la grande occasione, che Hesse accetta, e nel 1904 esce il romanzo del successo: Peter Camenzind. Il libro ha un’accoglienza molto favorevole, incontrando l’interesse del pubblico giovanile per la lingua intrigante, nuova, intimistica, che rievoca la letteratura romantica. I giovani lettori sono affascinati dalla rappresentazione dello scontro tra città e villaggio, tra civilizzazione e natura. Il racconto si colloca sulla scia del superamento del naturalismo. Si tratta di un romanzo di formazione, che rientra nella tradizione di questo genere molto tedesco, ma l’esito è imprevisto: Peter abbandona il villaggio, lascia la famiglia, indigente e culturalmente ristretta, all’inseguimento del sogno di diventare un artista affermato, ma rimane profondamente deluso dalla città e dai circoli intellettuali, abbandona tutto e si ritira di nuovo nel villaggio, ma questa volta è un uomo maturo che sa consigliare e sostenere i poveri e gli sprovveduti paesani.
Il successo corrispose a un movimento diffuso di critica – anche sociale – alla città, ma la crisi veniva superata con il ritorno alla natura. Era proprio questo ciò che parlava a un’intera generazione, quella dei liceali e degli studenti che avevano aderito al movimento spontaneo dei Wandervögel, degli “uccelli migratori”, una sorta di variante tedesca dei boy scout, fondati nel 1907 da Robert Baden-Powell. L’ideale di ritirarsi nella natura era anche quello predicato da Tolstoj. Insomma una serie di fattori erano all’origine della grande fortuna del romanzo, fascinosamente scritto, lontano per altro da ogni tentazione avanguardistica.
Proprio in quegli anni stava sorgendo il movimento degli espressionisti con una comunità di artisti, soprattutto, almeno all’inizio, pittori, poeti e drammaturghi d’avanguardia. Ma erano anche gli anni in cui sorgevano le grandi personalità della letteratura del Primo Novecento: Schnitzler (1862), Hofmannsthal (1874), Mann (1875), Rilke (1875) e appunto Hesse (1877). Essi appartenevano a un’altra generazione, lontana dalle avanguardie: il loro tedesco era elegante, fluente, segnale di una concezione del mondo ancorata su un’attenzione alle forme. Anzi, per quanto riguarda Hesse notiamo un indubitabile tratto conservatore, che lega la sua scrittura fortemente alle estreme propaggini romantiche, e non è certo un caso che l’ultima stagione della poesia romantica sia costituita dalla “Scuola Sveva”, soprattutto da Ludwig Uhland (1787-1862) e Eduard Mörike (1804-1875).

Hesse raccoglie questa eredità, come appare evidente dalle prime esperienze letterarie. Questa tradizione continuò a influenzare tutta la sua lirica, mentre nei racconti e nei romanzi si percepisce l’irrompere della modernità novecentesca. Le opere in prosa di Hesse sono tutte di livello, anche quelle oggi meno frequentate come Rosshalde del 1914, incentrato sulla crisi matrimoniale di un pittore, che riverbera cospicui spunti autobiografici, nonché come i tre racconti Knulp dello stesso anno.
Intanto, dopo il successo di Peter Camenzind, le opere di Hesse vengono accolte con rispetto dalla sua comunità di fedeli lettori, tuttavia si ha l’impressione che Hesse scivoli in un manierismo tardo-romantico sempre piú lontano dall’intensità del primo romanzo. È la crisi della vita: finisce l’esperimento tolstoiano di vivere, molto modestamente, con Maria Bernouilli in un villaggio sul Lago di Costanza, anzi finisce pure il matrimonio. Maria presenta fenomeni di disturbi mentali gravi e deve essere ricoverata; i tre figlioletti vengono affidati uno a un amico pittore, gli altri a istituzioni pubbliche.
Intanto è scoppiata la Grande Guerra. Hesse viene riformato, ma avverte l’esigenza di dare un contributo volontario alla Germania, e dall’Ambasciata di Berna, dove vive, invia libri ai prigionieri tedeschi. Intanto assume posizioni assai critiche verso il militarismo tedesco e s’impegna affinché la comunità degli artisti e degli intellettuali europei possa mantenere ben distinto il conflitto con le sue tremende necessità belliche dalla pratica artistica e dalla solidarietà intellettuale. Una posizione che gli arreca veementi critiche, anche personali, da parte della stampa tedesca, che gli accanisce contro, considerandolo un imboscato. Cosí si approfondisce in modo irreversibile la separazione dalla patria tedesca, e infatti nel 1923 ottiene la cittadinanza svizzera, nazione che non abbandona che per brevi viaggi in Germania. Con la sconfitta tedesca, con la conseguente dissoluzione dell’Impero avanza una eccezionale crisi socio-economica: la valuta tedesca si svaluta in modo impressionante e ciò polverizza le sue entrate. La Germania in agitazione sociale, il matrimonio finito, nonché la miseria sono i motivi che provocano una crisi profonda. Abbandona Berna per trasferirsi definitivamente nel Ticino, a Montagnola, vive di espedienti, nutrendosi di maccheroni e di castagne.

Ma l’indigenza va di pari passo con un crollo psichico. Frequenta uno psicanalista junghiano e lentamente risale la china. Comincia a dipingere come pratica di conoscenza e di distensione, e soprattutto ricomincia a scrivere e ad essere pubblicato. Un romanzo scritto in tempo di guerra, Demian, pubblicato con uno pseudonimo, ottiene di nuovo un notevole successo, cosí saggi e racconti, e finalmente inizia a scrivere, nel dicembre del 1919, Siddhartha. Eine indische Dichtung. È il racconto che è divenuto la sua opera piú celebre. La prima parte, dedicata allo scrittore francese pacifista Romain Rolland, scorre rapida, ma poi avviene un blocco, e l’autore scivola di nuovo nella depressione, da cui riesce a trarlo fuori l’intervento di Carl Gustav Jung, il fondatore della psicologia analitica, che nel 1911 si era distaccato da Freud, infrangendo il nucleo della psicanalisi, ovvero che ogni disturbo risale a una causa sessuale. Jung – e con lui Hesse – avanza un’interpretazione simbolica per cui le turbe psichiche devono essere affrontate come segnali di energie interiori che possono essere orientate verso la guarigione e verso la creatività. Sicuro e forte di questa intuizione, Hesse nell’autunno del 1922 conclude il racconto, che dice tanto della sua storia personale, della sua ricerca, della sua esperienza dell’uomo e del mondo: «Iniziai il Siddhartha nell’inverno del 1919; tra la prima e la seconda parte ci fu un intervallo di quasi un anno e mezzo. Feci allora l’esperienza – non nuova per me, naturalmente, ma di una durezza inconsueta – che non ha senso voler scrivere qualcosa, quando non lo si sia sperimentato di persona».

Con questa intuizione, che divenne la sua verità spirituale, che irrora la sua scrittura, Hesse si trasformò in un maestro, un guru: questo fece la sua fortuna – specie negli anni Sessanta nelle Università americane – ma suscitò anche polemiche, stroncature e attacchi in quanto divulgatore d’insegnamenti soverchiamente facili, al limite della superficialità ‘new-age’. Intanto il racconto ‘indiano’ (ma con riserve) diventò per generazioni di giovani un breviario di saggezza, che non ha ancora esaurito la sua carica comunicativa e forse nemmeno quella sapienziale. Il racconto è noto: il protagonista ci viene incontro come un giovane bello, ricco, sapiente, figlio di una famiglia autorevole di bramini. Il padre bramino si applica con tutte le sue energie per evitare al figlio cosí dotato ogni contatto con il male, in tutte le sue apparenze: la povertà, la malattia, la morte. Ciò è impossibile, e al primo contatto con la realtà incancellabile della vita, Siddhartha è profondamente scosso e comprende immediatamente che tutta la sua erudizione e tutta la ritualistica non lo aiutano a conseguire la vera conoscenza. Dove può essere la stretta porta che conduce al vero? si chiede il giovane bramino. Certo è la prima ormai insuperabile risposta: il senso dell’essere non è nella casa paterna, nella pratica devota e ritualistica, isolata dalla vita vera. E cosí inizia il lungo peregrinare del giovane ricercatore, e a nulla valgono le preghiere, le suppliche del padre. La voce interiore è cosí forte che Siddhartha tutto lascia, agi, ricchezze, certezze religiose. Abbandona tutto alla ricerca del tutto, seguito dal suo fidatissimo amico Govinda. E comincia la prima stazione della ricerca presso alcuni asceti nella giungla, dove i giovani amici si esercitano a privarsi di tutto, a evitare qualsiasi tentazione e richiamo, applicandosi nella concentrazione e nella meditazione, sulla scia della pratica di severe rinunzie operate dagli asceti piú anziani e piú avanzati. Il giovane intuisce che tali pratiche sono espressione di un pensiero interiore che non è vivente, si tratta di mere esercitazioni tramandate ed eseguite senza sorgere dal nucleo profondo dell’individuo. A lungo soggiorna nella giungla fino a una prima, rivoluzionaria Illuminazione, che comunica all’amico: «Lungo tempo ho impiegato, Govinda, e non ne sono ancora venuto a capo, per imparare questo: che non si può imparare nulla! Nella realtà non esiste, io credo, quella cosa che chiamiamo “imparare”. C’è soltanto un sapere, che è ovunque, che è Atman, che è in me e in te e in ogni essere. E cosí comincio a credere: questo sapere non ha nessun peggior nemico che il voler sapere, che l’imparare [H. Hesse, Siddhartha, Adelphi, Milano 1973].
Si può ben immaginare lo scompiglio provocato nel giovane amico, completamente ignaro di questa intuizione. Tale sfiducia, per la via spirituale, dei mezzi meramente umani, come l’imparare, rivela già la radice nordica e luterana dell’‘indiano’ Siddhartha. In uno scritto Hesse dice chiaramente che il racconto, dalle vesti orientali, è in realtà rivolto agli occidentali, agli uomini d’oggi: «Siddhartha è un libro molto europeo, malgrado la sua ambientazione, e la dottrina di Siddhartha parte proprio dall’individuo, prendendolo cosí seriamente come non lo fa nessuna dottrina asiatica, Siddhartha è l’espressione della mia liberazione dal pensiero indiano. …La via della mia liberazione da ogni dogma, anche da quello indiano, conduce fino a Siddhartha e proseguirà naturalmente per tutta la mia vita» [Cit. in M. Freschi, Hermann Hesse, Il Mulino, Bologna 2016].
L’India, la “madre” India, rappresentava nella famiglia una meta spirituale presente e venerata. Il nonno materno, come abbiamo detto, era un’autorità negli studi dell’indologia, sua madre e suo padre erano stati nella missione pietista in India. Hermann aveva contestato anche fieramente la via indicata dai genitori di diventare un pastore, ma il prestigio della saggezza indiana era rimasto intatto. Nel 1911 aveva intrapreso un viaggio che sarebbe dovuto giungere in India, ma che venne soltanto sfiorata con un soggiorno a Ceylon. Ma l’impressione rimase e risvegliò quella nostalgia per una dimensione spirituale, per un’esperienza del sacro altra da quella del pietismo ortodosso. L’insegnamento di quello strano viaggio fu un primo superamento delle immagini orientalizzanti, interiorizzate e mutuate dall’atmosfera culturale familiare: «Noi ci rechiamo pieni di nostalgia verso il Sud e l’Oriente, spinti da uno scuro e grato presentimento di patria, e troviamo qui il paradiso, la pienezza e la ricca abbondanza di ogni dono della natura, troviamo gli schietti, semplici e infantili uomini del paradiso. Ma siamo noi stessi ad essere differenti, noi qui siamo stranieri e senza cittadinanza, da gran tempo abbiamo perso il paradiso, e quello nuovo che abbiamo e vogliamo costruire non è da cercare all’equatore o nei mari caldi d’Oriente, ma si trova in noi stessi e nel nostro nordico futuro» [H. Hesse, Siddhartha, op.cit.].
Piú chiaro di cosí nel superare quella struggente nostalgia orientale! Il racconto raffigura quella immagine spirituale, venerabile, dell’Oriente, ma la comprende come una modalità di un’altra epoca spirituale, di un’altra umanità, con la sua pur sublime spiritualità, con la sua semplicità, sicurezza nella tradizione, non piú proponibile all’uomo occidentale moderno. Ormai Hesse comprende che l’uomo del suo tempo deve affrontare un altro itinerario, emancipato dalle suggestive certezze della fede, dei rituali, della devozione ai venerabili maestri. Ai suoi contemporanei indica una possibilità di realizzazione spirituale, al di là delle pratiche devozionali e persino delle severe ascesi dei tradizionalisti, che nel racconto sono dapprima i bramini e poi gli asceti della foresta, che credono di raggiungere la conoscenza con pratiche di digiuni, di veglie e di rinunce di ogni genere.

Siddhartha e Govinda discepoli del Buddha
Avventurandoci nel testo si comprende questa intenzione dell’autore: nelle parole di Siddhartha riaffiora la conquista del pensiero luterano della rinuncia alle pratiche esteriori della devozione, ché la salvezza sorge dall’interno come conquista. Hesse non è certo un luterano, se lo fosse non sarebbe fuggito dal seminario di Maulbronn, eppure il suo itinerario parte proprio da quella realizzazione luterana della libertà dell’anima che prescinde dalla mediazione sacerdotale. Siddhartha deve affrontare un’ulteriore prova. Una volta abbandonati gli eremiti, i samana, per altro molto contrariati dal suo allontanamento, si imbatte con l’uomo piú santo e piú vicino alla verità, a Gotama, ovvero al Buddha storico. Questo incontro rappresenta spiritualmente la prova piú impegnativa. Tutti riconoscono la saggezza dell’insegnamento di Gotama e aderiscono alla sua dottrina, rinunciano ai beni materiali e chiedono di diventare seguaci e monaci del Buddha. Ma Siddhartha è colto da una comprensione diversa da quella dei molti, tra cui l’amico Govinda. In un colloquio con Gotama, il giovane crede di aver compreso il vero senso dell’insegnamento che è quello della libertà da maestri e da dottrine che gli vengono dall’esterno e che non partono dalla conoscenza interiore. È proprio questa la libertà che insegna Buddha. Cosí il protagonista esprime la sua convinzione nel dialogo con il Buddha, che è il centro del racconto e anche il momento di maggiore tensione, rappresentando una conferma della suggestiva imitazione dell’atmosfera indiana: «Molto contiene la dottrina del Buddha cui la rivelazione è stata largita: a molti insegna a vivere rettamente, a evitare il male. Ma una cosa non contiene questa dottrina cosí limpida, cosí degna di stima: non contiene il segreto di ciò che il Sublime stesso ha vissuto, egli solo tra centinaia di migliaia. Questo è ciò di cui mi sono accorto, mentre ascoltavo la dottrina. Questo è il motivo per cui continuo la mia peregrinazione: non per cercare un’altra e migliore dottrina, poiché lo so, che non ve n’è alcuna, ma per abbandonare tutte le dottrine e tutti i maestri e raggiungere da solo la mia meta o morire [H. Hesse, Siddhartha, op.cit.].
Il giovane, non piú bramino, non piú samana, non diventa nemmeno un monaco del Buddha, per superare l’ostacolo piú grande: quello della venerazione del Sublime, al fine di realizzare l’epifania del divino – della libertà – nell’uomo. Ciò che affascina nel racconto, nell’itinerario del giovane, è il superamento di grandiose realtà spirituali, sempre nel riconoscimento del valore delle esperienze. Il piú alto incontro è quello con il Sublime, con il piú grande Maestro, il Buddha, l’Illuminato, il cui valore morale, la cui grandezza spirituale Siddhartha riconosce e rispetta, ma non percepisce piú come sua la via del Buddha, la venerazione del Sublime Maestro. In questo Siddhartha diviene il nuovo mito di questo tempo, in quanto precursore dell’uomo della modernità: senza maestro, senza dottrina, senza via, ché è lui stesso maestro, dottrina, via a se stesso. Solo da questa sensibilità moderna si può resistere al Buddha, il meraviglioso maestro dell’età premoderna (cui potremmo aggiungere il Cristo storico): «Ho visto un uomo, pensava Siddhartha, un uomo unico, davanti al quale ho dovuto abbassare lo sguardo. Davanti a nessun altro voglio mai piú abbassare lo sguardo: a nessun altro. Nessuna dottrina mi sedurrà mai piú, poiché non m’ha sedotto la dottrina di quest’uomo. Il Buddha …mi ha donato Siddhartha, mi ha fatto dono di me stesso [op.cit.].
Il giovane s’incammina sulla via del risveglio, il suo, quello non piú mediato da maestri, religioni, insegnamenti esterni: infatti era scomparso in lui: «il desiderio di avere maestri e di conoscere dottrine. L’ultimo maestro che era apparso sulla sua strada, il sommo e sapientissimo maestro, il piú santo di tutti, il Buddha, anche questo egli aveva abbandonato, aveva dovuto separarsi da lui, non aveva potuto accogliere la sua dottrina [op.cit.].
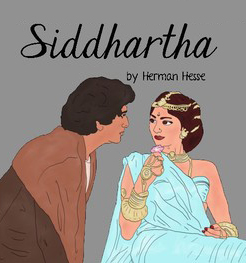
Siddharta e Kamala
A questo punto il racconto potrebbe interrompersi con la salita in gloria di Siddhartha quale maestro dei tempi nuovi, ma in realtà è piú santino che maestro autentico. Con questo risveglio termina la prima parte e subentra la stasi della scrittura e la crisi sciolta dall’intervento di Jung. A Siddhartha manca la vita, scopre la solitudine, anche l’amico di una vita, Govinda, l’ha abbandonato per entrare nella comunità dei monaci. E Siddhartha prosegue la sua peripezia aprendosi, lui il dotto bramino, il coerente samana, l’interlocutore del Buddha, alla vita nella sua forma piú seducente: quella dell’amore sensuale per la bella Kamala, una raffinata cortigiana, che l’accetta a condizione che smetta di apparire il samana, magro, emaciato e trascurato, che non è piú, per divenire un autorevole giovane uomo, ricco e rispettato. Apparentemente un salto mortale, ma anche un’apertura alle energie della vita vissuta in cui realizzarsi. La tentazione di essere al di sopra degli uomini comuni, di essere ancora padrone delle sue pulsioni, lo conduce ad immergersi sempre piú nella società con i suoi commerci, le sue passioni. Lentamente le facoltà acquisite negli esercizi ascetici, saper pensare, saper aspettare, saper digiunare, si consumano nella mollezza del lusso, delle ricchezze, dell’eros, che lo logorano interiormente, avvicinandolo alla maggioranza degli uomini.
Con un residuo di forza e di dignità, Siddhartha abbandona quel mondo, percependone la forza, le insidie. Era entrato in città come un eroico asceta e la lascia come uno sconfitto che torna al fiume, quello che aveva attraversato per recarsi in città. Finalmente comprende di aver distrutto un patrimonio spirituale, che non era quello che veramente lo appagava, ma che pur tuttavia aveva una straordinaria dignità, quella della tradizione dell’ascesi, dell’insegnamento spirituale. In preda alla disperazione pensa di porre fine alla vita, a un’esperienza che lo aveva travolto. Ora è la voce del fiume che gli comunica il senso dell’eterno fluire della vita. «Ora Siddhartha intuí pure perché da Brahmino, da penitente, avesse invano lottato col proprio io. Troppa scienza l’aveva impacciato, troppi sacri versetti, troppe regole per i sacrifici, troppa mortificazione, troppo affanno di azione! Pieno di orgoglio era stato, sempre il piú intelligente, sempre il piú diligente, sempre di un passo davanti agli altri, sempre lui a sapere, sempre lui a vivere nello Spirito, sempre lui il sacerdote o il saggio [op.cit.].
In questo riconoscimento della natura luciferica della prassi devota, nella pratica sacerdotale, percepisce il peccato piú grave: quello dell’orgoglio, con la superba presunzione di avvicinarsi all’Atman come le sue sole forze. Qui affiora la radice luterana della cultura spirituale di Hesse. Anche Lutero aveva gettato la tonaca alle ortiche, lui il coerente monaco, l’asceta severo, l’intransigente agostiniano, l’inflessibile maestro, l’erudito dottore di Wittenberg, che improvvisamente intuisce che il suo era un itinerario luciferico, era sfidare la divinità con la finitezza umana. Cosí Siddhartha: «In questo sacerdozio, in questo orgoglio, in questa spiritualità, s’era annidato il suo io, là sedeva indisturbato e prosperava, mentre egli credeva d’ucciderlo con digiuni e penitenza. Ora se ne accorgeva, ora vedeva che la voce segreta aveva avuto ragione, che nessun maestro mai lo avrebbe potuto liberare» [op.cit.].

Sisshartha e Govinda al fiume
Consapevole del suo peccato d’orgoglio, il piú subdolo e il piú insidioso, si era smarrito nel mondo, dandosi ai piaceri e al potere, alle donne e all’oro. Piccoli peccati di fronte alla superbia luciferica di voler erigersi a dio con le proprie forze, di voler abbattere l’io con le energie dell’io, che cosí sempre piú s’irrobustiva, cresceva. Che fare? Finalmente l’intuizione: non fare piú nulla di ciò che aveva sempre fatto. In quella volontà di potenza risiedeva il dolore, l’inquietudine, la sofferenza. Abbandonarsi ad ascoltare il fluire del fiume. E in quel fluire Siddhartha s’identifica, pur nella solitudine e nella contemplazione del fiume, estremo simbolo del divenire. Rincontrando, dopo tanto tempo, il fedele amico della giovinezza, Govinda, devoto monaco buddista, tenuto alla povertà e alla peregrinazione, gli annuncia che anche la sua vita è movimento, il moto inesauribile del flusso della vita: «Disse Siddhartha: “Anch’io mi trovo in una condizione come la tua, amico. Non vado in nessun posto. Sono soltanto in cammino. Vado errando”».
Un’altra stazione di questo lungo cammino interiore che partecipa di un’evoluzione spirituale, che ha attraversato le esperienze del distacco e dell’ascesi, ma che ormai ha anche conosciuto le seduzioni della mondanità. Ora sí che la via di Siddhartha non coincide piú con quella degli asceti, con quella delle rinunce e dell’ignoranza del mondo con tutti i sui vasti e variegati orizzonti. L’uomo conosce anche la vanità del mondo per averla sperimentata, per esservisi immerso e infine per essersene consapevolmente allontanato, dopo essersi misurato e aver vinto le sfide del mondo. Cosí la sua esperienza si è approfondita e arricchita e il suo percorso acquista una consapevolezza illuminata dalla conoscenza. Il racconto, nella sua suggestiva atmosfera indiana, è un limpido e reiterato confronto, svolto nelle sue molteplici variazioni, con la tradizione spirituale del cristianesimo luterano. Non si nasce e cresce invano in un ambiente intimamente radicato nel pietismo e nella spiritualità protestante. L’autore del racconto aveva intuito, ancorché oscuramente, che per essere nel solco di quella intuizione di libertà interiore occorreva eseguire l’estremo passo nel superamento della pratica pubblica, universalmente accettata e riconosciuta, della devozione. Nelle profondità del proprio io viveva la libertà spirituale. Aveva compreso il nucleo piú autentico della dottrina del Buddha non divenendone un seguace, cosí come Hesse aveva portato alle estreme conseguenze il messaggio di libertà di Lutero, emancipandosi da ogni chiesa, dottrina e tradizione: «Da lungo tempo sapeva di non essere piú separato da Gotama, sebbene non avesse accolto la sua predicazione. No, l’uomo che cerca veramente, l’uomo che veramente vuol trovare, non può accogliere nessuna dottrina».
Di nuovo affiora luminosa l’intuizione di essere giunti alla meta. Ma il karma, il destino di una vita vissuta, non perdona nessuno e cosí riappare Kamala, convertita al messaggio del Buddha, in cammino verso il maestro insieme al figlio, nato dall’ultimo, dal piú intenso e struggente amplesso con Siddhartha, quello del languido abbraccio del commiato. Il fanciullo è nato dall’appassionata dedizione della donna, che lo ha allevato nel lusso e negli ozi, per poi condurlo con sé nella scelta monastica. Giunta al fiume dove Siddhartha vive come barcaiolo, la donna muore, punta da un serpente, dopo aver confessato all’amato di un tempo che il fanciullo è suo figlio. Siddhartha lo prende con sé, ma il ragazzo gli è ostile e odia quella vita misera, quel silenzio, quell’esistenza noiosa con i due vecchi barcaioli, Siddhartha e il suo saggio amico Vasudeva. Malgrado gli sforzi, il ragazzo diviene sempre piú maldisposto e nemico del genitore, che si cruccia e si addolora per questa animosità. Infine il ragazzo fugge con la barca e spezza i remi per non essere inseguito. La ruota della vita gira e cosí come un tempo era stato Siddhartha ad aver lasciato il padre e la famiglia nel dolore, è ora lui a provare la medesima sofferenza, e finalmente comprende, raggiunge l’ultima stazione, quella dell’accettazione del destino, del karma, con l’intuizione che deve concedere al ragazzo la sua libertà e che lui stesso deve sciogliere quel vincolo di sangue e di generazione, che per lui improvvisamente si rivela la prova piú ardua, la sofferenza piú aspra: «Siddhartha intuí …ch’egli non poteva aiutare suo figlio, e non doveva vincolarsi a lui. Profondamente sentí in cuore l’amore per il figlio fuggito, come una ferita, e sentí insieme che la ferita non gli era data per rovistarci dentro e dilaniarla, ma perché fiorisse in tanta luce».
L’ultima, la piú dolorosa, irrimediabile ferita della vita. Lui non ci può fare nulla, non la può allontanare da sé, è là con sofferenza, e tutte le arti della dottrina, della magia, dell’ascesi, del dominio dell’io e del pensiero risultano inutili. Qui è il sangue, la propria carne, e l’insegnamento non aiuta. Solo la sofferenza aiutav Come ritrovare il figlio fuggito? Improvvisa l’illuminazione: l’unità del tutto, l’unità di tutte le creature. Qui è proprio lo scrittore che diventa, dopo l’estremo dolore, in virtú dell’acuta sofferenza, l’annunciatore della sua dottrina, del suo insegnamento, che trascende letteratura e racconto per attingere la sapienza della vita: «Lentamente fioriva, lentamente maturava in Siddhartha il riconoscimento, la consapevolezza di ciò che realmente sia saggezza, quale fosse la meta del suo lungo cercare. Non era nient’altro che una disposizione dell’anima, una capacità, un’arte segreta di pensare in qualunque istante, nel bel mezzo della vita, il pensiero dell’unità, sentire l’unità e per cosí dire respirarla»..
Intuire, vivere l’unità, aver scoperto infine il pensiero dell’unità di là dall’ordinario pensare dialettico, quello fuggevole, sfocato, dispersivo della molteplicità di tutti i giorni, della superficialità non viva del pensiero della quotidianità è la metà raggiunta. Il racconto ‘indiano’ si conclude con il dialogo, intessuto di quelle suggestive atmosfere orientali, in riva al grande fiume, tra Siddhartha e il monaco Govinda, l’amico di un tempo. Govinda, il pio monaco, chiede all’amico lumi per giungere alla liberazione. E Siddhartha: «Vedi, Govinda, questo è uno dei miei pensieri, di quelli che ho trovato io: la saggezza non è comunicabile». Incomunicabilità dell’esperienza interiore di fronte all’unità del tutto, attingibile – ecco l’ultima parola del saggio – dall’amore. Il racconto è l’apologia della liberazione con le proprie forze.
In un aforisma di quegli anni, Kafka scrive che chi cerca non trova, perché l’essenza del cercatore sta nella ricerca. Il racconto di Hesse è una grandiosa, luminosa poesia di Siddhartha, l’eroe dello Spirito al di là di dottrine, insegnamenti e maestri. Eppure non sarà del tutto inutile spezzare una lancia per il povero, umanissimo Govinda, entusiasta, devoto, sempre alla ricerca, in questo assai piú umano dell’eroico Siddhartha. Nel profondo inchino finale di Govinda all’amico, ormai suo maestro iniziatore, palpita tutta la sua umanità e la speranza che la ricerca in ultima istanza, se pura e devota, conduce all’Illuminazione, o almeno a «tutto ciò che nella sua vita vi fosse mai stato di prezioso e di sacro».
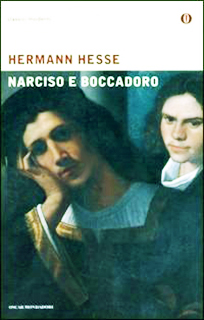
Si può prendere Hesse con i suoi scritti – Siddhartha segna l’acme di questa esperienza poetica e spirituale – come un maestro, persino come il proprio maestro, con il consenso appassionato di alcuni e la riprovazione di altri. Tuttavia Hesse è un Dichter, uno scrittore autentico, un poeta, un poeta tedesco vicino ai romantici, anche loro dei Sucher, dei Gottsucher, dei ricercatori, ricercatori di Dio. La sua poesia sa identificarsi con l’insegnamento spirituale ed esistenziale, e proprio cosí, in quanto annunciatore di insegnamenti di vita e di libertà, Hesse realizza la sua piú autentica verità poetica, che si conferma anche nelle opere successive in varie modalità: in Lupo della steppa, ambientato in una città – probabilmente Zurigo, dove svernava in un appartamento di amici munito di riscaldamento – che è l’intrigante racconto della spaccatura dell’uomo contemporaneo tra la coscienza intellettuale, il costume borghese e la parte ‘lupina’, indomabile dell’inconscio.
Successivamente lo scrittore si cimenta con un romanzo ‘storico’: Narciso e Boccadoro, dove torna il tema della divisione della personalità, raffigurata dai due indimenticabili amici.

Poi nel 1943, dopo dieci anni di lavoro, esce la sua opere piú vasta e impegnativa. Un romanzo che è un’utopia, che difende i valori della spiritualità. Esce prima in Svizzera e nel 1946 – l’anno del conferimento del Premio Nobel per la letteratura – in Germania: Il giuoco delle perle di vetro. Saggio biografico sul Magister Ludi Josef Knecht, pubblicato insieme con i suoi scritti postumi a cura di Hermann Hesse. Già il titolo indica uno stile antiquato, erudito, che non ci si aspetterebbe proprio da un romanzo utopico. Il romanzo pare piuttosto una leggenda medievale con quella comunità di Castalia di asceti e monaci. Il nome del protagonista segnala la sua vera vocazione: Giuseppe Servitore, Josef Knecht, che sale gradualmente tutti i gradini dell’Ordine di Castalia fino ad assurgere alla dignità di Gran Maestro del mistico giuoco delle perle di vetro, simbolo mirabile della libertà d’azione, sciolta da ogni utilitarismo, calcolo. Un’ampia storia ricca di figure, vicissitudini, racconti, esperienze di purificazione, di sublimazione. E il protagonista, raggiunta la cima degli onori, degli oneri, della scienza del misterioso e libero giuoco, a sorpresa lascia tutto. Abbandona Castalia, le vette, e scende in pianura per diventare un semplice, un modesto Magister ludi, maestro elementare, precettore di un adolescente ribelle e ostinato, che non accetta disciplina, consigli, l’autorità dei genitori. Il padre del giovane Tito, disperato, si rivolge a Josef, l’amico d’infanzia. Josef comprende che per raggiungere l’anima del ribelle occorre lasciare la città. Entrambi si avviano in montagna, per cementare un dialogo col giovane. All’alba del loro primo giorno, Tito, entusiasta del paesaggio, si getta in un laghetto alpino, dall’algida acqua, invitando il maestro a seguirlo. Benché stanco del lungo viaggio e dell’ascesa sul monte, Josef segue Tito per non deluderlo e per costruire cosí con lui una comunanza, ma viene stroncato da un improvviso malore letale. Inutile tutti gli sforzi del giovane, che lentamente comprende il sacrificio d’amicizia, e alla fine del romanzo e della tremenda esperienza che è anche una iniziazione all’amore, Tito percepisce con un immenso dolore il messaggio del maestro: «Ahimè, pensò atterrito, ecco che della sua morte sono io il colpevole! E soltanto allora, quando non v’era piú da far valere la superbia né da opporre alcuna resistenza, sentí nella pena del cuore spaventato quanto avesse già preso a voler bene a quell’uomo. E mentre, nonostante le obiezioni, si sentiva colpevole della morte del Maestro, lo prese con un sacro brivido il presentimento che quella colpa avrebbe trasformato lui stesso e la sua vita e preteso da lui cose molto piú grandi di quante fino allora egli avesse mai pretese da se stesso» [H. Hesse, Il gioco delle perle di vetro, Mondadori, Milano 1980].
Dopo piú di vent’anni dal racconto della fuga del figlio ostile al padre, a Siddhartha, questa volta a mo’ di chiusura del cerchio di fronte al sacrificio del Maestro è un giovane che s’inchina al mistero iniziatico dell’amore dell’insegnamento. In Tito si redime il figlio di Siddhartha e in Josef Knecht, il maestro della libera azione – simbolizzata dal gioco-rinuncia alla maestria per un gradino superiore, quello del sacrificio per un amore puro, ideale. L’io si sublima, cristicamente, nel prossimo. Al di là ormai per Hesse c’è solo il silenzio degli ultimi vent’anni.
Non è necessario condividere le prospettive spirituali e intellettuali di Hesse, è sufficiente percepire l’intensa bellezza della sua lingua, l’arditezza e l’originalità delle sue costruzione letterarie. Il suo insegnamento è stata la sua piú potente sollecitazione a scrivere, e lo scrivere era comunicazione per l’autore dell’intramontabile fiducia nella possibilità dell’uomo contemporaneo di ritrovare se stesso, di comprendere l’universo mentre comprende se stesso. Lo scrittore riuscí a scrivere solo perché animato da quella fede, spesso non condivisa dai critici, sovente polemici e detrattori di quel vago spiritualismo, mentre i lettori, specie i giovani degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, sono stati piú clementi, mostrandosi frequentemente entusiasti seguaci, sicuri di aver trovato in Siddhartha un autentico maestro. Ora siamo piú distaccati da quella sensibilità – quella tipica dei “figli dei fiori”– e ci accostiamo alla sua opera riconoscendone il valore letterario, poetico, ma anche commossi per questa fede in un tempo di decadenza delle tradizioni religiose.
Marino Freschi

