
Nello studio di un celebre psichiatra si presentò un giorno un uomo apparentemente ben equilibrato, serio ed elegante. Dopo alcune frasi, però, il medico scoprí che quell’uomo era intimamente abbattuto da un profondo senso di malinconia e da una tristezza continua ed assillante.
Il medico iniziò con grande coscienziosità il suo lavoro terapeutico e, al termine del colloquio, disse al suo nuovo paziente: «Perché non va al circo che è appena arrivato nella nostra città? Nello spettacolo si esibisce un famosissimo clown che ha fatto ridere e divertire mezzo mondo: tutti parlano di lui, perché è unico. Le farà bene, vedrà». Allora quell’uomo scoppiò in lacrime, dicendo: «Quel clown, sono io».
April, 14 anni: «C’è una cosa che mi preoccupa tantissimo… ed è: come faccio a capire quando è ora di recitare la mia parte? Quand’è che posso essere realmente me stessa? Io fingo perché spesso non me la sento di mostrarmi come sono, un po’ come se questo non dovesse piacere agli altri. Non so, forse è una preoccupazione che tutti hanno, forse anche gli altri vorrebbero non dover sembrare sempre piú furbi, piú forti di quel che sono».
[da: Bruno Ferrero, Il Canto del Grillo, ElleDiCi].
In questa piccola storia – e nel breve pensiero giovanile che l’accompagna – appare nitida l’immagine della crisi adolescenziale.
Le premesse di questa crisi sono già rintracciabili a partire dal nono anno di età del bambino e sono associate all’irruzione di sentimenti di insicurezza e solitudine. Compare per la prima volta nella coscienza dei ragazzini la «poetica delle maschere» ossia la percezione di indossare costantemente una maschera. Questa maschera nasconde agli altri la propria intima essenza.

I ragazzi e le ragazze possono avere una vita sociale brillante, pubblicare degli autoscatti sorridenti sui social, per poi ritirarsi nella propria solitudine e pensare: «Chi mi conosce realmente? Quanto dovrò continuare a fingere di essere quel che non sono?».
Il tema della questione è l’affiorare di un mondo interiore che diventa sempre piú fitto e vasto. Questo mondo dev’essere scoperto, esplorato e conosciuto. Il ragazzo dovrà imparare a vivere in questi due mondi distinti (quello interiore e quello esteriore) e dovrà riuscire ad armonizzarli. Lo sfasamento tra ciò che accade nella vita interiore e ciò che accade nella vita esteriore genera disorientamento e produce angoscia.
Lo sfasamento tra queste due realtà, unito ai grandi cambiamenti fisici e neurologici tipici di questa età, provoca sentimenti di derealizzazione e depersonalizzazione. La realtà appare agli occhi del ragazzo finta o irreale. Per irrealtà intendo la sensazione di trovarsi in una sorta di Truman Show dove tutto è recita. Recitano i passanti, i commessi nei negozi, recitano gli insegnanti e i genitori…
Anche i mobili della propria abitazione possono apparire come gli oggetti di un set cinematografico: anche per questo nasce il bisogno di rivoluzionare i propri spazi.
Quando si parla di depersonalizzazione e derealizzazione nei giovani, non si deve necessariamente pensare all’irrompere di uno stato patologico. A questa età è normale provare questo scollamento da se stessi e dalla realtà.
«Io esisto veramente?», «Sono veramente qui?», «Cosa percepiscono gli altri di me?» Questi pensieri accompagnano i sentimenti di depersonalizzazione.
Domande del genere attraversano come nuvolaglie la coscienza dei ragazzi e spingono alcuni ad atteggiamenti piuttosto plateali. Per “sentirsi” i ragazzi possono arrivare a ferirsi, a tagliarsi: sono risposte non necessariamente evidenzianti uno stato patologico.
La teatralità di certi gesti corrisponde al fatto che in questa età – lo ripeteva spesso il mio maestro di pedagogia – tutte le patologie “si presentano sul palcoscenico” e ci informano della loro esistenza. Le forme dell’angoscia e della paura, dell’isolamento, della depressività e dell’aggressività si impongono alla coscienza: questa presentazione, però, non vuol dire che i ragazzi siano malati o disturbati.

Le patologie che si presentano sul palcoscenico della coscienza giovanile sono anche patologie ontiche o spirituali – come le definisce Costantin Noica nel suo Sei malattie dello spirito contemporaneo – e appartengono al nostro tempo, alla nostra contemporaneità.
Attraverso questa presentazione il giovane incontra anche il lato oscuro del mondo e ne prende atto. Le crisi si presentano con i caratteri tipici della crisi e non attraverso il paradigma sociale del “va tutto bene”, emblema della cosiddetta normalità: è una constatazione ovvia e tuttavia sempre piú fraintesa.
Balenando in burrasca
La crisi puberale è l’archetipo delle crisi biografiche. L’oblío ci fa dimenticare le nostre crisi adolescenziali nonché le forze messe in atto per attuarne il superamento, eppure ogni qualvolta che da adulti ci ritroviamo gettati in una crisi biografica, sperimentiamo nuovamente quanto provato da ragazzi: la perdita del senso dell’esistenza e della capacità di dirigere la propria vita.
Ne consegue che una crisi puberale sperimentata appieno e superata mettendo in gioco tutte le proprie risorse costituirà una sorta di immagine, di calco, per il superamento delle crisi che compariranno sul cammino dell’individualità.
In questo periodo storico anche la crisi puberale sembra venir considerata come una sorta di malattia, di disturbo. Nelle scuole, in particolare, non vi è spazio per lo sviluppo degli adolescenti.
Le scuole si occupano sempre piú di istruire e sempre meno di accompagnare i ragazzi alla scoperta del mistero della vita e dell’essere. I ragazzi hanno bisogno di viaggiare, di movimento e di apprendere attraverso l’incontro con altri esseri umani, possibilmente degni del loro interesse.
In movimento
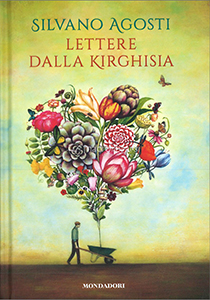
«I ragazzi e i giovani vengono obbligati a starsene seduti, tra scuola e compiti, circa otto ore al giorno, e alla fine dei loro corsi di studi, a qualsiasi domanda culturale, il loro sguardo vaga smarrito o si esprime in un “boh!”» [da: Silvano Agosti, Lettere dalla Kirghisia].
Movimento non vuol dire percorrere uno spazio da un punto A a un punto B. Ci muoviamo verso gli altri, orientiamo i nostri interessi, dirigiamo la nostra attenzione, andiamo incontro al nostro destino… Queste espressioni ci ricordano che siamo responsabili del nostro movimento ed è la capacità di muoversi all’interno delle vicende biografiche a caratterizzare il nostro sviluppo individuale. La qualità con cui dirigiamo noi stessi nei momenti cruciali o nella quotidianità della vita costituisce il fondamento della biografia umana, eppure tale movimento passa pressoché inosservato. Non vi è attualmente un’educazione per questo. Anzi. Tutto ciò che compiono gli esseri umani – dalla scuola materna fino all’università – è un’educazione alla ricezione passiva, allo stazionamento e all’inerzialità. Il dinamismo conoscitivo è dunque sostituito da un immobilismo conoscitivo. Ci si lamenta della crisi di valori dei giovani, della loro incapacità a “darsi una mossa” , della loro mancanza di entusiasmo, e non ci si accorge che vengono educati, sin dalla prima infanzia, alla staticità.
La cosa assume caratteristiche ancora piú paradossali e grottesche durante l’adolescenza – l’età di maggior apertura al mondo – quando i ragazzi, piú che in qualsiasi altra età – vengono costretti all’immobilità laddove il movimento dovrebbe diventare il fulcro dell’azione educativa.

L’immobilità fisica, con cui i bambini vengono educati, insegna a stare al proprio posto e produce quell’immobilità interiore che diviene propedeutica alla relazione con i social, con i mezzi di comunicazione di massa. Il presupposto per una dipendenza da tali mezzi e strumenti è proprio l’atrofia del movimento fisico e interiore. Si resta per ore e ore davanti al tablet, all’iPhone cosí come per anni si è rimasti immobili su una sedia: la relazione con i mezzi di comunicazione di massa è la rappresentazione di un movimento interiore che invero non c’è.
Le avventure e i viaggi che vorrebbero sperimentare i ragazzi sono sostituiti da quei surrogati che offrono soltanto la messinscena del movimento: social, televisione, video-games…
La formazione scolastica non dovrebbe essere disgiunta dal desiderio dei ragazzi di andare incontro alla vita. La formazione dovrebbe fluire attraverso la vita stessa e quindi la vita stessa dovrebbe divenire luogo di formazione.
È proprio questa paralisi fisica, congiunta alla scissione vita reale-scuola, ad amplificarne il senso di smarrimento e derealizzazione.
Cosa possiamo fare
I ragazzi dovrebbero conoscere veri artisti, veri esperti delle discipline che studiano e recarsi da loro, nei loro atelier, studi, botteghe. È importante conoscere coloro che realmente utilizzano il pensiero per creare, plasmare, modellare, e non solo quanti vengono formati per trasmettere – senza aver mai creato alcunché – un sapere privo di vitalità.

Frequentare il laboratorio di uno scultore non per apprendere i segreti della scultura quanto per attingere alla sorgente del pensiero che crea. Si apprende molto di piú preparando il pranzo assieme a un poeta che leggendo qualche tediosa antologia.
Non è la poesia ad educare l’animo bensí la poeticità dell’essere, la condivisione di una peculiare visione del mondo. Questo è ciò che possono trasmettere degli artisti autentici.
Dovrebbero essere i ragazzi a muoversi verso la comunità degli artisti e non gli artisti a entrare nelle scuole. In questo modo i ragazzi orienterebbero i loro passi verso il mondo esterno: questa sarebbe una prima educazione al movimento.
I ragazzi devono risvegliare l’entusiasmo in grado di dirigere il loro movimento in modo autonomo e non possono farlo rimanendo seduti! Aiutare gli altri, organizzare qualcosa per chi ha bisogno: nessun ragazzo rifiuterebbe l’idea di poter far qualcosa per chi è in difficoltà. Nessuno!
I ragazzi dovrebbero poter viaggiare con i loro insegnanti non per fare la gita di fine anno ma per il semplice gusto di passare del tempo assieme. Viaggiare in barca, mangiare all’aperto e poi studiare insieme. Sono idee percorribili, non utopie.
Nicola Gelo (1. continua)
