
Gli esseri umani della nostra epoca sembrano mostrare una piú acuta autocoscienza, derivante dal porre l’accento sulla forza di volontà e sull’efficienza in tutti i ceti sociali, mentre il mondo dei sentimenti e della contemplazione si allontana sempre piú sullo sfondo.
L’uomo sembra piú forte, piú sicuro di sé. Ma ci si potrebbe giustamente chiedere se non abbia appena sollevato la superficie della sua coscienza nel regno di quella forza e della fiducia in se stesso. Potrebbe anche essere che l’uomo si sia spinto cosí lontano nell’apparenza da avere in essa tutta la sua forza e la sicurezza di sé, e che il suo essere reale sia cosí logoro e offuscato da lasciarle tutto lo spazio, anche quando il mondo dell’apparenza lo ha messo di fronte al proprio fallimento.
La psicanalisi e la psicologia analitica hanno spesso avuto un sentore di quel dualismo nella coscienza umana – dell’“essere” contro l’“apparire” – ma i rimedi che suggerivano non erano altro che le sponde di quella coscienza discorsiva che dovrebbe essere sanata, poiché è il risultato diretto di un tale conflitto interiore. Tutti i miglioramenti a cui hanno portato sono stati ingannevoli e di breve durata, poiché hanno semplicemente lasciato entrare nella coscienza una quantità di imaginazioni insolite, allontanandola cosí dai suoi problemi per un po’, e portando a ricadute piú gravi in seguito.
La superficialità della psicanalisi e di altri metodi di quel tipo porta a pensare che la psicologia sia pronta per nuovi progressi e scoperte. La psicologia in sé si occupa dei misteri della vita dell’anima, è profondamente connessa con il mondo sovrasensibile e si occupa di elementi puramente spirituali. La psicologia occidentale, cosí come la psicanalisi, manca interamente di tale base. I metodi materialistici applicati ai soggetti spirituali non portano da nessuna parte. Nella psicologia analitica lo scopo è nuovo, ma il vecchio tipo di ricerca strumentalmente legata al cervello come suo mediatore contingente è rimasto esattamente lo stesso.

Chi parte da intuizioni che erano familiari alla metafisica indiana e mantiene chiara alla loro base la distinzione tra il pensiero e il suo strumento fisico, consapevole della qualità speculare del pensiero umano in quanto dipendente dalla funzione del sistema nervoso centrale, saprà che esteriormente l’apparenza delle cose, l’esperienza sensibile e la vita psichica ad esse connessa, derivano dal fatto che “da qualche parte” nella costituzione dell’uomo il suo essere interiore è legato al mondo sensoriale. Il cervello è la sede di quello scambio, il supporto fisico che riflette – e altera – la luce dell’anima. Ma dove l’anima è legata alla materia fisica, sorge la coscienza di veglia, che è quindi una coscienza riflessa, poiché attraverso di essa nasce la Maya in un mondo percepito come “esterno”. Attraverso il cervello, l’anima dell’uomo affonda le sue radici nel mondo. Ecco perché l’Albero della Creazione (M. Eliade, Trattato di storia delle religioni) è rappresentato con le radici rivolte verso l’alto, mentre i suoi rami e i suoi fiori sembrano germogliare verso il basso. L’ideogramma mitico e metafisico dell’albero capovolto, che si ritrova nelle tradizioni greca (U. Holmberg, Der Baum des Lebens) e islamica (A.J. Wens’nck, Tree and Bird as Cosmological Symbols in Western Asia) e nelle dottrine segrete ebraiche (Zohar, Beha Alotheka) è presente anche nella mitologia indú: l’albero Asvattha delle Upanishad e la Bhagavadgītā (Katha-Upanişad (VI, I); Bhagavad Gītā (XV, 1-3). Il suo senso ultimo è che l’uomo, in quanto essere cosmico, ha le sue radici in cielo, e che è soggetto a dimenticare la sua origine cosmica in quell’organo con il quale entra in contatto con il mondo dei sensi. La sua vera conoscenza consiste nel ritrovare in sé quell’altezza che giace nelle profondità del suo essere.
Questa visione pittorica della realtà interiore indica chiaramente che le profondità dell’anima non possono essere sondate dalla dialettica, vale a dire da un’attività riflessa della mente che è tagliata fuori dalla fonte stessa della vita dell’anima. Solo l’anima può giustificare se stessa, ovvero il castello dell’anima è accessibile solo alle forze dell’anima.
In altre parole, nessuna mentalità scientifica da laboratorio può penetrare in un mondo che, per sua stessa natura, elude qualsiasi formulazione e sfugge a definizioni scientifiche e dialettiche. Il piú piccolo non può racchiudere il grande: nessun disco di grammofono può cogliere e riprodurre la musica di Wagner.
Se una scienza spirituale può insegnare la “via”, questo non significa implicitamente che la conoscenza di tale dottrina dovrebbe di per sé consentire al discepolo di trasferirla in un’attività corrispondente. Nella sfera dell’anima nessuno può entrare in forza di una mera conoscenza, cosa rispetto alla quale tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro livello, sono uguali. Quella sfera non soggiace alla presunzione dei valori correnti, ma esige piuttosto una scala di un ordine diverso, secondo valore interiore, chiarezza e impersonalità.
Ciò che ho detto sopra intendeva sottolineare quanto l’odierna psicologia sia lontana da quell’insieme di valori e quanto sarebbe desiderabile una revisione completa della psicologia ai fini di una nuova comprensione dell’Uomo. Ma se ciò dovesse accadere, i ricercatori dovrebbero partire da premesse molto diverse dall’atteggiamento agnostico e positivistico su cui si basa ancora la scienza moderna.
Nella psicologia di Jung la distinzione fondamentale tra introversi ed estroversi (C.G. Jung: Tipi psicologici) non riflette la realtà interiore dell’individuo, ma deriva piuttosto da un fenomenismo empirico. Tracciare il confine tra le persone che vivono nel soggetto e nell’oggetto, o guardare soggettivamente e oggettivamente la realtà dentro di sé porterebbe ad ammettere che dal soggetto stesso dovrebbe essere raggiungibile da un lato una conoscenza di sé strettamente centrata sul soggetto e dall’altro una conoscenza esclusivamente del mondo oggettivo. Dal punto di vista della pura conoscenza questo è piuttosto ingenuo. Qualsiasi individuo che arrivi a sperimentare cosí intensamente la propria introversione da possedersi completamente come soggetto, conquisterebbe allo stesso tempo il mondo oggettivo, poiché un soggetto esiste solo nella misura in cui esiste un oggetto. L’introversione esiste solo nella misura in cui un mondo esterno spinge un soggetto senziente all’isolamento interiore, e l’estroversione nella misura in cui esiste un soggetto forte abbastanza da fondersi nell’oggetto senza perdere se stesso. Perdere se stesso significherebbe non riuscire a sperimentare l’oggetto, cosí come il tipo opposto non riuscirebbe a sperimentare il soggetto, se non potesse vivere fino in fondo la sua vita introversa. L’introversione incompiuta e l’estroversione non raggiunta con perdita del soggetto sono quindi la stessa cosa, due aspetti della stessa situazione psicologica, modalità di esistenza di una coscienza meramente discorsiva e offuscata.
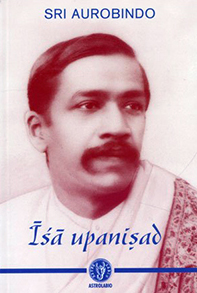
Alla luce della metafisica orientale e con particolare riferimento al Vedanta, il soggetto si limita ad affrontare l’oggetto, atteggiamento determinato da avidyā (inconsapevolezza) che è, da un punto di vista assoluto, una condizione provvisoria, in quanto prelude a una riscoperta del Sé nel Tutto. Nel suo commento all’Isha panishad Sri Aurobindo scrive: «Ogni parvenza di pura soggettività rivela l’oggetto implicito nella sua stessa soggettivazione. Ogni parvenza di mera oggettività risulta nel soggetto implicito nella sua stessa oggettivazione» (Sri Aurobindo, Isha Upanishad). Nella tipologia di Jung non c’è traccia di alcuna nozione metafisica della relazione soggetto-oggetto, secondo la quale il carattere oggettivo dell’asserzione soggettiva è evidente nella prima fase, mentre una fase ulteriore, quella del postulare in modo generale, sta già albeggiando. Quest’ultima necessita di un oggetto, ovvero dirige l’altro elemento in sé implicito, affermando cosí nello stesso tempo il suo divenire. Ma questo divenire potrà apparire soltanto come correlato a uno stadio superiore, dove non c’è lotta per un oggetto. Da questo stadio, nella sua immediatezza, sia l’estroversione che l’introversione si presentano analiticamente come due momenti inseparabili e complementari.
Sinteticamente, d’altro canto, fa nascere l’esperienza oggettiva del soggetto, ovvero l’esperienza della mente in quei differenti gradi di autoespressione che, tra l’altro, prendono la parvenza di natura. Qualsiasi soggetto che effettivamente conquisti se stesso è già penetrato nell’essenza del mondo. Allo stesso modo, chiunque abbia un’oggettiva esperienza goethiana della natura e del cosmo ha già conquistato se stesso come soggetto. Sia l’introversione che l’estroversione, su cui si basa la tipologia di Jung, concernono allo stesso modo un singolo individuo svilito, incapace di cogliere se stesso come un soggetto o il mondo come un oggetto. Molto diverso è l’individuo che può sperimentare se stesso e il mondo, di là dall’estroversione e dall’introversione: questa è la via del soggetto reale (puruşa) e dell’oggetto reale (puruşa prakŗti). Una distinzione tipologica sarebbe solo giustificata tra questi due possibili percorsi, che sono in definitiva due modi graduali di raggiungere la conoscenza. Una psicologia che descriva cosí i tipi secondo una fenomenologia della mente, potrebbe essere di aiuto all’uomo moderno. Qui un ponte dovrebbe essere gettato tra la psicologia e la tradizione spirituale dell’Oriente.
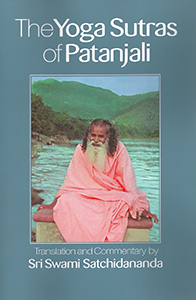
L’errore filosofico alla base della psicologia di Jung mostra come, nonostante le migliori intenzioni, qualsiasi ricerca che miri oltre il mondo dei sensi sia ostacolata da una mente vincolata a un supporto fisico (il cervello), vale a dire a quell’organo che è, allo stesso tempo, strumento del pensiero e mediatore delle percezioni sensoriali. Qui lo Yoga tradizionale offre una chiave che, a un attento esame, si rivelerà essere l’unica possibile soluzione dell’antitesi naturale tra la trasmissione delle percezioni sensoriali e una mente legata a una funzione di mediazione. Nello Yogasūtra (Yoga Sūtra II, 54), lungo il sentiero del samyama, incontriamo lo stadio del pratyāhāra, in cui matura la facoltà di disconnettere l’attività sensoriale dagli oggetti dei sensi. L’attività sensoriale è in effetti un’attività interiore che l’uomo della strada considera appartenente interamente al mondo dei sensi, ma che opera essenzialmente attraverso i sensi, e si lega illusoriamente ad essi e quindi all’apparenza esteriore delle cose, dato che i sensi appartengono al mondo esterno, o piuttosto sono il mondo esterno inserito nell’essere umano. I processi di dhāranā e dhyāna, attraverso cui la mente si distacca dallo stadio sensoriale, si perfezionano attraverso il pratyāhāra, dove la mente (citta) può trasmettere il contenuto interiore, o l’essenza noumenica delle cose. Dovrebbe essere ben considerato che in ogni senso la percezione contiene un elemento spirituale, che tende a raggiungere il sé, ma che solitamente viene superato, quando sorge la sensazione, dagli automatismi soggettivi che affiorano in essa e impediscono cosí che diventi, nell’individuo, la forma intuitiva di quel contenuto spirituale. Ecco perché al mondo si desta continuamente un’eco unilaterale, che è allo stesso tempo soggettiva e non spirituale.
La disciplina del pratyāhāra consente al discepolo di vagliare da ogni percezione sensoriale la sua controparte spirituale e di far rivivere in lui, fuori dal mondo morto e illusorio delle impressioni esterne, la sua interiore struttura spirituale. Ciò che esteriormente appare come tasselli e frammenti di un mondo diviso e multiplo, si muta interiormente nelle linee di un meraviglioso tempio interiore. Ma questo edificio che sembra sorgere dentro di noi – tanto che alcune scuole di pensiero occidentali lo chiamano “soggettivo”, perché si fermano al suo primo albeggiare nella coscienza – appartiene invece alle cose stesse ed è l’effettivo contenuto del mondo.
Le percezioni si danno per essere vissute al massimo della loro purezza: dovrebbero essere incontrate in uno stato di silenzio interiore e di “vuoto”. Ogni altra imagine di vita esteriore o interiore deve essere messa a tacere. Nell’essere umano ordinario tale stato è difficile da realizzare, dato che non è il “Sé Spirituale”, ma l’“ego” comune ad essere pronto a ricevere le percezioni, e i loro contenuti sono inseriti nella sfera della mente subconscia, o dei vāsanā, suscitando una tipica risposta in linea con famiglia, razza, abitudine e memoria, cosí che l’essenza della percezione venga perduta. L’errore del freudianesimo sta nel confondere per contenuti della coscienza rispecchianti l’individuo che percepisce, ciò che deve invece essere riconosciuto come estraneo all’individuo reale, e come ciò che cresce fino a diventare, in lui, il collegamento con le forze cosmiche ostili all’uomo, il Rākşasīmāyā (Sri Aurobindo, Lights on Yoga).
Lavorare su tali contenuti come se fossero i propri, equivale a lasciare che il nemico espanda la sua azione nella fortezza della propria coscienza. Finché l’uomo si affida a questa dubbia comunione con i poteri subterrestri, egli in quanto essere spirituale non vive, e parimenti non sa. In realtà non percepisce l’oggetto, ma solo il modo in cui la sua vāsanāvŗtti risponde alla percezione dell’oggetto. Egli resta colmo di avidyā fintanto che la sua conoscenza del mondo – e quindi la sua autocoscienza – è falsificata dall’ostinata ingerenza della “memoria”, ovvero della miriade di abitudini individuali che vogliono solo affermare se stesse e che sono invece estranee all’essenza del mondo.
Lo stato del pratyāhāra consente all’uomo di ricevere in se stesso, oltre alla percezione, l’essenziale elemento interiore (tattva) dell’oggetto percepito. In tal modo tutto diventa portatore di un messaggio eterno.
Tuttavia è ovvio che sia l’esclusione della vita dei sensi, sia il gettarsi a capofitto in essa, sono errate: o si è persi al mondo o si è persi nel mondo. In entrambi i casi l’uomo non raggiunge alcuna conoscenza del mondo e perde persino il senso della sua presenza in esso. La tecnica del pratyāhāra è di grande aiuto per realizzare la presenza di citta di fronte alla serie delle impressioni, ciò che è il principio di vidyā: il superamento del dualismo di spirito e materia, la sintesi tra i poli esteriori e interiori dell’essere ha la sua radice in questa facoltà di essere puramente presente alle percezioni dei sensi. Andando oltre in questo modo si può scoprire come il senso ultimo del vivere consista proprio nel liberare, attraverso l’azione interiore purificata, il mondo dei sensi che continuamente si confronta con noi, quello che di solito siamo indotti a isolare dal suo essere reale in una māyā, in scenografie, un cambiamento cieco (samsāra), un’esteriorità illusoria da cui emergono solo la nostra gioia o il nostro dolore.

Come si può tradurre la tecnica del pratyāhāra in termini di psicologia occidentale? Prima di tutto, come detto sopra, dovremmo cambiare il nostro atteggiamento verso le percezioni dei sensi. Se proviamo a cogliere ciò che accade in noi stessi quando concentriamo la nostra attenzione su due diverse percezioni, ad esempio quella di una pietra e quella di una pianta, sentiamo sorgere nella nostra anima reazioni di diversa qualità. Dovremmo fare attenzione a questa differenza. Tali echi provengono apparentemente dal nostro mondo interiore, ma non possiamo fare a meno di sentire allo stesso tempo che appartengono all’oggetto della nostra attenzione, cosí come alle percezioni che li hanno causati. Una progressione di differenze precise e facilmente riconoscibili dovrebbe essere istituita gradualmente, e dovrebbe corrispondere a quelle delle impressioni dei sensi, ed essere comunque diversa, essendo oggettiva.
Questa disciplina porta a liberare la propria coscienza dai cosiddetti complessi, in quanto segna un’azione indipendente da essi, sradicando gradualmente quell’errato atteggiamento verso il mondo esterno dovuto al loro continuo portarsi in avanti, schermando il vero sé ad ogni percezione. Mentre quella intrusione viene eliminata, l’Io spirituale (puruşa) entra lentamente in azione e stabilisce la sua connessione con il mondo. Dato che tale relazione riflette lo stato attuale delle cose, la loro nascosta pietà, questo restituisce all’anima la sua funzione di mediazione tra il tempo e l’eternità, tra il finito e l’infinito. Ovviamente questo non fornisce soltanto le basi di una psicologia spirituale, ma postula anche un mondo morale senza sollevare il problema morale.
Cosí è preparato il terreno per una vera esperienza del mondo dei sensi, per una contemplazione dell’apparenza esteriore delle cose che, oltre a non essere falsata a livello delle percezioni, porta in sé, insieme alle sensazioni, l’elemento interiore che appartiene alle cose e ancora in esse non appaiono. In tal modo anche un occidentale può acquisire la visione tradizionalmente orientale dell’uomo come creatura nella cui costituzione operano gli dèi.
La conoscenza di sé a questo livello non equivale ad avere una nozione intellettuale di se stessi, irrimediabilmente legata alle limitazioni del cervello, bensí a sondare a fondo le forze che guidano l’esistenza dell’uomo in tutte le sue sfere da distanze stellari, fluendo in ogni organo e dando ad ogni funzione naturale il suo senso individuale (M. Eliade, Cosmical Homology). Qui una fisiologia macrocosmica sottende il lavoro basale di ogni corpo umano. Cervello, cuore, metabolismo e sesso sono altrettanti supporti di stati di coscienza che vanno dal grado puramente umano – corrispondente al cervello come base della normale coscienza di veglia – a quelli sovrumani, al cui raggiungimento l’anima è solitamente impedita dal suo essere molto legata alla connessione cerebrale.

Bruce Rolff «Realizzazione spirituale»
A quei livelli nei quali lo yogin sperimenta forme sempre piú alte di coscienza e di realizzazioni, il comune essere umano attraversa gli stadi di sogno, di sonno senza sogni e infine qualcosa di simile alla trance, la controparte di turīyā. Quanto piú alti ci si eleva nel sādhanā, tanto piú in profondità si può penetrare, per vie sottili, nelle profondità organiche del proprio corpo, entrando cosí in contatto con le forze cosmiche attive nei vari organi. Sperimentare tali processi significa prendere parte a un aspetto dell’esistenza del mondo e approfondire il mistero dell’universo. Ci si rende conto che il flusso delle cose può trovare il suo compimento solo attraverso la conoscenza dell’uomo.
L’occidentale sarebbe tentato qui di forzare la sua discesa nel profondo, concentrandosi sugli organi fisici, immaginando di poter riuscire ad aprirsi la strada oltre il confine mantenendo la propria coscienza ancora collegata al sistema nervoso centrale. Una simile concentrazione sarebbe puramente intellettuale, rimarrebbe legata alle forze corporee e si fermerebbe al mondo delle sensazioni, ovvero al piano della māyā, e non sarebbe del tutto priva di pericoli per l’equilibrio fisiologico del soggetto.
La leggerezza con la quale gli occidentali entrati in contatto con le dottrine Yoga cercano di metterle in pratica, mostra quanto siano lontani dal rendersi conto che in esse è richiesto qualcosa di completamente diverso dalla coscienza quotidiana. L’occidentale, anche se conosce e comprende a fondo i testi yogici, non può arrivare da nessuna parte se non si costruisce una chiave per quelle esperienze con i mezzi a sua disposizione, vale a dire a partire dal suo normale stato di coscienza.
Allo stadio della coscienza razionalistica si perde normalmente la chiave della conoscenza metafisica, non essendo possibile nessun’altra esperienza interiore oltre a quella legata ai sensi. Questo si riferisce all’uomo moderno in generale, sia occidentale che orientale. Il livello di razionalità rappresenta l’ultimo gradino della discesa dell’uomo nell’oscurità della materia, ed è quindi il primo gradino della risalita. L’esperienza del pensiero – una conquista dell’Occidente – non deve essere eliminata, non deve essere trascesa (cosa potrebbe trascenderla se non un ulteriore atto di pensiero?) ma solo trasformata.

Novalis
Il pensiero può ben essere trasformato in forza-pensiero, secondo i versi scritti da Novalis nel suo “Idealismo Magico” e da Sri Aurohindo, la cui lirica “Thought, the Paraclete” (Pensiero, il Paracleto) porta un titolo carico di significato per un occidentale (Sri Aurobindo, Lettres). La condizione di coscienza razionale, contro la quale cosí tanti spiritualisti si sono sollevati focosamente in armi, mentre non possono combatterla o sottrarlesi senza ricorrere ad essa, non ha valore in sé, ma è in definitiva un’attività mentale che può essere penetrata profondamente e dominata dall’interno da chiunque abbia una forza spirituale creativa.
La metafisica orientale, in particolare indiana, può aiutare l’Occidente solo nella misura in cui parta da una giusta valutazione delle forze che deve esercitare. Quando si predica contro “l’intelletto” che razionalizza ogni cosa, gli occidentali in massima parte non sono neppure minimamente consapevoli del fatto che proprio l’intelletto stia fornendo loro i mezzi per la loro crociata.
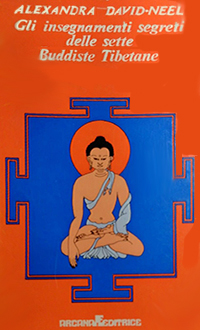
Torniamo adesso al nostro scopo iniziale, di scoprire se la ragione umana può essere fatta per sostenere una psicologia che porti realmente a sperimentare le leggi trascendenti della vita dell’anima. Il nostro compito sarà attuato se l’Io potrà essere messo in contatto con quelle piú profonde energie del pensiero, del sentimento e della volontà di fronte alle quali esso si trova solitamente in uno stato di “ignoranza” – lo stato di veglia della coscienza razionale – di sogno o di sonno profondo. La cognizione, mentre si scioglie dai suoi vincoli superiori (la testa), può volgersi verso strati piú profondi del proprio essere. La conoscenza essenziale che la Tradizione Orientale collega al cuore è la prima a sorgere. Ma andrebbe notato qui che essa ha poco in comune con il mondo delle emozioni e dei sentimenti con il quale un occidentale può associare superficialmente il cuore. È piuttosto una conoscenza non offuscata dallo schermo dei sensi e legata al cuore cosí come alla sua fonte di luce, come un raggio di sole è legato al sole; è la via interiore che gli asceti tibetani dicono che abbia la sua sede nel cuore: devayāna (A. David-Neel, Gli insegnamenti segreti delle sette Buddiste Tibetane).
In breve, le tre sfere di pensiero, sentimento e volontà devono essere gradualmente conquistate se la coscienza ordinaria deve essere trascesa attraverso successivi stadi di rilassamento mentale (niḩsaṅkalpa, saṅkalpa). Il pensiero, cosí liberato, getta un ponte nel subconscio e lo riempie di una nuova qualità interiore (vāsanānanda).
Sin dall’inizio l’Occidente dovrebbe quindi ricorrere a una distinzione propria della psicologia tradizionale, vale a dire la divisione della vita dell’anima nelle sue tre attività principali: pensare, sentire e volere. Tali facoltà sono solitamente mescolate in una sorta di groviglio nella vita di tutti i giorni. A uno stadio piú elevato dell’evoluzione, questi tre poteri possono essere sperimentati nella loro purezza come distinti l’uno dall’altro, qualcosa di completamente sconosciuto alla coscienza ordinaria. In effetti, essi non sono altro che tre veicoli della vita interiore, a ciascuno dei quali, secondo i risultati della ricerca spirituale, corrisponde una determinata “sede” corporea: il pensare al cervello, il sentire (passioni ed emozioni) al petto, dalla laringe al plesso solare, il volere (volizioni e istinti) alla metà inferiore del corpo e agli arti.
Occorre comprendere che ognuna di quelle “sedi” ha il suo particolare tipo di coscienza, e che l’uomo ordinario è cosciente soltanto di quello connesso con la testa. I processi che si svolgono altrove sono certamente sperimentati, come le emozioni e gli impulsi, ma indirettamente, attraverso la loro ripercussione nella testa. In altre parole, i nostri sentimenti e impulsi sono “pronti all’uso” e diventiamo coscienti di essi solo entro il nostro sistema nervoso centrale quando le loro onde, partendo dalla loro lontana sorgente, lambiscono le sue rive. Il pensiero lo percepiamo alla sua stessa fonte: possiamo anche dire che partecipiamo alla sua nascita e siamo strettamente collegati con la sua crescita.

Quest’ultimo punto è altamente favorevole a una concezione concreta della vita dell’anima e può indicare la via per un controllo efficiente dei propri sentimenti e impulsi. Possiamo agire su noi stessi solo basandoci su quell’attività della mente che percepiamo immediatamente e che, allo stesso tempo, ci guida attraverso ogni altra cosa, in quanto la nostra coscienza normale nasce con essa, vale a dire il pensiero.
Possiamo correggere un pensiero sbagliato per mezzo di un altro pensiero, mentre tutte le emozioni e gli impulsi che raggiungono la nostra coscienza sono fatti, cioè sono già stati spinti cosí profondamente nella nostra coscienza che qualsiasi pensiero con il quale potremmo opporci a loro non farà, almeno per il momento, cambiare il nostro stato d’animo.
Con questo abbiamo toccato il problema centrale dell’uomo: l’intera esistenza dell’individuo dipende dalle diverse relazioni della sua ragione con il suo mondo emotivo e istintivo. Possiamo anche dire che importanti svolte nella storia dell’umanità e nella vita degli individui sono state decise dal prevalere della ragione su certi stati d’animo e viceversa.
All’umanità odierna non occorrono ulteriori prove che se si pensa cosí a lungo alla dannosità di un’abitudine o alla pericolosità di un certo slittamento mentale, difficilmente si può dominare ciò che è già cresciuto in noi, consolidando uno stato d’animo ricorrente o un istinto, o cristallizzandosi in ciò che la psicologia moderna definisce “un complesso”.
Siamo quindi di fronte al problema di scoprire come la luce e l’equilibrio del puro intelletto possano essere applicati alle sfere meno coscienti dei sentimenti e alle profondità della volontà. La ragione non può opporsi direttamente a uno stato d’animo o a un istinto, ma può aprire la strada a un’azione di vasta portata basata sulla meditazione o su linee di pensiero di tale natura da essere afferrata dalle sfere del sentimento e della volontà. A quel punto lo Yoga tradizionale può essere tradotto in termini di psicologia occidentale.
C’è dunque una possibilità per l’uomo moderno, fuori dai sentieri battuti di qualsiasi determinata tradizione, di controllare saldamente le proprie facoltà e di allenarsi ad una forma piú alta ed equilibrata di vita interiore. Questo può senz’altro essere affermato, a condizione che non si facciano salti e che la fonte stessa della vita cosciente, il pensiero, venga preso come punto di partenza.
La pratica di un pensiero chiaro e preciso non si traduce nell’acquisizione di una certa agilità mentale, ma piuttosto, se si osservano alcune condizioni, nell’acquisizione, da parte dell’Io superiore, di una maggiore padronanza dei processi mentali. Un ulteriore passo può consistere nel portare questo nelle sedi di altre facoltà attraverso un approfondimento della meditazione (dhyāna). Dovrebbe essere ben compreso che non deve essere portato lí alcun messaggio con un contenuto definito, ma la stessa forza spirituale ampliata attraverso la concentrazione su tali contenuti, una forza che salga cosí in alto nel potenziale sovrasensibile quanto in profondità indagherà nelle facoltà corrispondenti. Queste appariranno immerse nel sonno della natura solo alla coscienza ordinaria. In realtà ognuna di esse vive ad uno stadio superiore di veglia (Māndūkya Upanishad, III, 31), estraneo alla coscienza ordinaria e quindi inaccessibile a qualsiasi psicologia profana.
Cosí l’individuo porta in sé l’“Uomo Cosmico”, come possibilità costantemente stroncata sul nascere al limite dell’esperienza sensibile e razionale.
Nel corso di una simile esperienza qualunque occidentale correrà il rischio di confonderla con una discesa nei regni della natura inferiore, la natura di rajas e tamas, mentre quella via in realtà lo porta in contatto con un regno della natura dove sono all’opera forze spirituali ancora piú alte, fino ai centri della fisiologia occulta dell’uomo, davanti ai quali l’uomo moderno, non avendone alcuna idea, è immerso egli stesso nell’oscurità di rajas e tamas. Ecco perché il pensare è solitamente riferito allo stato di veglia, e il sentire e il volere rispettivamente agli stati di sogno e sonno profondo. Per l’uomo ordinario le risorse piú profonde del suo essere sono avvolte da ombre che diventano sempre piú oscure (J. Evola, Lo Yoga della Potenza).
Il giusto approccio ad esse può essere effettuato prendendo le controparti, le capacità opposte a quei poteri, prefigurandole nel mondo come ancora accessibili alla coscienza di veglia, come punto di partenza. L’evocare imaginativamente e il contemplare quegli aspetti della vita naturale la cui sostanza è essenzialmente e sottilmente in sintonia con le sedi piú profonde del volere dell’uomo, da un lato si appellerà alla coscienza dei sensi e al pensiero della mente, ma dall’altro estrarrà da quelle immagini una qualità non riducibile ad esse e che conduce ad altri gradi di coscienza.

Cosí, ad esempio, la sintonia con la regione mediana dell’uomo, regolata ritmicamente dal flusso e riflusso del respiro, dalla circolazione del sangue, dal battito del cuore, è indotta da una quieta contemplazione di quei fenomeni naturali dove il ritmo trova una espressione potente ed evidente, come la successione del giorno e della notte, l’alternanza delle stagioni, la danza in tondo dei corpi celesti e il cambiamento cosmico.
Ma per gettare un ponte verso la cittadella piú intima e potente, quella del volere – dove scorre la vita istintiva e dove le energie piú creative, come la fermezza e il coraggio sono, per cosí dire, immagazzinate – occorre evocare e contemplare quietamente e intensamente quei processi naturali che derivano dalle energie creative e formative: riproduzione e crescita, vento, uragano e fulmine.
Questo contemplare, aprendo i recessi piú intimi della natura ad una reale esperienza, è in genere conclusivo per un maggiore equilibrio interiore e può, se trasformato in effettive meditazioni, fornire le basi per stabilire gradualmente un rapporto armonico tra la sfera del pensiero cosciente e quelle del sentire e del volere. Una retta pratica della disciplina può poi condurre, con il tempo, alla realizzazione dello scopo umano, altamente auspicabile, di trovare in se stessi la forza per attuarlo e risolverlo, una volta che viene considerato giusto e determinato, grazie alla crescente concordia tra la volontà e il retto pensiero.
Il contemplare e l’evocare imaginativo di certi processi naturali, se attuati correttamente, consentono all’essere umano di superare la scissione interiore a causa della quale alcune forze della coscienza sembrano essere tagliate fuori dai suoi strati piú profondi, dallo schermo cerebrale. Come isolatore, il cervello registra accuratamente la vita dei sensi e ha quindi una funzione positiva, su cui poggia la scienza moderna nel suo aspetto piú positivo. Ma la sua relazione unilaterale con la realtà attraverso la percezione dei sensi esclude la coscienza dai tesori interiori della vita dell’anima.
Il nocciolo dei problemi essenziali dell’uomo moderno sta proprio in quella scissione. Nello schema che ho tracciato sopra, ho cercato di evidenziare come alcuni insegnamenti della metafisica indiana possano condurci a una fruttuosa comunione con il nucleo stesso del nostro essere, senza perdere quella chiarezza di coscienza che è la funzione piú positiva del cervello.
Oggi l’equilibrio è qualcosa che l’uomo deve conquistare da sé per mezzo della propria buona volontà. Ma le forze di cui può disporre a tal fine sono presenti nel mondo e in se stesso. Dovrebbe usarli fidando sullo Yoga, affinché gli mostri come la vista della natura e del cosmo che si dispiega davanti ai suoi occhi è sempre a sua disposizione per lasciare che le energie curative e moralmente creative agiscano dentro di lui.
Massimo Scaligero
Tradotto da: East and West, Gennaio 1956, Vol. 6, No. 4.
Link all’articolo originale inglese: “Sketch of a psychology founded on Yoga”

