
Il ricordo dell’Ottuplice Sentiero è connesso nella nostra mente a un insieme di regole morali molto semplici che hanno, nella nostra epoca, un sapore alquanto fuori dal mondo, pur rappresentando, in effetto, i contenuti fondamentali del Buddismo. Potremmo pensare che, se confrontato con l’esperienza aristocratica delle Upanishad e le vette metafisiche raggiunte dai loro autori ascetici, l’Ottuplice Sentiero, insieme alle Quattro Nobili Verità e alla dodecupla catena del Pratityasamutpada, non è che una realistica versione di verità sovrasensibili, cosí lontane da quelle altezze da dimenticare il nucleo essenziale dell’uomo, l’Ātman-Puruşa.
Dovrebbe tuttavia esserci consentito presumere, che alcuni cambiamenti verificatisi nella visione spirituale dell’umanità con il succedersi di ogni età evolutiva alla precedente, debbano avere qualcosa a che fare con alterazioni interiori dell’uomo stesso. Le riforme religiose e le lotte filosofiche dovrebbero forse essere ricondotte al mutevole modello dell’esperienza spirituale umana, all’emergere di una nuova relazione organica con la sfera sovrasensibile. Questo potrebbe spiegare perché i pensatori tradizionali operanti all’interno di un dato sistema, si trovino a volte fianco a fianco con i rappresentanti di nuove prospettive e i precursori di futuri punti di vista. Per mancanza di coscienza della novità di alcune esperienze, queste ultime sono ancora collegate alle antiche espressioni; questo porta a incomprensioni e conflitti. Le grandi polemiche tra i Realisti e i Nominalisti nella corrente ascetica aristotelica nel Medioevo non potevano essere spiegate altrimenti: i due gruppi avevano una differente esperienza degli Universali e chiamavano con lo stesso nome l’oggetto della loro contrastante percezione interiore.
La divergenza tra la Nyāya-Vaiśe-şika e le dottrine buddiste potrebbe essere spiegata allo stesso modo.
Chiunque guardi in modo imparziale alla vita umana nel corso dei secoli, alla storia dello spirito umano, dovrebbe essere in grado di notare i cambiamenti che questo implica, se ve ne sono. L’umanità è forse rimasta la stessa? Come è quindi possibile che essa afferri e riconosca se stessa anche in condizioni che sono affondate e sepolte nella coscienza? Il mondo antico non è sicuramente la proiezione dell’intelletto attuale che cerca di costruire qualcosa di diverso da se stesso, qualcosa che non ha mai vissuto. Esso si rivela invece nella forza del proprio essere come una realtà oggettiva con la quale il moderno intelletto moderno deve sforzarsi di arrivare a una comprensione.
Riguardo all’Ottuplice Sentiero dovremo vedere se si tratta di una formula meramente morale, che pone la questione nella serie delle “beatitudini” che non possono essere postulate ma devono essere prima raggiunte, o piuttosto la formulazione morale di una esperienza metafisica che già contiene in sé, in uno stato di assoluta purezza, la suprema saggezza delle Upanishad, pronta a tradursi in uno stile di vita, uno stile umano, e di sondare ulteriormente le profondità. Una interpretazione strettamente morale potrebbe quindi essere il risultato di una comprensione solo del suono esteriore delle parole e non dei contenuti a cui esse semplicemente alludono.
Osserviamo piú da vicino «la retta visione, il retto pensiero, la retta parola, la retta azione, il retto stile di vita, il retto impegno, la retta esperienza, la retta meditazione», cioè la formulazione dell’Ottuplice Sentiero. Gli otto punti sono ovviamente attitudini ed esercizi che non possono essere separati l’uno dall’altro. Il segreto del loro vero significato sta nella loro struttura, nel loro accordo, nei sottili collegamenti tra loro.
La virtú, ogni atteggiamento interiore, è per l’uomo moderno prima di tutto qualcosa di astratto, quasi una parola d’ordine. L’esperienza razionalista è ciò che consente all’uomo di costruire la scienza e una visione scientifica del mondo. Ma il metro di giudizio della mera conoscenza non può in alcun modo essere applicato alla visione dell’uomo antico. Studiosi come Eliade, Kerenyi, Dumézil hanno fornito un quadro completo della differenza tra l’esperienza antica e moderna della natura e del mondo. Gli stessi organi di conoscenza erano differenti. L’uomo antico, un essere pre-razionalistico, pre-filosofico, non sperimentava il pensiero astrattamente, poiché la corrente vivificante della volontà fluiva direttamente nel suo pensiero. Una virtú non può essere astrattamente pensata – poiché l’uomo moderno può al contrario essere razionalmente persuaso di ottime ragioni per condannare un modo di vivere da cui non è in effetti abbastanza forte da lottare per liberarsene – ma una volta ammessa nell’anima come pensiero, quella virtú mostrerebbe fin dall’inizio la sua forza trasformatrice dell’anima.

L’importanza attribuita a dhārana e dhyāna, ovvero concentrazione e meditazione, può essere percepita nei testi tradizionali come esperienza attraverso la quale l’uomo realizzava il suo essere: nel pensiero viveva, per cosí dire, in un organismo sottile non limitato alla testa, ma che pervadeva l’insieme del suo corpo e anima. Lo yoga, la dottrina dei çakra, la nozione delle nādī e il lato pratico dello shaktismo sono intesi nell’induismo per «incarnare lo spirito e per spiritualizzare il corpo», e possono giustamente essere messi in relazione con l’idea dell’antica identità di essere e pensare. Il mistico realizzava se stesso con il pensiero e sentiva che egli non era quando era solo cosciente del proprio corpo; si sentiva svanire e quasi dissolvere nei processi sensoriali, mentre sentiva il suo essere pienamente realizzato mentre era impegnato nel pensiero meditativo. Per lui essere era pensare e pensare essere. Al di fuori dell’attività interiore causata dal pensiero egli non era. In essa percepiva il proprio essere, la sua stessa vita. L’uomo realmente viveva nella meditazione. In altre parole, le astrazioni erano sconosciute all’antico asceta, dato che il pensiero era volontà e allo stesso tempo jñāna era autorealizzazione.
Solo dopo la nascita del pensiero riflesso, dialettico e filosofico, l’essere e il pensare si sono suddivisi in due distinte funzioni. La vita e le idee si sono frazionate, sono andate alla deriva in posizioni contrastanti ed è sorto il problema della loro relazione, che è ormai un argomento filosofico secolare fino ai suoi ultimi stadi. L’esistenzialismo propone di nuovo il problema con l’intenzione non di risolverlo, ma di riaccendere la maligna fiamma della dualità attraverso una dialettica acutizzata ed esasperata.

La disputa a lungo portata avanti sembrava trovare la sua soluzione a un certo punto dello sviluppo del pensiero occidentale, quando Descartes disse il suo cogito ergo sum. Questo ha portato a ulteriori rivalutazioni ma non ha cambiato niente, poiché il “cogitare” e l’“esse” di Descartes erano di per sé una espressione della rottura tra lo “speculare” e il “vivere” che intendeva superare. Se uno dei discepoli del Buddha avesse potuto parlare con Cartesio, avrebbe detto: «Non puoi essere nel tuo pensiero perché il tuo pensiero non è, dato che è un semplice riflesso. Perciò, quando pensi, tu non sei, proprio come l’imagine riflessa da uno specchio non è, anche se appartiene a un oggetto reale». Cogito qui significa «non entia coagito, ergo non sum» (Michaelstaedter).
È una questione viva, scottante, che è alla radice dei problemi piú angoscianti di oggi, mentre ancora cerchiamo di essere fuori dal pensiero e di pensare tagliati fuori dalla vita, cosí inevitabilmente cadendo o in un realismo materialistico o in un realismo metafisico, entrambi riaffermanti dualità, astrattezza e limitazione.
L’idealismo e i suoi sviluppi fino a Giovanni Gentile sembravano aver bandito l’“essere” come soggetto di ogni argomento razionalistico. Potrebbe essere al massimo essere un soggetto di meditazione o il fulcro di un nuovo tipo di azione sulla forza di alcune intuizioni fondamentali già acquisite. Ma l’esistenzialismo lo ha riproposto come problema centrale della sua tendenza, e Martin Heidegger ha potuto scovarlo e riportarlo alla ribalta come se nessuno lo avesse prospettato e risolto dialetticamente prima. La ragione per cui questo problema viene proposto sempre di nuovo, e non si trova alcun indizio alla sua soluzione, deve essere ricercato nello stato attuale del pensare umano, un pensare disanimato, privo della dimensione di profondità, anche se può dissertare brillantemente sulla profondità.

Hegel ha senza dubbio toccato l’argomento, anche se non lo ha portato alle sue ultime conseguenze. Il suo compito poteva essere solo quello di indicarlo. «L’essere – dice nella sua Wissenschaft der Logik – è una pura intuizione, e tale è anche il nulla in quanto semplicemente identico all’essere». Ovviamente per pura intuizione si intende qui un pensiero che si esaurisce nel suo oggetto ideale. Ma è precisamente per questo che non si esaurisce e riemerge di là dalla contraddizione, e nel suo riemergere, benché in un breve lampo se misurato nel tempo naturale, è uno con l’eternità. Questo ulteriore stadio in cui l’essere è il pensiero che percepisce, l’essere non può essere considerato implicito nella dialettica di Hegel, né nell’autocoscienza di Fichte, e neppure nella identità di Schelling. Tuttavia, l’intera filosofia dell’idealismo è una elevata tensione verso una sintesi di essere e pensare, ma solo una tensione, senza il costante perseguimento di tale obiettivo fino al suo adempimento.
Tale realizzazione non può essere ovviamente il frutto di ulteriori speculazioni. Il solco della ragione e dell’argomentazione sfuma nell’indefinitezza della razionalità, mentre tutto annuncia che lo spirito o diventerà una esperienza o svanirà nel regno dei fantasmi. L’idealismo, o l’intera filosofia – che è dire la stessa cosa, dato che non esiste filosofia che non sia idealismo nella sua essenza – dovrebbe essere in grado di concordare sul presupposto che il pensare non è una funzione meramente soggettiva, in quanto prima del suo essere assunta dal soggetto, l’uomo, è una forza universale, cosmica, superindividuale, una realtà spirituale, l’essere; un essere in cui l’uomo può essere, senza il quale l’uomo non può essere; e in effetti egli non è, perché il pensare è pensare riflesso, perché cerca sempre fondamenti esteriori, miti, esseri o rivelazioni, senza rendersi conto che questi, in quanto sono l’oggetto del suo pensiero, sono i pensieri stessi. Quando penso, non sono fuori della realtà delle cose, dato che i pensieri appartengono alle cose, anche se sorgono dentro di me: l’anima delle cose trova la sua espressione in me attraverso il mio pensiero, non certo attraverso il pensiero riflesso, ma attraverso il retto pensiero, che può essere identificato con quello che Sri Aurobindo chiama il «Pensiero Paraclito». Affinché l’anima delle cose possa rivelarsi in me come pensiero, non devo sottrarmi a quel pensiero, ma indugiare in esso. Devo fermare il flusso stesso del pensiero, assumerlo dentro di me come una forza, vivere con esso. Questo è ciò che significano concentrazione e meditazione. Se si salta da un pensiero all’altro, in un volo permanente, in una stabile incapacità di controllare e contemplare, cosí che solo la superficie delle idee ne lambisca fugacemente uno con l’astrazione o l’ombra dello spirito, si attua un volubile, riflesso, sconclusionato, infruttuoso, irreale pensare, al quale devo necessariamente opporre un essere, un “Dasein”, una esistenza, una materia, una realtà che non potrà mai placare la mia sete, perché non possiedo il tipo di pensiero che gli appartiene, e quindi sono tagliato fuori dalle cose, dall’esistenza e dalla vita.
Ovviamente, se quel tipo di pensiero impotente, che affronta solitamente una vita irreale, si volge ora a considerare l’Ottuplice Sentiero, non può vedervi che una serie di dogmi apprezzabili solo da quel punto di vista morale che oggi lascia per lo piú freddi. Pensare non è essere, l’essere non è il pensiero. Quindi pensare ad esempio la retta azione, può solo lasciare il posto ad astrazioni sul modo corretto di fare le cose. Ma se ammettessimo che un discepolo del Buddha potesse porsi in quella condizione in cui il pensiero era una forza viva, diverrebbe allora comprensibile come per lui il meditare sulla retta azione significherebbe cogliere al tempo stesso il principio dinamico necessario per compiere quel tipo di azione.
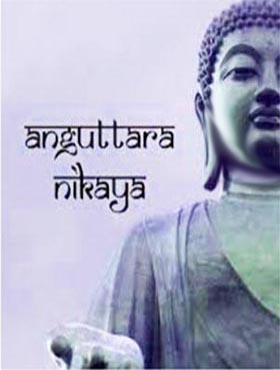
I discorsi del Buddha
Chiunque studi testi tradizionali come l’Anguttara, il Majjhimanikayo e l’Abhidharmakośa troverà ovvia questa identità di essere e pensiero. Attraverso essa l’asceta poteva sentire il flusso della vita nel suo pensiero e con ogni pensiero assorbiva un elemento di forza di volontà. Vasubandhu per esempio, afferma che l’atto del pensare (vitarka) è l’espressione dell’organo del pensiero. Inoltre traccia una distinzione tra pensiero sottile e ordinario. Il primo è una specie di pensiero spirituale. Tale distinzione è necessaria ancora oggi per evidenziare quanto distanti possano essere i contenuti vissuti in una regola ascetica secondo gli standard di coloro che si conformano ad essi.
Se possiamo presumere la validità di tale osservazione riguardo a qualsiasi dottrina spirituale, questo può indurci a tenere nettamente separato il valore di un principio morale basato sulla sua realizzazione e pratica concreta, da qualsiasi altro prodotto della capacità di astrazione dell’umanità. Quanto all’Ottuplice Sentiero, la sua semplicità non deve ingannarci. Se è stato posto da qualcuno che l’ha realizzato in se stesso, dovrebbe essere misurato secondo il tipo di valutazione sopra specificato, vale a dire come espressione di un mondo spirituale piuttosto che della logica umana. Lo sfondo interiore delle otto attitudini dovrebbe essere interiormente sperimentato attraverso la meditazione, in modo che ne possa scaturire il senso del loro accordo. Quell’accordo, quando è raggiunto dall’intuizione, quando è colto e richiamato spesso alla mente nel suo lampo di luce, può improvvisamente inondare l’anima del ricercatore come un potere di determinazione interiore, proprio il tipo di determinazione necessaria per seguire regolarmente ciascuno degli otto sentieri.
L’Ottuplice Sentiero non scaturisce dalla moralità, ma le forze morali da essa. Grazie al Sentiero l’uomo non è vincolato a una regola, ma deve creare lui stesso la regola in ogni caso. È quindi solo un metodo verso il conseguimento della Sapienza. A questo proposito vanno tenute presenti le parole di Aśvaghoşa: «La saggezza ha la facoltà di penetrare i dharma cosí come essi sono, e la funzione di dissipare l’oscurità della illusione che avvolge i dharma e nasconde la loro vera essenza».
Chiaramente questo riconoscimento dei dharma porta all’acquisizione della legge del karma, come gli Yogacārin piú tardi indicheranno nel trattare l’ālayavijiñāna. D’altra parte le antiche dottrine buddiste menzionano i “tre segreti” del pensiero, della parola e dell’azione e li concepiscono come legati all’ordito e alla trama invisibili del karma. Ogni “azione” del karma è considerata un “atto” spirituale. Nelle “azioni” il karma si manifesta e tuttavia si nasconde. Un essere umano impigliato nella māyā confonde le “azioni” con la pura verità e perde la possibilità di osservarle nella loro vera essenza, guardandole dall’alto di un “atto” interiore. Ma grazie al suo “occhio interiore” dischiuso l’Iniziato può vederle come le lettere di un alfabeto sovrasensibile attraverso il quale il karma trova la sua espressione, rivelando il segreto delle sue precedenti incarnazioni e del suo percorso futuro. La via che porta alla liberazione può essere vista solo da occhi purificati, ὅσον τ´ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι (Parmenide, 1).

Samsara – La ruota della vita
Sembra quindi come se solo una serie di “atti” interiori possa ridimensionare la catena di “azioni” di cui è intessuta l’esistenza samsarica, essendo quest’ultima la catena infinita che incessantemente confronta ogni individuo con le stesse fatiche e gli stessi problemi, con situazioni sempre ricorrenti di sofferenza e di impotenza. L’uomo ha bisogno della pratica paziente e persistente degli atti interiori attraverso i quali può liberarsi dall’avijjā, dalla memoria samsarica, da tutto ciò che lo lega alla sua struttura corporea apparente (skandha, vāsana, samskāra), e ravvivare in sé la sua memoria spirituale (ἀνάμνησις di Platone), cioè il ricordo della sua natura spirituale che porta alla liberazione. Questo è il senso dell’Ottuplice Sentiero: abitudini mentali, complessi, routine costituiscono una “memoria” che lega l’essere umano ad una natura inferiore che non è il suo destino, ma con la quale si identifica ciecamente. La persistenza per mesi, per anni in una serie di atti mentali voluti indipendentemente dalla propria natura, può spezzare la catena delle abitudini e permettere al discepolo di sradicare la falsa memoria, rivivificando al suo posto la vera memoria dell’uomo, quella corrispondente alla sua origine divina. Cosí l’Ottuplice Sentiero comporta la creazione di nuove abitudini che portano al risveglio dello “stato primordiale” dell’uomo.
Il termine “memoria” non è stato scelto a caso. Da un lato riflette l’dea di un insieme di abitudini inconsce, che tendono a ripetersi ciecamente – i vāsana, i samskāra della tradizione buddista – e dall’altro lato è spesso usato dalla moderna psicologia nello stesso senso riguardo all’azione dei “riflessi condizionati” e la vita dell’“inconscio”. Delay la chiama “memoria inferiore”, che è l’equivalente di affermare la mancanza di una “memoria superiore” che caratterizza il vero essere umano.
L’uomo moderno può trovarvi un modo per comprendere e, nel caso, praticare l’Ottuplice Sentiero per ciò che contiene di verità vivente ancora oggi. Esso porta a un risveglio della memoria spirituale, che è già sveglia nell’area superindividuale di ogni essere e dorme nell’inconscio, sopraffatta da una falsa memoria che governa ogni “associazione” e persino il pensiero da un luogo piú profondo. Quella dimensione interiore che manca alla psicologia moderna, l’uomo potrebbe ritrovarla nell’Ottuplice Sentiero, nella stessa misura in cui potrebbe ravvivare nel proprio pensiero la reciproca relazione delle otto attitudini tra loro, fino a farlo scaturire improvvisamente nella sua anima come potenza su cui poteva attingere per praticarle una per una.

Per ottenere ciò l’occidentale dovrebbe, come ho già detto, meditare sulle singole attitudini in modo da averle a portata di mano nella sua coscienza, finché potrebbero, a un certo momento, muoversi e combinarsi da sole nella sua anima, rivelandogli cosí la loro mutua relazione interiore, la loro natura univoca di raggi che irradiano da un centro. Ovviamente un tale esercizio ha lo scopo di colmare la separazione tra “essere” e “pensare” alla quale ho accennato sopra, e che non era un problema per i discepoli del passato. Il nostro pensiero disanimato dovrebbe attingere a una nuova sorgente di vita attraverso la meditazione. Cosí il flusso della volontà fluisce nel pensiero e lo eleva al di sopra delle solite elucubrazioni cerebrali. Si creano cosí le condizioni per le giuste attitudini.
Se l’uomo moderno, ad esempio, volesse seguire la via del “retto giudizio” e cercare di rettificare ogni suo giudizio passando a quel pensiero cosciente al quale ho accennato, noterebbe che il giudizio può essere all’altezza della verità del suo oggetto solo quando può affermare l’elemento eterno che l’oggetto contiene. Tale giudizio non potrebbe piú condannare niente, in quanto inevitabilmente sposerebbe l’essenza della bontà e della bellezza presente in ogni modo in qualsiasi cosa oltre la sua apparenza.

La via del giusto giudizio implica quindi un atteggiamento di positività verso gli esseri e tutti gli oggetti. Tale atteggiamento va favorito attraverso una costante percezione del lato buono e positivo dei fatti, delle cose e delle persone, in particolare quando è difficile trovarlo. Non voglio dire che si debba trascurare il lato oscuro occasionale di una cosa, ma che la critica “spontanea” vada attutita e l’attenzione rivolta deliberatamente verso gli aspetti positivi. Questo rafforzerà la facoltà di guardare al lato favorevole, costruttivo, che non può mancare di esistere e deve essere creato dalla nostra immaginazione, ma notato e colto nella sua concretezza, oltre il lato negativo delle cose che di solito colpisce per primo.
Quello sarà l’inizio del comportamento secondo lo spirito, attraverso il quale non ci si avvicina a nulla in modo sprezzante, poiché l’apparente multilateralità può essere ricondotta a un tutto armonioso. Trovare da ridire per l’aspetto negativo delle cose è tipico del punto di vista umano e deriva dal nostro abituale atteggiamento verso l’esperienza. È un modo inconsciamente ed egoisticamente impegnativo con l’influenza di idee preconcette derivanti da esperienze passate. Chi saprà liberarsi da quelle idee sarà capace di formarsi un giudizio autonomo, cioè giusto: non giudicherà secondo il nostro consueto pregiudizio che ci impedisce un contatto immediato con la realtà.
Gli stimoli del nostro temperamento, la nostra educazione, le relazioni umane stabilite nella nostra giovinezza e la visione delle cose che abbiamo formato a quel tempo, ci portano purtroppo a considerare le cose e le persone secondo schemi prestabiliti e ci predispongono a giudizi che dovrebbero essere sempre rivisti alla luce di una ragione sempre rinnovata. Sono cosí radicati che si aspettano da noi solo una sorta di reazioni prefissate, il cui automatismo ha acquisito la forza dell’impersonalità. Attraverso la pratica del retto pensare ci liberiamo gradualmente da esse e guardiamo le cose in un modo nuovo, all’altezza della loro intima realtà.

Qui si può dischiudere “l’occhio spirituale” e ottenere la visione diretta, attraverso la quale il segreto del karma degli esseri che vediamo comincia a profilarsi. Questo è inevitabile, poiché l’abitudine al giudizio distaccato e al fondersi nella realtà interiore delle cose oltre la loro apparenza, ci permette di cogliere la sottile relazione tra la loro essenza e l’esistenza. Il giudizio positivo illumina tutto ciò che un essere umano alimenta di bene e ci porta a veder operare il dharma negli “strati inferiori”, samskṛta, cioè le forze che impediscono a quell’elemento positivo di prendere il sopravvento. Ci porta a vedere gli ostacoli che impediscono all’uomo di muoversi lungo la sua direzione creativa, secondo il dharma superiore (asamskṛta, nirvanico). Progrediamo quindi verso la comprensione degli altri e giungiamo a una pratica della verità piú profonda ed edificante, a una pratica concreta dell’amore verso il prossimo (maitrī).

Il Sentiero della “retta visione” è simile. Esso causa una disciplina delle nostre concezioni, affinché queste riproducano fedelmente la realtà degli esseri e delle cose. Ciò implica soprattutto non accettare nulla come in precedenza giudicato e stabilito, e rivedere tutte le nostre concezioni e prospettive mediante un venire in contatto con gli oggetti in modo nuovo. Se qualcuno, ad esempio, sente un giudizio che ha già udito altrove, dovrebbe considerarlo come se lo stesse ascoltando in quel momento per la prima volta, chiedendosi se questa volta non riveli qualcosa di nuovo o se appaia sotto una nuova luce. Questa pratica rivelerà anche se qualcosa di nuovo è nato in noi stessi, se possiamo comprendere meglio e piú profondamente che in passato. Possiamo cosí valutare attivamente e consapevolmente la strada che abbiamo percorso verso la comprensione del mondo.
Seguire questo Sentiero significa giungere ad una “purificazione” della memoria, poiché conserveremo ciò che è vero e vivo ed elimineremo quella memoria ingannevole che è la stratificazione nella coscienza delle nostre reazioni soggettive. Se opponiamo una nozione già acquisita a qualcosa che ci sta di fronte in un dato momento, non facciamo che riferirci automaticamente ad essa, a un dato contenuto della nostra memoria, perdendo cosí la nuova esperienza. Se, quando ci viene detto qualcosa di nuovo, attingiamo al deposito di idee che abbiamo raccolto riguardo a eventi simili in passato, ci tagliamo fuori da qualsiasi giudizio realmente attivo; se dovessimo decidere di esaminare il fatto di nuovo, il presente giudizio piú oggettivo mostrerà la percezione contraria. Questo è il modo per controllare “l’area” dalla quale solitamente sgorgano i contenuti della memoria per confermare i nostri giudizi sugli schemi. Ripulire quest’area, dove il passato s’impone sempre sul presente, significa in qualche modo liberarsi dal determinismo del tempo: “il tempo diventa spazio”, cioè vediamo il tempo, per cosí dire, inserito nello spazio e alla nostra portata nel presente. Il ricordo cessa di essere un’eco morta del passato e perde tutte le falsità che potrebbero averlo incrostato in passato. Questo è di vitale importanza, poiché possiamo rimuovere dalla nostra coscienza un veleno pericoloso, la catena di falsità che conserviamo come ricordi. Ma la memoria spirituale, libera da ricordi ingannevoli, è la forza stessa attraverso la quale l’anima può realizzare il tempo come spazio in sé e muoversi in esso come in un presente continuo secondo la sua volontà.
Le altre sei attitudini sono illuminate da retto giudizio e retta visione. Grazie ad esse, gli ideali di vita vengono riconosciuti per quello che sono realmente, poiché non possono piú coincidere con ciò che è transitorio o non affonda le sue radici nell’eternità, e l’impegno umano trova finalmente il suo scopo. La retta aspirazione diventa una forza che libera l’uomo da tutti i miraggi ingannevoli e dai miti inferiori sui quali tante energie umane vengono perdute.
Da questo nasce l’impulso di non agire piú secondo la propensione personale, ma solo tenendo conto delle esigenze interiori degli esseri e delle cose, il che significa “volere” allo stato puro, cioè non voler agire sullo stimolo dei propri vantaggi o preferenze, ma unicamente per il bene dell’oggetto. L’oggetto a sua volta, come ho detto sopra, può ora essere compreso nella sua realtà grazie al retto giudizio e alla retta visione. La volontà, se scevra dalle motivazioni egoistico-sentimentali che sono i suoi abituali stimoli, diviene forte in sé e si unisce alla sorgente impersonale del suo potere. La volontà umana, si può dire, quasi coincide qui con la volontà degli Dei.
La retta volontà si realizza nella retta azione, in una corrispondenza ora rigorosamente ricorrente tra “potere” e “atto”, per cosí dire. Diventa allo stesso tempo chiaro che è necessario un modo interiore di agire, che è in definitiva la retta meditazione, rivestita di retta azione nel mondo visibile. L’azione è in effetti di un solo tipo: l’atto dello spirito che a volte riveste la contemplazione – o la retta meditazione – e a volte l’azione. La sintesi di tutto è il giusto modo di vivere, che risulta come un ininterrotto accordo tra la retta meditazione – nella quale confluiscono il retto pensiero, la retta visione, la retta volontà – e la retta azione. Ma la catena di questi sette moti dell’anima può indagare nelle profondità dell’essere solo con il giusto sforzo, ovvero attraverso una paziente resistenza portata avanti durante mesi e anni con impeto inalterabile e devozione incrollabile, finché non operi, alla fine, come la stessa natura.

Appare ora evidente che l’Ottuplice Sentiero non funziona come un imperativo morale o sociale, ma è intessuto di una sequela di atti interiori sempre veicolati attraverso un particolare modo di pensare, che è il retto pensiero o il pensiero puro. La fonte dell’intuizione è chiamata incessantemente a sgorgare nell’anima in modo da realizzare le tante attitudini che devono esservi poste indipendentemente dai vecchi vāsana, ma anche oltre la conoscenza o la saggezza acquisite. La chiave dell’intero processo è per l’uomo moderno la riconquista del pensare come uguale all’essere. Al di fuori di un “pensiero vivente” gli otto Sentieri non possono che rimanere direzioni etiche astratte, le forme esteriori di saggezza intese ad avvolgere l’egoismo umano nelle vesti di una qualche dignità. La moralità qui in realtà non è il presupposto, ma un effetto collaterale, che non si pone neppure come scopo e quindi non è neppure voluto, poiché l’Ottuplice Sentiero e il pensiero adamantino, non piú vincolato ad alcun sostegno fisico, diventano la via verso la realizzazione di quello che la moderna la filosofia designa intuitivamente come “il fondamento”: che non ha altro sostegno che se stesso. In tal senso, il suo raggiungimento, come afferma il Buddha riguardo alla verità nel Samyuttanikaya, è oltre “ciò che è” e “ciò che non è”, oltre la dualità, cioè di là da quello “stato umano” mediante il quale, secondo Eraclito, ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνῃ φάος ἄπτει ἑαυτῷ.
Alcuni secoli dopo Nāgārjuna parlò di Madhyamika come di un percorso teso anch’esso tra l’essere e il non essere, che dipinge con precisione intuitiva l’“area spirituale” dell’esperienza interiore che può realmente liberare l’uomo dai vāsana, dall’antica natura, dal saṃsāra cosí come da ogni forma di conoscenza o anche di saggezza legata ad essi. L’Ottuplice Sentiero può essere tradotto per l’uomo moderno in una psicologia aristocratica – o in un tipo di psicologia – cioè in una vera scienza dell’anima. Ciascuno degli otto Sentieri porta all’eliminazione di un aspetto della “memoria”, vale a dire di quello che, come “passato”, è presente nell’uomo ed esige imperiosamente da lui certe abitudini e uno sguardo particolare sul mondo. Quando è libero dalla falsa “memoria”, l’uomo può guardare indietro alla sua vita e ripercorrere la catena del suo ricordo in maniera obiettiva. Egli può cosí risalire all’inizio della sua attuale vita terrena, dove si confronterà non con il nulla, ma a un vero Essere che vive in lui da prima della nascita. Può raggiungere lucidamente la soglia di un’esperienza dell’Io superiore, un Essere che si confronterà realmente con lui come indipendente da nascita e morte. Proprio quella esperienza può dare un senso alla sua vita e rivelargli che l’Ottuplice Sentiero non è stato ancora conosciuto dall’uomo, poiché deve ancora essere percorso.
Massimo Scaligero
Tradotto da: East and West, Gennaio 1957, Vol. 7, No. 4.
Link all’articolo originale inglese: “What the Eightfold Path may steill mean to mankind”

