In una chiara mattina di marzo dell’anno 1838, un uomo sulla trentina, leggermente stempiato, senza ancora la fluente barba da sapiente che l’avrebbe caratterizzato nella sua età piú avanzata, entrò nella gabbia di Jenny, una femmina di orangutan del Borneo, diventata l’attrazione principale dello zoo di Londra. Jenny era molto intelligente per essere una plantigrada: rispondeva con cenni di assenso alle domande dei visitatori, mostrava meraviglia se le venivano offerti giocattoli e dolciumi attraverso le sbarre. Sorrideva emettendo suoni di gradimento. Arrivava a specchiarsi e ad acconciarsi quasi come una persona umana. Ma lo era, in effetti, pensava l’uomo che aveva osato varcare le sbarre della gabbia e scambiare con la scimmia gesti di amicizia, sorrisi e suoni gutturali che, secondo la modulazione e l’accento, volevano mettere Jenny a proprio agio.

Ritratto di Charles Darwin da giovane e da anziano
Chi era quell’uomo, e chi lo aveva autorizzato a disturbare l’animale sapiente, con il rischio di irritarlo e riceverne qualche danno fisico? Nipote di un illustre naturalista, figlio di un medico noto per le sue ricerche e i suoi metodi innovativi di cura, Charles Darwin aveva onorato le sue ascendenze familiari navigando per cinque anni, a bordo del Beagle, un brigantino della Royal Navy, lungo le coste dell’America del Sud fino alla Terra del Fuoco, e risalendo quelle del Pacifico fino alla California e alle Galapagos, studiando con occhio scevro da ogni fisima creazionista le specie animali che un ambiente naturale ancora intonso mostrava in tutta la sua stupenda e insieme drammatica visione primigenia di morte e vita alternate freneticamente, spietatamente. Una lezione che nessuno dei testi di scienza del tempo poteva dare.
Entrando nella gabbia di Jenny, il giovane Charlie intendeva ricevere la conferma di un’intuizione avuta contattando una tribú della Terra del Fuoco, all’estremità del continente americano. I fuegini, questo il nome locale degli abitanti, avevano conservato, negli anni, gli stessi tratti somatici, i modi di interagire con i simili e con gli elementi della natura che in qualche modo ricordavano gli attributi fisici e il comportamento delle scimmie piú evolute, gli orangutan. Il giovane naturalista era rimasto folgorato dall’evidenza che gli veniva offerta dal caso: ecco trovato in carne, ossa e soprattutto peli, gestualità, andatura e vocalità, un essere che rappresentava lo stadio intermedio di trasmutazione genetica tra la scimmia e l’uomo. Il rovello evolutivo, che già aveva tormentato per anni suo nonno Erasmus, gli veniva risolto dagli irsuti, selvaggi, maschi e femmine uguali, che si arrampicavano con sveltezza sugli alberi, accendevano il fuoco per cuocere il cibo e soprattutto berciavano pronunciando versi organizzati in parole essenziali agli scambi e alle interlocuzioni. Erano, quei primitivi, l’anello probante delle sue teorie che volevano l’homo sapiens discendere per selezione naturale dai quadrumani delle varie specie. Venivano, nella scala evolutiva, dopo l’orangutan Jenny, che aveva sí modi e sensi quasi umani, ma non aveva compiuto il fatale salto dalla dimensione animale a quella umana, sviluppando la parola. Il giovane naturalista impiegò venti anni per trovare e comporre i tasselli del puzzle evolutivo scimmia-uomo, di cui il piú complesso era appunto la facoltà del linguaggio, che l’uomo aveva in monopolio.

Gilgamesh
Avrebbe risolto il problema con un escamotage, come aveva fatto con il problema della creazione. La necessità di stabilire che il cosmo non si fosse animato ex nihilo, dal nulla, ma per mano e volontà di un creatore, quale che fosse la sua natura e forma, aveva assillato l’uomo sin dai primordi della sua entrata in scena nella fantastoria del mondo. Nelle cosmogonie idolatriche delle prime comunità il Dio creatore poteva essere un uccello, un insetto, un rettile. Per gli Egizi era uno scarabeo, Khepri, personificazione di Aton-Ra; per gli indiani algonchini una lepre, Michabo; per i Cherokee il creatore era il ragno Inktomi, detto “Il tuffatore”, perché si era immerso nel mare primordiale recuperandone gli uomini e dando avvio alla vita sulla terra. Il famoso mito greco di Deucalione e Pirra narra che i due, camminando, gettarono alle loro spalle dei sassi, e questi, appena toccano terra, si tramutano in esseri umani di ambo i sessi. E poi c’era Gilghamesh dei Sumeri, con la creazione di Enkidu, l’uomo primordiale, da parte del dio Aruru. E ancora, nella Genesi della Bibbia degli Ebrei, il Creatore interviene di persona a guidare gli uomini alla formazione della loro esistenza, per poi punirli per una disobbedienza.
Ipotesi di menti ingenue, secondo Darwin, non sottoposte al vaglio dei cinque criteri standard di verifica che la prassi impone a qualunque teoria di natura scientifica: che qualcuno osservi il fenomeno mentre si verifica e ne fornisca prova registrata, che possa essere riprodotta da operatori scientifici. Occorre dunque fornire dati accertati, verificabili, non passibili di falsificazioni che contradicano la teoria, che consentano di fare predizioni e infine che possano illuminare aree di conoscenza incerte e indefinite. L’ipotesi che Darwin formulava nel suo L’origine delle specie, pubblicata dopo venti anni di gestazione, nel 1859, non poteva correre il rischio di venire confusa con una delle fertili quando ingenue fantasmagorie cosmogoniche dei popoli primitivi. Non lo consentiva l’aura di rigido positivismo che condizionava tutta la materia scientifica.
Si parlava nei circoli scientifici alternativi di organismi imponderabili in grado di originare la vita. Ne aveva fatto cenno anni prima Thomas Malthus nel suo Saggio sul principio di popolazione, citando il moscerino pungente, non a caso ritenuto il demiurgo creatore della cosmogonia dei Navajo, come l’essere piú minuscolo, quasi invisibile, capace di generare la specie.
Darwin adottò il moscerino dei Navajo come parametro della cellula primordiale che aveva dato origine alla specie umana, agendo da unità singola o in un gruppo di piú cellule. Cosí era iniziata diceva, illo tempore, l’operazione che in una gestazione durata forse eoni aveva creato dal nulla materico l’homo sapiens.
Ci credettero subito, senza esitare, tutti gli atei del mondo: finalmente era nato il verbo evoluzionista che la faceva finita con la fola creazionista di un Demiurgo che aveva fatto dal nulla il mondo e gli esseri viventi in sei giorni e poi si era riposato al settimo, e quella di un Eden dato e tolto agli umani, che avevano solo tentato di conoscere come funzionava il marchingegno ricevuto non in proprietà indeterminata ma solo in comodato d’uso. Insomma, la bibbia di Darwin aveva fatto piazza pulita di tutto quello che i miti e le religioni avevano imposto ai popoli in decaloghi inquestionabili. Ora, L’origine delle specie autorizzava Nietzsche ad affermare: «Dio è morto», e Schopenhauer a gridare al mondo, nel suo Contro il teismo: «Ne ho abbastanza del Creatore!», indicando poi nell’infelicità del vivere la sola virtú per cui varrebbe la pena impegnarsi con i pensieri e le opere.
Era l’inedita pratica morale e materiale del pessimismo esistenziale. Ma ci furono anche, come era da attendersi, forti critiche da parte clericale e umanistica, mentre blandi dissensi e contestazioni di colleghi, naturalisti e filosofi passarono per doverosi ‘contributi’ alla teoria evoluzionista di Darwin.

Victor Evstafieff «Alfred Russel Wallace»
Alfred Russell Wallace, detto “l’acchiappamosche”, perché da autodidatta si era addentrato nelle foreste del Borneo e dell’Amazzonia a caccia di lepidotteri, rettili e insetti rari che spediva via nave in Inghilterra destinati ai ricercatori che non si muovevano dalle loro scrivanie di mogano, e tuttavia stilavano dotti saggi e cataloghi delle tante specie come se le avessero catturate personalmente. Ebbene, Wallace diede in qualche modo un contributo alla teoria di Darwin, asserendo che in base alla sua vasta e documentata esperienza sul campo, anzi nelle foreste e paludi di mezzo mondo, aveva rilevato che il cervello umano era il piú sviluppato di ogni altra specie animale di terra, di acqua e dell’aria. La sua evoluzione dominante sulle tutte le altre specie era stata agevolata dal mega-sviluppo della propria massa cerebrale che, in proporzione, superava in grandezza e peso quella di ogni altra creatura, compresi i grandi mammiferi terrestri e marini. Da qui la sua supremazia intellettuale, che oltre a favorirlo nelle scienze matematiche, gli avevano consentito di acquisire la facoltà del pensiero astratto e il processo creativo.
L’altra contestazione, considerata ‘contributo’, venne da Max Muller, un linguista tedesco che insegnava all’università di Londra. Il famoso docente filologo affermava che il linguaggio, la facoltà di esprimere idee, concetti e sentimenti, era una prerogativa delle specie umana, in esclusiva. Nessuna altra specie ne era dotata.  Questo era il motivo per cui la specie umana si era evoluta, mentre le altre erano rimaste al palo nella corsa all’emancipazione da essere primitivo e ottuso in primate geniale, creativo, cui ogni traguardo espressivo era accessibile. Il linguaggio, dunque, era il catalizzatore delle potenzialità umane atte a fare dell’uomo bruto villoso e schiamazzante un essere armonizzato.
Questo era il motivo per cui la specie umana si era evoluta, mentre le altre erano rimaste al palo nella corsa all’emancipazione da essere primitivo e ottuso in primate geniale, creativo, cui ogni traguardo espressivo era accessibile. Il linguaggio, dunque, era il catalizzatore delle potenzialità umane atte a fare dell’uomo bruto villoso e schiamazzante un essere armonizzato.
Darwin reagí alla scoperta di Muller escogitando una semantica delle scimmie, partendo dal presupposto che la parola, il linguaggio umano, si fosse evoluto dai versi, gridi, grugniti, vocalizzi di gioia e dolore, suoni e onomatopee di vario significato emozionale. Insomma, un ennesimo escamotage per tutelare una teoria che, col passare del tempo, mostrava sempre piú evidenti crepe di contraddizione e indifendibilità.
Patetico fu l’esito di una lezione che l’ideatore della teoria evolutiva tenne in una classe della scuola primaria di Londra. Gli alunni, non condizionati dall’omertà di gruppo, dalla necessità di tenersi mano che s’impone ai membri di un clan esclusivo, in questo caso quello degli scienziati, si comportarono con l’illustre ospite in cattedra usando la disincantata logica elementare dei bambini. La prima domanda che venne fatta a Darwin dalla scolaresca fu di conoscere i dettagli dell’istante in cui l’evoluzione si era messa in moto, come si era materialmente sviluppata e iniziando da che cosa.
Colto di sorpresa dalla elementarità della richiesta, il complesso cervello del naturalista si era inceppato, come se un cavallo da derby fosse stato costretto a tirare un carretto di ortaggi. Lo smarrimento fu di breve durata, poi l’astuzia dialettica suggerí: «Probabilmente con l’intervento di quattro o cinque cellule nuotanti in una pozza d’acqua».
Poi, un’altra domanda: «Da dove venivano quelle cellule, e chi le aveva messe nella pozzanghera?». Le questioni prive di fronzoli retorici e cavilli matematici ebbero il potere di irritare Darwin. Esasperato, rintuzzò: «Beh, non so proprio… Insomma, le cose non sempre si possono spiegare. Le cellule caddero nell’acqua e tutto cominciò a vivere, come vi ha insegnato il vostro maestro. Cosí è nato l’uomo, tutti gli animali, gli alberi e le piante da frutto. Non vi basta?».
No, ai bambini dalla logica elementare le risposte evasive di Darwin non bastavano. E come avrebbero potuto, se a lui stesso, uomo sapiente, sfuggivano i misteri che animano il cosmo?
Gli sfuggivano perché la scienza si era sempre piú avviluppata nel materialismo, da cui era difficile risalire. Scrive in merito Fortunato Pavisi: «Il materialismo scorre in due correnti principali che possiamo distinguere con i nomi di Isaac Newton e di Charles Darwin. Le teorie di Newton, sviluppate fino in fondo, hanno portato all’atomismo, cioè alla negazione dell’oggettività di tutto ciò che l’anima riceve come impressione sensoria: luce, colore, suono ecc. Il newtonismo spoglia il mondo di ogni suo contenuto e uccide l’anima. Esso significa per l’uomo l’impossibilità di condurre una vita interiore. Il darwinismo (che a torto si crede superato) spoglia invece l’anima di ogni contenuto suo proprio (Bene, Verità, Bellezza) e uccide il mondo. L’anima non può vivere senza un mondo oggettivo (negato dal newtonismo) che la sostiene, e il mondo non può sussistere senza un’anima oggettiva (negata dal darwinismo) che di continuo lo ricrea» (7 giugno 1947).
A sua volta Rudolf Steiner, nel suo libro Teosofia (O.O. N° 9), parla di come sono nate e come si manifestano le forze del vivente nei regni della natura e, in maniera diversa, in quello dell’uomo: «La struttura minerale dell’uomo, costituita in modo da avere come suo punto centrale il cervello, nasce per mezzo di riproduzione e consegue la sua figura compiuta per mezzo di crescita. L’uomo ha riproduzione e crescita in comune con le piante e con gli animali. Per mezzo di riproduzione e crescita il vivente si distingue dal minerale privo di vita. Il vivente nasce dal vivente per mezzo del germe. Il discendente si riallaccia all’antenato nella serie del vivente. Le forze per mezzo delle quali si forma un minerale sono legate alle sostanze stesse che lo compongono. Un cristallo di rocca si forma per mezzo delle forze insite nel silicio e nell’ossigeno che in lui si congiungono. Le forze che configurano un albero di quercia dobbiamo cercarle per via indiretta attraverso il germe nella pianta materna e paterna. E la forma della quercia si conserva nella riproduzione dagli antenati ai discendenti. Ci sono condizioni interiori che sono innate nel vivente. Era una concezione della natura grossolana quella che credeva che gli animali inferiori, persino i pesci, potessero formarsi dal fango. La forma del vivente si riproduce per mezzo di ereditarietà. Il modo in cui un essere vivente si sviluppa dipende dall’essere paterno o materno da cui è nato, oppure, con altre parole, dalla specie cui appartiene. Le sostanze di cui si compone mutano incessantemente; la specie permane durante la vita e si trasmette ai discendenti».
E ancora, nel ciclo intitolato La Genesi (O.O. N° 122), Rudolf Steiner spiega la particolare unicità dell’essere umano rispetto agli appartenenti al regno animale: «…All’uomo è stato impresso un organo superiore, e questo stesso uomo diventa un essere vivente. Osservate ora bene quale concetto infinitamente fecondo e importante viene introdotto proprio dalla Bibbia nella teoria dell’evoluzione. Certo, sarebbe sciocco di negare che per quanto riguarda la sua formazione esteriore, l’uomo appartiene, per cosí dire, al grado piú alto del regno animale. Questa banalità può esser lasciata al darwinismo; ma quel che è importante, è che l’uomo non è divenuto un essere vivente allo stesso modo degli altri esseri inferiori; ma che invece all’uomo venne prima conferito un organo superiore del suo essere: un organo superiore, che nei riguardi della sua anima e del suo Spirito era già stato preparato prima: è ciò che possiamo chiamare il germe della natura dell’Io».
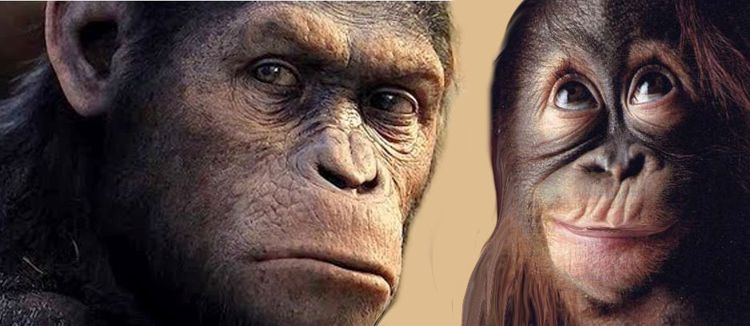 Anche Wallace parlava della centralità del cervello umano, e fondava le sue obiezioni alla teoria evoluzionista proprio sull’organo cerebrale, che aveva fatto dell’uomo un privilegiato nella scala genetica, consentendogli di primeggiare in modo assoluto sulle altre specie e sviluppare, con la facoltà del pensiero, la sua civiltà. Questo favor dei, concludeva “l’acchiappamosche”, era la prova lampante che nella storia umana era intervenuto un qualche altro potere, un’intelligenza superiore regolatrice. Soltanto l’intervento di un potere di carattere definito era in grado di giustificare la supremazia dell’uomo sulle diverse creature.
Anche Wallace parlava della centralità del cervello umano, e fondava le sue obiezioni alla teoria evoluzionista proprio sull’organo cerebrale, che aveva fatto dell’uomo un privilegiato nella scala genetica, consentendogli di primeggiare in modo assoluto sulle altre specie e sviluppare, con la facoltà del pensiero, la sua civiltà. Questo favor dei, concludeva “l’acchiappamosche”, era la prova lampante che nella storia umana era intervenuto un qualche altro potere, un’intelligenza superiore regolatrice. Soltanto l’intervento di un potere di carattere definito era in grado di giustificare la supremazia dell’uomo sulle diverse creature.
I colpi bassi o alti, a seconda dello schieramento in campo, alla teoria evoluzionistica non erano finiti. Max Muller attaccò la “semantica delle scimmie” con la quale Darwin riteneva di aver liquidato la faccenda del linguaggio, evolutosi a suo dire con lo stesso meccanismo degli organi fisici.
Egli affermava che la parola coordinata in linguaggio sensato era un privilegio accordato all’uomo in esclusiva, e testimoniava di una volontà altra di fare dell’uomo il cardine di un disegno. E non si fermava, Muller, al discorso specialistico della genetica. Non potendo demolire la fortezza di notorietà e autorità in cui si era asserragliato Darwin, pensò di riuscirci con la satira scientifica.

La lingua “madrese”
Ecco allora proporre, sulla base della variante onomatopeica dei versi animali concepita da Darwin, una teoria bow-wow, una pooh-pooh, poi ding-dong, la teoria mama, detta poi lingua “madrese”, quindi le teorie yo-he-ho, la sing-song, la hey-you, e altre non meno allusive inventate dalla fantasia del pubblico che ci si divertiva.
La dotta congiura per uccidere Dio scivolava nella patetica farsa.
Patetico è l’aggettivo che piú si attaglia alla periclitante civiltà dell’homo sapiens. Patetica è, infatti, prima di ogni altra, l’idea, ormai dogma, algoritmo e logaritmo, che quella elaborata dalla specie umana in milioni di anni sia la migliore civiltà possibile alla portata dall’homo cogitans.
Dai tanti e tali aspetti che essa presenta, sorge tuttavia l’atroce dubbio che civile, e neanche tanto, essa abbia soltanto l’illusione di esserlo.
C’è tuttavia la variante della specie, l’homo habilis, un iperbolico bricoleur, che pastrocchiando con la materia è approdato alla soluzione finale di poterla disintegrare con l’atomica: è il suo modo maldestro di soddisfare il proprio ego malato di delirio di onnipotenza.
 In realtà quella che l’uomo attuale trova sul fondo della rete a strascico dei fatti e misfatti della sua spesso crudele e insensata battuta di pesca, è l’impotenza, il barattolo vuoto dei propri fallimenti e la disillusione del totale dominio sulla materia, con cui lo aveva sedotto il Serpente nel noto Giardino dell’Eden. Fallito, soffre ormai la penuria dei beni venali che il Signore del Mondo promette a chi di materia vive. Troppo vagheggiata, la materia lo tradisce, sfugge al suo possesso, si nega all’approccio, latita con i benefici di cui, se dominata in toto, essa largheggia. Altrimenti si fa scarsa, persino nelle disponibilità operative. E anche se gratifica un soggetto, è per ribadire il potere sperequativo di cui può avvalersi, semmai, per indurlo nella tentazione di ritenere vana ogni possibilità di recuperare i valori traditi, individuando la causa delle varie disforie nel marasma globale.
In realtà quella che l’uomo attuale trova sul fondo della rete a strascico dei fatti e misfatti della sua spesso crudele e insensata battuta di pesca, è l’impotenza, il barattolo vuoto dei propri fallimenti e la disillusione del totale dominio sulla materia, con cui lo aveva sedotto il Serpente nel noto Giardino dell’Eden. Fallito, soffre ormai la penuria dei beni venali che il Signore del Mondo promette a chi di materia vive. Troppo vagheggiata, la materia lo tradisce, sfugge al suo possesso, si nega all’approccio, latita con i benefici di cui, se dominata in toto, essa largheggia. Altrimenti si fa scarsa, persino nelle disponibilità operative. E anche se gratifica un soggetto, è per ribadire il potere sperequativo di cui può avvalersi, semmai, per indurlo nella tentazione di ritenere vana ogni possibilità di recuperare i valori traditi, individuando la causa delle varie disforie nel marasma globale.
Ecco allora, il laureato ingegnere domandarsi se per caso non dipenda dall’eccesso di neoliberismo imperante se uno del suo livello è costretto per vivere a fare il lavapiatti. «Il n’y a pas de sots métiers, il n’y a que de sottes gens» direbbero i francesi, ovvero non ci sono mestieri stupidi ma solo gente stupida, ciò però non aiuterebbe l’ingegnere a smaltire la sua amara frustrazione.
Certo, ha ragione, ma solo in parte, a caricare sul mulo del liberismo tutto il peso di responsabilità che la civiltà consumistica ha accumulato nel tempo, arrembando le risorse naturali e monetarie al motto “ laisser faire, laisser passer”, l’allegra, incosciente, persino criminale idea di Luigi XV, che al ministro delle finanze che lo ammoniva per la sua dissennata condotta di sperpero, con distacco profetizzava «Dopo di me il diluvio». Che puntualmente arrivò, e tagliò la testa di Antonietta, Luigi XVI e di migliaia di altri francesi. Ancora oggi, lo sfaglio della lama che recideva la vita con la meccanica frequenza di una catena di montaggio, anzi smontaggio, proietta un’ombra sinistra su ogni avvenimento pubblico d’Oltralpe. Lampeggia nei moti del Sessantotto, sui binari dei TGV, sui giubotti gialli dei contestatori che affrontano quelli neri del potere macronico, malato della stessa arroganza dei Borboni di Francia. Una dinastia che si chiuse con l’estremo delitto di cui l’uomo, forma e sostanza divina, possa rendersi colpevole: l’uccisione di Dio, vale a dire di se stesso.
Una commistione di follia e stupidità che, non casualmente, i sacerdoti della ghigliottina vollero sacrare nel Culto della Dea Ragione, entità fredda, tagliente, che ai suoi devoti vietava la misericordia, imponeva cioè il pensiero non temperato dalla sapienza del cuore.
L’idolatria raziocinante si diffuse come un morbo, una pandemia che traboccò dalla Francia e contagiò prima l’Europa e poi il mondo. Uccidere Dio, eliminarlo dal contesto della storia umana, e giustificare il deicidio non come un’ubbia religiosa, ma come un liberare l’uomo dal complesso di sudditanza dal divino che ne aveva tarpate le ali per millenni, aprendogli, con la scienza e il pensiero speculativo, il Giardino dei Segreti.
Guai però a togliere il velo dal simulacro di Iside passando dalla colpa. Fatalmente non è la dea che si rivela all’uomo dissacratore: strappato il velo, egli scopre il proprio volto. E ci vede impressi tutti i guasti dell’anima, vi legge quelli piú gravi sofferti dall’Io divorato dagli Asura, che operano ormai in stretta collaborazione con gli Ostacolatori di eonica militanza. Dovrebbe rinsavire, ripassare la parte, rivedere tante teorie deicide che lo stanno allontanando dalla terraferma a clima temperato, per lasciarlo sul derivante pack artico in attesa dell’orso che lo divorerà. Vecchio e solo, non è ormai neppure piú in grado di rimasticare le coriacee filosofie di cui si è nutrito per secoli.
Ma l’homo insipiens qual è, diabolicamente persevera e s’inventa il Bosone, il Bing Bang, il FoxP2, i creatori di nuovo conio, emuli del dio inverso, che sul mondo in dissoluzione tuona:«Fiat tenebra!».
Leonida I. Elliot
