DEL CONCETTUALISMO CONFORMISTICO ASSURTO A MODELLO ANTROPICO
Mi piacerebbe parlare di cose sagge e istruttive, ma finisco sempre per dire delle banalità generiche che, dopo scritte, non mi soddisfano piú, perché contengono molto poco di quel che avrei desiderato nel progettarle. Forse (mi è stato suggerito da amici in via confidenziale) non mi so spiegare bene. Cosí ho deciso di prendermi una chance alternativa che potrebbe rivoluzionare il mio rapporto con la scrittura.
Normalmente compongo prima il “pezzo” e poi ci metto il titolo che mi sembra migliore in senso relativo. Il titolo è importante, in quanto permette a chi non ha costruito l’articolo di abbozzare un primo concetto su quel che avrà da leggere. Invece adesso agirò al contrario, mi cimenterò in un’esperienza nuova: prima di qualunque altra cosa stenderò un titolo, il piú strano e astruso che la mia fantasia riesce ad immaginare, e dopo, soltanto dopo, creerò un articolo in grado di giustificarlo, alla luce di quella logica di cui mi reputo un affezionato simpatizzante e che quindi spero di non tradire redigendo un ulteriore cumolo di sciocchezze.
Potrei sempre giovarmene nel caso di uno scritto risultante anomalo ed insulso, dal momento che un test pilota ha diritto alle attenuanti in sede valutativa.
E poi in fondo è una sfida con la parte meno conosciuta di me stesso: potrò senz’altro scambiare un titolo folle o insignificante come del tutto inadatto per un articolo destinato a una rivista in cui l’orientamento antroposofico sta al centro dell’impegno editoriale, ma se tale titolo è stato ideato e accolto nella mia mente, anche come pura e semplice provocazione al pensare, allora non può non corrispondere al senso ultimo di chi, scrivendo magari per sé, entra comunque nel mondo dei concetti e delle idee, dove non è piú solo, ma tutti e tutto si animano in concordia vivendo la medesima identità contestuale.
 Cosa sia l’effetto boomerang non mi pare chieda particolare spiegazione, basta sapere che si tratta di qualcosa che, fuori controllo, può far male. Sul “concettualismo conformistico assurto a modello antropico” invece, sono in difficoltà, perché, detto sinceramente, mi sembra un’espressione sovraccarica di astrazione, per giunta aggravatasi durante una digestione turbolenta. Inoltre, sa pure di ambiguità intellettuale, con la quale in genere non vado d’accordo. Spesso nel nostro linguaggio adoperiamo dei paroloni sostanzialmente vuoti di ogni significato decente. Ma nella politica come nella magistratura, nella critica d’arte come in quella letteraria, ci imbattiamo non di rado in autentici spropositi di pensiero, messi lí appositamente da qualcuno che non riusciva a trattenere la libido di stupire il mondo, esibendosi in piroette d’aria fritta.
Cosa sia l’effetto boomerang non mi pare chieda particolare spiegazione, basta sapere che si tratta di qualcosa che, fuori controllo, può far male. Sul “concettualismo conformistico assurto a modello antropico” invece, sono in difficoltà, perché, detto sinceramente, mi sembra un’espressione sovraccarica di astrazione, per giunta aggravatasi durante una digestione turbolenta. Inoltre, sa pure di ambiguità intellettuale, con la quale in genere non vado d’accordo. Spesso nel nostro linguaggio adoperiamo dei paroloni sostanzialmente vuoti di ogni significato decente. Ma nella politica come nella magistratura, nella critica d’arte come in quella letteraria, ci imbattiamo non di rado in autentici spropositi di pensiero, messi lí appositamente da qualcuno che non riusciva a trattenere la libido di stupire il mondo, esibendosi in piroette d’aria fritta.
Concettualismo, altro non è che una maniera di logorare i concetti, o meglio, riesumare i cadaveri di concetti per farsi belli e ammirati laddove c’è poco da abbellire e ammirare. È la codificazione di un processo degradante che da arido diviene patologico, non verificato, e tuttavia misconosciuto. Apre una strada pericolosa, piena di insidie per gli habitué che ormai non possono piú fare a meno di percorrerla. È simile alla necessità di avere sempre a portata di mano il telefono cellulare: se non ci parliamo dentro (nel telefonino, intendo) almeno trenta volte al giorno, o non ci scambiamo qualche dozzina di sms, temiamo di aver perduto il contatto con l’efficienza della vita pratica, mentre (opinione personale) vale proprio il contrario. Viene messa a repentaglio la peculiarità piú alta riposta nell’essere uomini: la capacità di capire, comprendere e scambiare valori immateriali senza ricorrere a protesi artificiali.
Da un noto sociologo apprendo che questa è l’epoca dell’iper-oggetto, ossia la tendenza sparsa un po’ dovunque a costruire un prodotto concettuale costringendolo in una rappresentazione predisposta, diciamo già confezionata, come una scatola di caramelle, per poi usarla a piacere, a volte anche a sproposito. Tuttavia l’uso di questo espediente argomentativo convince l’ascoltatore medio, inducendolo a credere che quanti sanno cosí esprimersi, debbano per forza essere persone colte, intelligenti e capaci di dare utili consigli.
I “persuasori occulti”, i maghi che per decenni ci strapazzano con la pubblicità, sostenendo la panzana colossale che essa sia l’ “anima del commercio”, si sono riciclati ancora una volta e hanno inventato un linguaggio idiomatico di comunicazione dove logica ed estetica vengono frullate in una specie di videogame a nostro uso e consumo (specifico: nostro uso e consumo, nel senso che ci fanno usare e consumare le schifezze per cui vengono pagati).
 Non è piú il concetto a dominare, illuminando i discorsi parlati e scritti, ma è l’idiomatismo, sindrome di un abbassamento del livello medio fino ai minimi termini, a farla da padrone. Siamo passati da vecchie locuzioni nelle quali il concetto racchiuso nelle immagini (per esempio “Parlare a nuora perché suocera intenda”) era non solo accettabile ma anche divertente, ad altre nettamente decadenti: “Non prenderemo decisioni a babbo morto”, dove è evidente la perdita di stile e di tono, fino ad arrivare all’odierno controsenso: «Stiamo attenti: c’è una mucca in corridoio!».
Non è piú il concetto a dominare, illuminando i discorsi parlati e scritti, ma è l’idiomatismo, sindrome di un abbassamento del livello medio fino ai minimi termini, a farla da padrone. Siamo passati da vecchie locuzioni nelle quali il concetto racchiuso nelle immagini (per esempio “Parlare a nuora perché suocera intenda”) era non solo accettabile ma anche divertente, ad altre nettamente decadenti: “Non prenderemo decisioni a babbo morto”, dove è evidente la perdita di stile e di tono, fino ad arrivare all’odierno controsenso: «Stiamo attenti: c’è una mucca in corridoio!».
Nello sforzo di rendere un’idea agonizzante fingendola viva e vegeta, si è costretti a ricorrere all’assurdità dell’astratto, nel tentativo disperato di scuotere l’attenzione degli ascoltatori, i quali – mi sembra giusto – si addormentano, coscienziosamente, in piedi.
Tolta questa premessa ostativa, quel che rimane non ha molta storia. Per questo, accanto al concettualismo c’è l’aggettivo conformistico. È come dire che i concetti, pur essendo la componente essenziale della conoscenza, sono finora rimasti a tal punto ignorati che, nonostante il loro continuo impiego quotidiano, divenuto ormai un abuso, non sono riusciti a farsi riconoscere dall’uomo per quel che in effetti sono: Enti dello Spirito capaci di affacciarsi e sfiorare le nostre coscienze, mentre a tutto questo lavorío, a questa assidua interazione metafisica di fondamentale importanza, noi, dell’umano genere, restiamo per lo piú estranei e indifferenti. Ecco il senso dell’uso conforme: un imprimatur ad assolvere la coscienza pensante dalla responsabilità di non aver pensato.
Potevo affermare la medesima opinione anche a riguardo di altre cose d’importanza basilare per la nostra esistenza, come il sole, l’aria, la natura o la forza di gravità, nei confronti dei quali proviamo… niente, assolutamente niente! Forse, in alcuni momenti di particolare ispirazione, qualche anima pia scriverà dei versetti o dipingerà un quadretto o comporrà un tema musicale in loro onore, ma per il resto l’umanità intera preferisce ingolfarsi e irretirsi nelle panie di problematiche piccole, medie o grandi, di cui il concettualismo conformistico irrisolto (irrisolto perché neppure percepito, nemmeno attraverso l’astuzia dei presupposti astratti) ci investe e ci sommerge poco gloriosamente dall’alba al tramonto.
È facile parlar male degli altri, ma per esemplificare quanto vado esponendo, sono in grado di portare un mio personale contributo, piuttosto sconfortante, capitatomi di recente. Da parecchi anni partecipo ai corsi indetti dall’Università della Terza Età; in particolare seguo il corso di fisica teorica di cui so poco o nulla, ma d’altra parte il corso è rivolto ad un pubblico non professionale e quindi le lezioni non sono soltanto adeguate all’impreparazione dei frequentatori, ma riescono ad essere pure di notevole interesse, soprattutto per l’impegno e la dedizione dell’insegnante.
Ebbene, nell’ultimo anno accademico il corso di fisica aveva per titolo “L’uomo e l’universo; il Principio Antropico”. Purtroppo, per un mio difetto di vista, anziché “antropico” lessi “entropico”, rimanendo lievemente perplesso. Fiducioso tuttavia nelle positive esperienze dei corsi precedenti, cominciai a frequentare comunque gli incontri didattici. C’era nell’aria qualcosa che mi pareva di non riuscire ad afferrare adeguatamente, ma per ben tre lezioni, riuscii a tenere da parte i dubbi che mi scalciavano nell’entrobottega. Fintanto che arrivò il giorno in cui vidi in lettere chiare e tonde, sulla lavagna luminosa dell’aula, che si trattava dell’aggettivo “An-tropico” e non “En-tropico”. Naturalmente ci rimasi male, ma era il prezzo da pagare per la mia sconcertante superficialità.
 Sono convinto che tutto ciò non fornisca una prova tangibile del danno provocato dal concettualismo conformistico, perciò ne fornirò altre due maggiormente obiettive che non quella mia, la quale si può facilmente (volendo esser cortesi) ascrivere nel repertorio delle sviste e delle manchevolezze di chi non possiede piú gli occhi e la mente di un tempo.
Sono convinto che tutto ciò non fornisca una prova tangibile del danno provocato dal concettualismo conformistico, perciò ne fornirò altre due maggiormente obiettive che non quella mia, la quale si può facilmente (volendo esser cortesi) ascrivere nel repertorio delle sviste e delle manchevolezze di chi non possiede piú gli occhi e la mente di un tempo.
Proseguo perciò con un articolo tratto da una celebre rivista scientifica ove si sostiene quanto segue: «La terra, la natura e l’universo che ci circonda, ci fanno capire che la vita nel cosmo non può addebitarsi a una semplice casualità. Il calcolo probabilistico ci dà per impossibile che da uno scoppio iniziale d’energia (per altro sconosciuta) abbia avuto origine quel che oggi siamo in grado di percepire; …bisognerebbe trovare il coraggio – indipendentemente dal fatto d’essere credenti o meno – di concepire questa immensa realtà come frutto di una mente di gran lunga superiore a quella umana; …in essa deve essere presente il Principio Antropico svolto fino nei minimi particolari. Abbiamo a che fare con un’intelligenza che ovunque si crea, si disfa e si ricrea di nuovo, come molteplice forza di vita, studiando gli adattamenti possibili e adeguandosi volta per volta alle necessità – parti integranti del disegno stesso – che si incrociano fra loro provocando continue soluzioni alternative; e si noti bene, sempre in favore di una positiva evoluzione umana. …Non ci è consentito parlare in nome di tutta l’umanità, ma la nostra epoca riconosce nell’interrogativo che segue, la somma esponenziale del patrimonio di scienze e di filosofie da quando siamo apparsi sullo scenario del mondo: esiste un Creatore? esiste un Dio? Vorremmo saperlo in molti; crediamo fermamente che tutti, nessuno escluso, abbiano un enorme interesse a ottenere una risposta chiara e definitiva. Ma a questo siamo impediti dal fatto che nella nostra cultura ogni verità, per diventare universale e oggettiva, deve essere supportata da prove – e forse dovremmo rammaricarcene – ma una fondamentale premessa di questo genere, non si è mai verificata».
Riassumiamo:
TESI: universo, mondo, natura, uomo, vita. Ci sono, esistono, sono incomprensibili, meravigliosi, sublimi, dotati di incredibili facoltà, di tesori di forze e, per chi lo vede, anche di infinita saggezza e amore.
IPOTESI: c’è forse un Dio Creatore?
DIMOSTRAZIONE: spiacenti, ci è impossibile sostenerlo per mancanza di prove.
Faccio una mia modestissima considerazione e la sussurro sottovoce: «Ma scusatemi tanto, tutto quello da cui siete partiti e che avete dettagliato tanto bene nella tesi, che cos’è? Non è forse la piú grande delle prove? Non è l’unica prova possibile per far capire anche alla piú scombussolata e retriva mente umana, che la stessa Energia che ci infonde la vita, ci fa pensare, sentire e volere, e procedere in uno scenario infinito di spazio e di tempo, fatto su misura per una nostra progressione conoscitiva tutta da interiorizzare, è proprio la manifestazione diretta di quel Dio la cui entità, secondo voi, ci diventerebbe possibile solo se confortata da prove?
Ma siamo matti? Siamo arrivati a questo punto di follia? Abbiamo in mano un arnese composto da lama e da manico, tuttavia non ci arrischiamo a chiamarlo coltello perché prima dovremmo avere delle prove!
D’accordo; il coltello è formato da lama e manico, è facile da riconoscere; e l’universo da cosa è formato? Da tutto? Cioè da Spirito e materia? Da fisico e metafisico? E allora in questo tutto devono trovar posto anche l’intelligenza, la saggezza e l’amore, altrimenti che Tutto sarebbe?
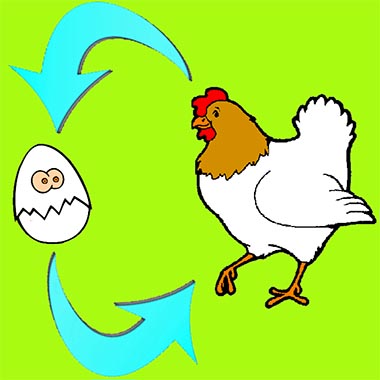 Io capisco che il gioco di “causa-effetto” è stato praticato dalla notte dei tempi e l’abbiamo scolpito nella testa al punto da farlo diventare un chiodo fisso. Tant’è vero che il detto “è nato prima l’uovo o la gallina?” è per l’appunto un’esplicita provocazione a racchiudere in noi l’inevitabile ignorabimus con il quale molti ricercatori, entro- ed eso-nauti, hanno pensato bene (si fa per dire) di concludere i diari delle loro ricerche.
Io capisco che il gioco di “causa-effetto” è stato praticato dalla notte dei tempi e l’abbiamo scolpito nella testa al punto da farlo diventare un chiodo fisso. Tant’è vero che il detto “è nato prima l’uovo o la gallina?” è per l’appunto un’esplicita provocazione a racchiudere in noi l’inevitabile ignorabimus con il quale molti ricercatori, entro- ed eso-nauti, hanno pensato bene (si fa per dire) di concludere i diari delle loro ricerche.
Non risulta troppo difficile comprendere che, nella nostra dimensione di viventi all’interno dello spazio e del tempo, le cose devono accadere succedendosi una dopo l’altra, in una concatenazione che chiama impellentemente in ballo il meccanismo di “causa-effetto”; infatti nel sorgere di una qualsiasi cosa c’è sempre lo zampino di quella che la precede, ed essa a sua volta preparerà di sicuro i presupposti per la creazione di una ulteriore. Ma con tale sistema finiamo per non spiegare alcunché, tranne restare bloccati nel sapere di non saper niente, e che quindi ogni spinta alla conoscenza possa essere definitivamente archiviata come un vezzo antico, vanesio e tutto sommato anche insalubre.
Come pretendere da un sapere cosí “automatizzato” di diventare creativo? Sarebbe come voler raccogliere dagli alberi i frutti dei propri risparmi.
Non considero una colpa l’esser transitati nella dimensione del pensiero che sa afferrare i concetti, senza aver nemmeno sospettato in cosa consista la loro essenza e quale rapporto di continuo sostegno e soccorso abbiano da sempre con noi, ma è certo una trascuratezza imperdonabile non aver voluto continuare a cercare in tale direzione con la dovuta fiducia e perseveranza, anche quando si sarebbe potuto farlo con poco sforzo in piú, avendo a disposizione un insegnamento come quello offerto dalla Scienza dello Spirito. Invece, ignari e ingrati (uso la congiunzione semplice al posto di quella avversativa, per il concorrere unificato di entrambe le deficienze) abbiamo trovato piú comodo relegare una simile possibilità nel deserto delle astrazioni, facendola morire d’inedia, impedendo cosí al potere dei concetti di arricchire le nostre anime con le forze di vita spirituale di cui sono intessuti. Il che significa in ultima analisi aver annientato l’unica ragione della loro presenza nel nostro pensare.
La ricca serie delle incongruenze umane nei confronti del mondo del pensiero, e della vita dei concetti in particolare, offre lo spunto per un ulteriore esempio (avevo infatti parlato di due prove) che stigmatizza la situazione psicofisica e intellettiva corrente nel Terzo Millennio.
 Ho assistito a piú di una conferenza di cultura generale divulgativa, in cui fra svariate cose si asseriva, e con una certa incisività, che la realtà non è mai quella che appare. Io ho sempre sentito una tale sentenza come strana, faticosa e in definitiva poco chiara, non tanto per il suo contenuto immediato, che è facile da afferrare, quanto piuttosto per la disposizione illogica delle parole adoperate per titolare l’argomento, che messe in tal modo si depotenziano le une con le altre e fanno risuonare il costrutto della frase con il preoccupante rumore tipico del coccio fessurato.
Ho assistito a piú di una conferenza di cultura generale divulgativa, in cui fra svariate cose si asseriva, e con una certa incisività, che la realtà non è mai quella che appare. Io ho sempre sentito una tale sentenza come strana, faticosa e in definitiva poco chiara, non tanto per il suo contenuto immediato, che è facile da afferrare, quanto piuttosto per la disposizione illogica delle parole adoperate per titolare l’argomento, che messe in tal modo si depotenziano le une con le altre e fanno risuonare il costrutto della frase con il preoccupante rumore tipico del coccio fessurato.
Dunque, c’è una realtà? Sí. Però essa non è cosí come appare? No, non lo è. E allora come dovrebbe essere questa realtà? Dovrebbe apparire con dei sottotitoli recanti la scritta: «Attenzione, Signore e Signori! Io sono soltanto una realtà apparente. Il che sta a significare che non esaurisco l’intero cumulo di realtà, ma mi limito a presentarne una porzione, ossia una fetta della totalità di cui sono parte; precisamente quella che ciascuno è in grado di percepire. In sostanza la colpa non è mia, ma appartiene esclusivamente al vostro modo di cogliere i miei aspetti e di rappresentarveli».
Interessante vero? Ricorda l’outing di Jessica Rabbit (la ‘sciantosa’ accusata di essere il simbolo della vampirella senza cuore, si difende cosí: «Io non sono cattiva, è che mi disegnano cosí!…), o anche il discorso di qualche maldestro leader politico incautamente cacciatosi nei guai. Ma sarebbe pure una soluzione consolatoria per l’ultimo superstite del pianeta Terra dopo una drastica “movida” termonucleare. Basterà che si ponga in mezzo a due specchi (ammesso che siano rimasti degli specchi interi) e potrà esultare nella riflessione: “Ma guarda in quanti siamo sopravvissuti!”.
Nonostante la valanga di effetti che tende a sommergerci, continuiamo a reclamarne altri ancora per avere finalmente in mano la prova di tutte le prove. Se qualcuno fosse provvisto di un senso di humour piú sottile del solito, potrebbe addirittura sostenere che la Prova, quella con la P maiuscola, l’abbiamo avuta tempo fa e in buona maggioranza non siamo stati capaci di identificarla. Forse il motivo consiste nel fatto che un riconoscimento di questo tipo avrebbe implicato la fine del conformismo di comodo, del teatrino animico di pupi, burattini e marionette, e volendo finire l’elenco, della visione di se stessi e della vita ridotte a un soffione boracifero di ceneri e coriandoli. L’inconsistenza, magra parente dell’aridità interiore, non deve venir svelata, allora come in seguito.
La scienza s’interroga sull’ipotesi di un Principio Antropico pervasivo dell’Universo: se l’uomo non fosse esistito, l’idea del Principio Antropico sarebbe rimasta in una dimensione diversa da questa. Allora il Principio Antropico è un fatto che riguarda l’Uomo che lo pensa o appartiene all’Universo in cui vaga come un autore alla ricerca dei suoi personaggi?
La realtà non poteva quindi essere diversa da quella apparente. Meglio per tutti. Todos caballeros. Troppo comoda per non crederci, troppo utile per rinnegarla, troppo scomoda per rifletterci su. Meglio la fede e l’obolo di qualche monetina per la quotidiana carità, per alcuni; meglio un moderno disinvolto rifiuto per ogni forma evolutiva, per alcuni altri. Il Signore Iddio e il Caso delle Infinite Probabilità possono coesistere sul medesimo trono. Il concettualismo conformistico è in grado di accogliere entrambe le possibilità. E se qualcuno solleverà l’antica eccezione del conflitto di competenza, sicuramente interverrà qualche Corte Suprema che ne rigetterà l’esposto, giudicandolo “incostituzionale per la corrente struttura umana”.
Quanto potrà ancora durare questa manfrina nell’epoca dell’anima cosciente? Durerà fintanto che le categorie degli influencer crederanno nel loro anticonformismo, e non si accorgeranno che sostanzialmente si tratta solo di un maldestro rimpasto di antichi impulsi inerziali.
Eppure, ad evitare il disastro del concettualismo conformistico, spinto dai venti di una ignoranza che si può definire multilevel, bastava aggiungere al tema di sopra (“La realtà non è quella che appare”) la modesta particella “ci” e ne sarebbe scaturito il titolo: “La realtà non è quella che ci appare” sul quale non ci sarebbe stato nulla da ridire: la particella “ci” avrebbe ricondotto il ragionamento sottostante alle eque proporzioni, mentre il non averlo fatto denuncia una pesante assenza di autocritica, di obiettiva valutazione del proprio sé. Denuncia la preoccupante tendenza a far emergere, magari a livello subconscio, un fumus di supremazia narcisistica nei confronti di un mondo decrepito che si atteggia a giovanile e vigoroso.

Escher «Cielo e acqua»
Perché non pensare che il cielo e le creature dell’aria siano stati ideati all’unisono? Perché non pensare che il mare e i pesci che lo abitano siano il frutto di una contempestiva volontà? Perché allontanare da noi l’idea che l’universo, il mondo, la natura da una parte e l’uomo dall’altra, non appartengano ad un unico progetto, ancor oggi in via di attuazione? Fa tanta paura pensare che materia e Spirito siano la medesima cosa, che tuttavia si è voluta disgiungere per culminare nel violento ingresso nell’armonia cosmica di una coscienza pensante umana? Di una coscienza che per capire deve sempre separare, mentre nelle profondità dell’anima, per poter amare deve sempre apprendere, ogni volta ex novo, i segreti del ricongiungere?
Perché non siamo capaci di dirci che né la gallina né l’uovo hanno gareggiato per nascere uno prima dell’altro, ma sono contemporanee metà di un singolo concetto che ha avuto la forza di porsi là come potenzialità biologica e qua come attuazione concreta e vivente? Il vero problema dell’uomo odierno è che, sí, è capace di avvalersi di astrazioni per concepire perfino un tale pensiero, ma dopo averlo pensato, non sa piú cosa farsene. Ha un motivo per comportarsi cosí?
Sta forse nel fatto che ci deve essere sempre un prima e un dopo? una causa ed un effetto, che facciano andar avanti il meccanismo della vita? Come in bicicletta, bisogna dare prima una pedalata di qua e subito dopo pareggiarla con una pedalata di là? Ritorniamo ai primordi in cui davamo un colpo alla botte e uno al cerchio, e ci pareva giusto perché funzionava. Ma vogliamo scherzare?
Nella Filosofia Della Libertà (inizio Cap. IV – “Il mondo come percezione”) Rudolf Steiner precisa: «Che cosa sia un concetto non può essere detto con parole. Le parole possono soltanto rendere attento l’uomo al fatto che egli ha dei concetti».
Il significato piú alto di questa frase mi era sfuggito per molti anni, eppure credo difficile trovarne una capace di illustrare in termini piú semplici ed elementari il fondamento di enorme portata che splende nel suo contenuto; privati dell’apporto di valore proveniente da una ben determinata posizione conoscitiva umana, la vita dei concetti trova senso solo nel morire per diventare nostro pensare, nostro sentire, nostro volere.
Di stretta conseguenza l’esistere umano non può altro che abbassarsi a quel che attualmente è: un insulso, sacrilego esistere (affermazione personale che assumo in piena responsabilità).
 Insulso in quanto viene sciupato il bene piú prezioso che la nostra presenza e il nostro impatto con il mondo del molteplice, sono (sarebbero) in grado di elaborare; e sacrilego perché, non cogliendone l’aspetto saliente, ci sbarriamo la porta di accesso ai Mondi Superiori, ai Mondi della Luce e dell’Amore, che invece pretendiamo trovare qui, tra Luna Park e surrogati di Paradiso, dibattendoci in anguste porzioni di spazio e fugaci spicchi di tempo.
Insulso in quanto viene sciupato il bene piú prezioso che la nostra presenza e il nostro impatto con il mondo del molteplice, sono (sarebbero) in grado di elaborare; e sacrilego perché, non cogliendone l’aspetto saliente, ci sbarriamo la porta di accesso ai Mondi Superiori, ai Mondi della Luce e dell’Amore, che invece pretendiamo trovare qui, tra Luna Park e surrogati di Paradiso, dibattendoci in anguste porzioni di spazio e fugaci spicchi di tempo.
L’inverarsi di un concetto nel nostro pensare prima e nella nostra parola dopo, è il momento che può benissimo venir percepito interiormente; è infatti uno degli elementi fondamentali di tutti gli esercizi spirituali, il momento in cui il Metafisico diviene Fisico: la base della vera ascesi. Risponde alle domande che molti si sono fatti per tutta la vita senza riuscire a venirne a capo.
Com’è che il pensiero ad un certo momento diventa parola? Com’è che la materia ad un tratto si anima di una forza a lei ignota e impossibile? Come fa lo Spirito dell’Universo a farsi riconoscere come Spirito Umano?
Eppure il nostro pensare è l’Universo stesso; tutto ciò che esso fa vivere come pensieri, splende, muore e risorge nei concetti umani.
Già Socrate ebbe a sostenere che i concetti di bontà, di moralità e di amore possono penetrare, come per un impulso magico, le menti e i cuori degli uomini e convivere con essi quali virtú da riprodursi in pensieri, sentimenti e azioni.
La stessa cosa si può rigirare pari pari ai concetti della fisica teorica, laddove essa crede di avere a che fare con effetti (particelle, neutroni, neutrini, protoni, quark e quant’altro) di cause che rimangono tuttavia fuori del famoso “orizzonte degli eventi” (definizione paranoica con la quale insabbiamo limiti e lacune). Quindi, volendo la nostra indagine poggiare sempre su un terreno saldo e sicuro, queste cause presupposte non ci possono offrire altre garanzie di esistere se non subissandoci con gli effetti dei loro comportamenti, di certo studiabili e convalidanti, se non fosse per il fatto che questi, nessuno escluso, ci rimandano ad un quid che per l’analisi scientifica non è un quid, ma è, nella sua essenza, un nulla. Un misterioso nulla producente effetti.
Per lunghissimo tempo abbiamo volto lo sguardo al firmamento, abbiamo studiato il moto delle stelle e dei pianeti; eppure non abbiamo concetti corrispondenti a cosa essi rappresentino e da chi siano stati creati. Abbiamo delle rappresentazioni, talora di ottima qualità, ma ne conseguono piú litigi che concordie.

Woody Allen
È strana la speculazione interiore nella quale si è avventurato l’uomo dal momento che ha cominciato a indagare su se stesso, sulla vita, sul mondo e dintorni; è partito da una contemplazione primitiva ed estatica del tutto, per finire millenni dopo con la scoperta che ogni cosa è in sostanza riconducibile a un microscopico qualcos’altro, fino ad arrivare al nulla. Questo carica di tragicità onerosa le parole del regista-attore e commediografo Woody Allen, quando una misticanza di ironica dignitosità, tipica del suo modo cerebrale di porsi i problemi, lo costringe a svelarsi l’arcano motto: «Dio è morto; il demonio non esiste e io comincio a non sentirmi piú tanto bene»
In questa ottica, mi ha altrettanto colpito l’amarezza di un giudizio di Oriana Fallaci, letto da poco in uno dei suoi libri: «Perfino nel porsi a contatto con l’infinito – afferma la scrittrice – nell’uomo non accade niente, se dentro di lui non c’è la grandezza».

Oriana Fallaci
Io vorrei rettificare un tale giudizio, in apparenza condivisibile quanto l’“asin bigio” dei Cipressi di Bolgheri: in ogni essere umano vive e splende lo Spirito, ma siamo noi, che distraendo l’anima da questa sua eterna sorgente interiore, perdiamo il contatto, e riduciamo la nostra vita a scolorire in un lungo crepuscolo. Da qui nasce l’amarezza che dilaga in diverse forme, da quelle elegiache e quelle mefitiche.
Ci vogliono delle precauzioni e naturalmente tutta l’attenzione del caso, se si vuol ridestare la coscienza, da tempo assopita, di un puntolino (il puntolino uomo) il quale è convinto di starsene all’interno di un segmento temporale, placido o agitato (secondo le inclinazioni personali), e fargli capire che invece non ci sono piú i limiti in cui prima credeva, ma anzi, la sua funzione è quella di attuare la congiunzione tra l’infinità di due semirette, una proveniente da un passato avvolto per ora nell’oscurità, l’altra proiettata verso un futuro che le forze della speranza vorrebbero radioso.
Senza di lui, senza il suo fattivo apporto, chissà, forse sacrificale, questo progetto scompare, si dissolve in una nuvola di altre probabilità escludenti quel puntolino; pertanto l’unificazione non verrebbe compiuta e l’integrità della retta (l’evoluzione umana) sarebbe compromessa per sempre.
Ce la farà? Ce la faremo? Volevo risolvere quasi per gioco la complicazione di dare un significato al titolo semifolle di questo articolo, e strada facendo molti concetti mi sono venuti incontro. Mi hanno aiutato, come sempre. In fondo basta solo pensarli, non chiedono di piú. Per usare un ultimo idiomatismo, siamo spesso a dire “far mente locale”, ma qui è forse piú appropriato dire “far mente spaziale” e mettere per un momento da parte tutto ciò che Fabrizio De André ha magistralmente concentrato nel verso: «…le donne, il tempo ed il governo». È un’immagine ampliabile a piacere, ma le tre parole del poeta sono piú che sufficienti a incorniciare il concetto.
 Di là dagli scherzi e dalle metafore, è di vitale importanza per lo Spirito umano stabilire un contatto di vera e propria amicizia fraterna e leale con i concetti che il pensare conduce incessantemente fino a noi. Nell’epoca e nel mondo odierni, non siamo ancora in grado di farli vivere adeguatamente; tutt’al piú, in qualche caso, manifestiamo loro la simpatia che normalmente riserviamo agli uccellini mettendoli in gabbia o ponendo in bella mostra una vaschetta di pesciolini rossi sul tavolo del salotto. Piuttosto poco.
Di là dagli scherzi e dalle metafore, è di vitale importanza per lo Spirito umano stabilire un contatto di vera e propria amicizia fraterna e leale con i concetti che il pensare conduce incessantemente fino a noi. Nell’epoca e nel mondo odierni, non siamo ancora in grado di farli vivere adeguatamente; tutt’al piú, in qualche caso, manifestiamo loro la simpatia che normalmente riserviamo agli uccellini mettendoli in gabbia o ponendo in bella mostra una vaschetta di pesciolini rossi sul tavolo del salotto. Piuttosto poco.
 C’è veramente bisogno d’altro. Nelle coscienze è maturata una forza nuova, ancora inespressa eppure individuabile, che esige da parte nostra un rapporto radicalmente diverso con il pensare e con i concetti con i quali abbiamo a che fare ogni giorno.
C’è veramente bisogno d’altro. Nelle coscienze è maturata una forza nuova, ancora inespressa eppure individuabile, che esige da parte nostra un rapporto radicalmente diverso con il pensare e con i concetti con i quali abbiamo a che fare ogni giorno.
Se fin qui riponiamo fiducia in Rudolf Steiner, se accogliamo, dopo un lavoro di confronto intenso e progressivo, gli aspetti veritieri delle Sue rivelazioni, non possiamo lasciar passare inosservate quelle, rintracciabili in molte Sue opere, riferenti un futuro prossimo, in cui Egli asserisce che l’uomo saprà cogliere la forza dei puri concetti, sperimentandola come veri e propri impulsi morali. E anche il linguaggio umano ne risulterà trasformato, sarà maggiormente efficace rispetto a quello attuale, che stenta oramai a comporre in parole e frasi i livelli ai quali l’anima incomincia ad avere accesso.
Allora, non certo il concettualismo conformistico, ma sicuramente una rinnovata intellettualità volta allo Spirito dell’Universo, recuperata attraverso il beneficio dell’Antroposofia, potrà agire nel mondo come sorgente perenne di moralità.
Il senso del Principio Antropico che poteva inizialmente fungere da suggestiva ipotesi scientifico-dialettica, non sarà piú un argomento di cultura d’élite, oggi ridottasi a radical-chic, perché ogni essere umano sperimenterà di persona il rapporto verace che lega la parte pensante della propria coscienza a quella etica, rapporto che si esprimerà nell’essenza del suo parlare quanto in quella del suo agire.
A tale fine è richiesta una notevole dose di coraggio, termine oggi piú che mai ingarbugliato in una pluralità di significati deludenti e poco onorifici. Ci sono troppi tipi di coraggio; va a finire che uno si confonde e magari adopera un genere di coraggio inadatto per l’operazione “concetti-coscienza-moralità” che si attende da noi e che ho cercato di descrivere almeno in abbozzo.
Da parte mia estraggo dall’urna delle meraviglie caratteriali, un unico tipo di coraggio; perché mi piace, mi è confacente e so per esperienza che non mi pianterà in asso nel momento del bisogno, anzi, è facile che accada il contrario.
Il coraggio, giusto come lo vedo io, valido in ogni circostanza, è accogliere con gioia e gratitudine quel che spesso accettiamo rassegnati e sottomessi.
Diranno i conducatores del pragmatismo esaltativo: «Con questo non si conquista un impero!».
Hanno ragione. Ma è perfettamente inutile andarglielo a spiegare.
Angelo Lombroni

