Ci avviciniamo ora ai momenti piú significativi e piú esoterici della vicenda del Cristo, che seguiremo principalmente attraverso il quarto Vangelo, che dal capitolo 12 in poi riporta gli eventi attraverso i quali il Cristo si identifica totalmente con la Terra, con il destino della Terra, anzi con il destino del cosmo. Inizia per il Cristo il percorso dell’amore in atto e del sacrificio di sé: del dono dell’Atman all’umanità. In questo percorso si colloca quel lungo discorso dell’Ultima Cena in cui rivela ai discepoli la reale dimensione cosmica della sua missione.

L’ultima cena
Il discorso dell’amore. Il Vangelo di Giovanni riporta (dal cap. 14 al 17) il lungo discorso dell’Ultima Cena, del seder pasquale, che il Cristo ha fatto predisporre la sera del giovedí, secondo l’uso essenico, com’è riconosciuto da molti studiosi. E comincia con quel toccante invito: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore…»: come dire «C’è posto per tutti voi». Poi rivela la sua comunione col Padre («Io sono nel Padre e il Padre è in me») e rivela il futuro dono dello Spirito Santo, del Paraclito, il dono dell’Io sono a ogni uomo. Sono i capitoli in cui il Cristo piú a lungo spiega la sua missione e il suo ideale dell’amore.
Sono tre i verbi che nel Nuovo Testamento esprimono l’azione di “amare”: epithyméô, philéô (talvolta sostituito da stérgô) e agapáô.
- Il verbo epithyméô (Mt 5, 28) significa amare appassionatamente, essere innamorati, essere invaghiti, desiderare. Questo verbo e il relativo sostantivo epithymía (Gv 8, 44) non sono diversi dal significato del verbo greco eráô e dal sostantivo érôs, che indicano brama di possesso.
- Il verbo philéô significa amare nel senso di volersi bene, avere caro, trattare con affetto, baciarsi (fra amici), accogliere amichevolmente un ospite. Philéô era il verbo che esprimeva l’idea di affetto fra amici (il sostantivo philós significa infatti in greco “l’amico”). Con philéô si indicava un rapporto interpersonale fondato sull’uguaglianza, sull’affinità all’interno di una comunità, di una città, di una razza. Infatti, come aggettivo, philós significa “caro” e veniva usato nella relazione fra genitori e figli o tra fratelli. Il verbo philéô ricorre 9 volte in Gv, 5 volte in Mt, 1 volta in Mc, 2 volte in Lc, 2 volte nelle Epistole.
- Il verbo agapáô significa amare nel senso di avere caro, tenere in gran conto, preferire, prediligere: è usato per indicare l’amore verso Dio, il Cristo, la giustizia o il prossimo. Per esempio,
Mc 10, 2: [al ricco] «Fissatolo, lo apprezzò (êgapésen) e gli disse: “Una sola cosa ti manca: va’, vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi seguimi prendendo la croce”». Rispetto a philéô, il verbo agapáô ha una minore sfumatura affettiva o, per meglio dire, emotiva, ed esprime un moto di benevolenza ideale, un tipo di amore che parte dall’alto o che all’alto si rivolge. Nel latino della Vulgata il verbo agapáô è tradotto con díligo, da cui l’italiano “prediligere”. Agapáô ricorre 37 volte in Giovanni, 13 volte in Luca, 8 volte in Matteo, 5 volte in Marco; si trova inoltre 25 volte nelle Epistole di Giovanni. Nel discorso dell’Ultima Cena riportato in Giovanni il Cristo usa sempre questo verbo: «Come il Padre ha amato me, cosí anch’io ho amato voi» (15, 9), «Amatevi gli uni gli altri» (15, 18), fino a quell’ultima preghiera (Gv 17) in cui il Cristo, donandosi completamente agli uomini, dice: «E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
La differenza tra l’amore espresso da philéô e quello espresso da agapáô – differenza in realtà ignota ai Greci dell’epoca classica – risulta particolarmente chiara dal capitolo 21 (15-17) di Giovanni, dove il Cristo pone a Pietro per tre volte la nota domanda: «Mi ami tu?». In realtà la prima e la seconda domanda recano il verbo agapáô: «Dopo aver pranzato, dice Gesú a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami (agapâs) tu piú di costoro?”. Gli risponde: “Sí, o Signore, tu sai che io ti voglio bene (philô)”. Gli dice: “Pasci i miei agnelli”. Gli dice per la seconda volta: “Simone di Giovanni, mi ami (agapâs) tu?”. Gli risponde: “Sí, o Signore, tu sai che io ti voglio bene (philô)”. Gli dice: “Pasci il mio gregge”. Gli dice per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene (phileîs)?”».
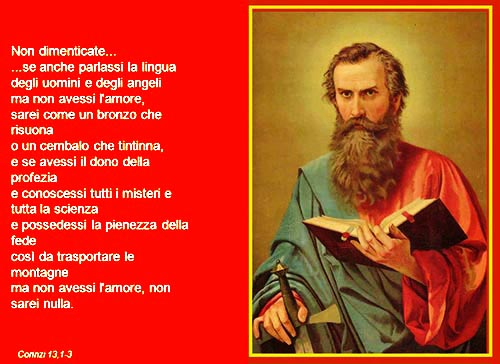 La terza volta il Cristo usa il verbo philéô perché, prima della Pentecoste, gli apostoli, compreso Pietro, vivevano ancora l’amore secondo rapporti di sangue, secondo affinità di gruppo o di famiglia: essi recepivano insomma il valore dell’amore secondo la connotazione espressa dal verbo philéô. Soltanto dopo la Pentecoste, quando sarà discesa su di essi la fiamma dell’amore cristico, gli apostoli comprenderanno appieno il valore universale dell’agápê, tanto che Paolo cosí potrà scriverne nell’“Inno all’amore” (1 Corinzi, 13, 1-8): «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’Amore (agápê), sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna, e se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la conoscenza e possedessi la pienezza della fede cosí da trasportare le montagne, ma non avessi l’Amore, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e offrissi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l’Amore, nulla mi gioverebbe. L’Amore è paziente, l’Amore è benevolo; non invidia, non si vanta l’Amore, non si inorgoglisce, non si vergogna, non chiede per sé, non si affretta, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si compiace della verità; tutto difende, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’Amore non verrà mai meno».
La terza volta il Cristo usa il verbo philéô perché, prima della Pentecoste, gli apostoli, compreso Pietro, vivevano ancora l’amore secondo rapporti di sangue, secondo affinità di gruppo o di famiglia: essi recepivano insomma il valore dell’amore secondo la connotazione espressa dal verbo philéô. Soltanto dopo la Pentecoste, quando sarà discesa su di essi la fiamma dell’amore cristico, gli apostoli comprenderanno appieno il valore universale dell’agápê, tanto che Paolo cosí potrà scriverne nell’“Inno all’amore” (1 Corinzi, 13, 1-8): «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’Amore (agápê), sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna, e se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la conoscenza e possedessi la pienezza della fede cosí da trasportare le montagne, ma non avessi l’Amore, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e offrissi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l’Amore, nulla mi gioverebbe. L’Amore è paziente, l’Amore è benevolo; non invidia, non si vanta l’Amore, non si inorgoglisce, non si vergogna, non chiede per sé, non si affretta, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si compiace della verità; tutto difende, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’Amore non verrà mai meno».
Se volessimo tradurre nel linguaggio della Scienza dello Spirito questo triplice modo di amare secondo i Vangeli potremmo vedere in esso i tre gradi dell’amore: il primo, in quanto si riversa completamente nell’ambito fisico, è tipica espressione dell’anima senziente; il secondo, in quanto si rivela elettivamente nell’ambito eterico, come accordo delle anime, è espressione dell’anima razionale o affettiva; il terzo, in quanto sorge dall’attività conoscitiva del corpo astrale, è segno vivente dell’anima cosciente. L’assoluta superiorità di quest’ultimo grado dell’amore è affermata da Paolo a conclusione del suo Inno: «Queste tre cose rimangono: la Fede, la Speranza, l’Amore; ma di queste la piú grande è l’Amore».
Qui si coglie anche la differenza che esiste fra la compassione, la grande compassione buddhista, per esempio, e l’amore. La compassione, spiega Rudolf Steiner, consiste nell’atto di vedere noi stessi al posto dell’altro, sorge insomma dal vedere noi stessi nell’altro: ci immaginiamo per un po’ al suo posto; l’amore, al contrario, è un moto di identificazione dell’altro con noi stessi: sperimentiamo l’altro dentro di noi, sentiamo come sente l’altro, percepiamo con il sentire dell’altro. La compassione, possiamo anche dire, è un decantarsi della luce del pensare nell’ambito del sentire, è un illuminarsi del sentire; l’amore è invece la presenza dell’Io superiore nel sentire, l’espressione stessa dell’Io.
Quando leggiamo le parole del Cristo: «Non vi chiamo servi, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l’ho fatto conoscere» (Gv 15, 15), ci accorgiamo davvero di cosa sia l’amore. Fra l’infinita ricchezza dei mondi, fra tutti gli esseri spirituali delle Gerarchie che compongono l’universo, il Cristo si è scelto l’uomo come amico e gli ha fatto dono del suo stesso “Io sono”, come una forza gravitazionale dello Spirito: una forza che gravita sul senso ultimo della missione del Cristo: trasformare la nostra Terra in un “Cosmo dell’amore”. Questo è il pensiero di fondo di quell’ultima grande preghiera del Cristo riportata da Giovanni, nella quale il Cristo sceglie come sua eterna dimora l’uomo, «perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola».
Il miracolo di Lazzaro. «C’era un malato, Eleazàr di Betania, del villaggio di Myriam e di Marta sua sorella». Cosí viene presentata dall’evangelista la vicenda di Lazzaro, come se fosse Maria la persona piú conosciuta, il vero biglietto da visita di questo personaggio. Difatti solo Maria era nota nel racconto dei vangeli sinottici storicamente precedenti a quello di Giovanni. Le sorelle mandano a dire al Cristo:

Bronzino «Resurrezione della figlia di Giàiro»
«Colui cui tu vuoi bene (phileîs) è malato»; non conoscono ancora il significato dell’amore. Del Cristo invece si dice che “amava” (êgàpa) Maria, la sorella e Lazzaro. Scrive Steiner (Il cristianesimo come fatto mistico e i Misteri antichi – Milano 1988, O.O. N° 8): «Lazzaro è amato da Gesú. Non si può qui trattare di affetto nel senso ordinario del termine; ciò sarebbe contrario al carattere del Vangelo di Giovanni, nel quale Gesú è la “Parola”. Gesú ha amato Lazzaro in quanto lo riteneva maturo per destare in lui la “Parola”. Fra Gesú e la famiglia di Betania esistevano certi rapporti».
Alla dubbiosa interrogazione dei discepoli sul partire o no verso Gerusalemme, Gesú risponde con la metafora della luce e del giorno già utilizzata nel brano del “cieco nato” (9, 4). Non vi preoccupate – pare dire (8, 12) – se siete con me siete al sicuro, perché io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita! Poi il Cristo aggiunge: «Il nostro amico Lazzaro dorme (si è addormentato, kekoímetai), ma io vado a svegliarlo». Anche della figlia del capo della sinagoga, Giàiro, il Cristo aveva detto: «Non è morta, ma dorme» (Lc 8, 52; Mt 9, 24). Ecco perché i discepoli credevano che il Cristo parlasse del «riposo del sonno», difatti gli dicono: «Se si è addormentato, si salverà». Ma no, Giovanni ribadisce che il Cristo «parlava della morte di lui», anzi il Cristo dice apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché crediate» (11, 14-15).
Gesú resta due giorni nel luogo in cui si trova, poi parte; impiega due altri giorni per arrivare, perciò giunge al quarto giorno dalla sepoltura (in Israele si seppellivano i defunti otto ore dopo la morte). L’anima di Lazzaro vive una tipica condizione: il corpo eterico ha concluso il suo percorso di visione retrospettiva della vita e si è staccato dal corpo astrale, che sta per cominciare il suo lungo viaggio.
Ecco, il Cristo resta fuori dal villaggio; le viene incontro Marta, poi Maria; quindi insieme vanno al sepolcro di Lazzaro. Avendo appreso della venuta del Cristo, Marta gli «corre incontro» (ypéntesen). Lo stesso verbo è usato in Mt 9, 28: due indemoniati geraseni «corrono incontro» a Gesú dai sepolcri, gridando: «Che cosa abbiamo in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?», alludendo al giudizio finale.
Gesú consola Marta con il messaggio della resurrezione, non quella finale, ma dicendo: «Io sono la resurrezione», ovvero «L’Io sono è la resurrezione». E Marta risponde: «Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». Il Cristo rivela insomma a Marta che l’Io è immortale, che l’Io-Cristo è immortale. Marta, come i due geraseni, riconosce in Gesú il Figlio di Dio: la sovranità dell’Io che trasfigura l’umano.
Nel frattempo Maria siede a casa. E Marta la chiama di nascosto: «Il Maestro è qui e ti chiama». Maria «si alza in fretta» (egheíretai tachù) e, vedendo che «si è alzata» (anéstê), gli ebrei la seguono. Lei va fuori del villaggio, dove Gesú ancora si trova, e gli dice la stessa cosa di Marta. Poi Maria piange. Anche Gesú freme nello spirito e piange. I presenti vedono in ciò soltanto un segno della philía: «Quanto gli voleva bene…».
Il villaggio di Marta, Maria, Lazzaro non è che la compagine triarticolata di un’entità spirituale in cui Marta è il volere, Maria il sentire e Lazzaro stesso il pensare; quindi ciascuno di essi è rispettivamente una epitome dell’anima senziente, dell’anima affettiva e dell’anima cosciente; per semplificare diremmo il corpo astrale, il corpo eterico e il corpo fisico. L’Io-Cristo è fuori del villaggio, quindi su un piano disincarnato, agisce dall’alto, dai mondi spirituali.

Resurrezione del figlio della vedova di Nain
A lui corre incontro il corpo astrale e lo riconosce come Io Superiore: è il tipo di guarigione che già si incontra nella vicenda dei due indemoniati geraseni; è il tipo di resurrezione che compare in un altro episodio di poco precedente in Luca alla vicenda degli indemoniati geraseni, la resurrezione del figlio della vedova di Nain. Qui – stando al racconto di Luca, il solo che ne parla – Gesú (7, 11-17) ferma il corteo funebre, tocca la bara e dice: «Giovinetto, alzati (eghértheti)». Qui viene usato non l’imperativo presente, ma l’imperativo aoristo, con significato istantaneo di «Svegliati!»: si può pensare che ciò alluda al fatto che nell’anima del figlio della vedova ancora non si era verificato il distacco del corpo eterico dall’astrale: erano ancora uniti, e quindi ridestabili con un solo intervento.
La guarigione degli indemoniati geraseni, la resurrezione del figlio della vedova di Nain, la resurrezione della figlia di Giàiro in Marco e in Luca sono antecedenti alla prima moltiplicazione dei pani e a “Gesú cammina sulle acque”: sono segni del dominio che il Cristo Gesú acquisisce sul mondo astrale, che il Cristo sta incarnandosi nel Gesú umano e sta irradiando il Sé all’umanità.
Poi è la volta del corpo eterico, che viene chiamato al Cristo e ridestato da lui. Si ripete qui l’essenza del miracolo della figlia di Giàiro. L’Io-Cristo ha il potere di restituire le forze astrali al corpo eterico e questi due corpi insieme alla compagine fisica. Già alla figlia di Giàiro il Cristo aveva detto «alzati» (egheíre) e – si legge in Lc 8, 54 – «il suo Spirito ritornò in lei ed ella si alzò (anéstê) all’istante». Lo stesso si legge in Marco, che riporta addirittura la formula aramaica: «Talità kum» (5, 41). La figlia di Giàiro aveva 12 anni: il corpo astrale non si era incarnato in questa ragazza; ma quando Gesú fece sí che l’eccesso di forze astrali dell’emorroissa fosse donato a lei, essa “si alzò” (anéstê) e cominciò a camminare. La ragazza dormiva nel sonno eterico.

La guarigione dell’emorroissa
Secondo la legge biogenetica fondamentale, la legge che sta alla base dell’evoluzione, per cui ogni passo riassume in piccolo i precedenti, il Cristo, prima di compiere il miracolo di Lazzaro, ricapitola le due grandi resurrezioni da lui compiute: il figlio della vedova di Nain (corpo astrale) e la figlia di Giàiro (corpo eterico). Solo a questo punto può ridestare il corpo fisico: segno del dominio acquisito
sul mondo dell’Atman per donare al mondo questa dimensione spirituale.
Dopo il miracolo di Lazzaro, che – secondo R. Steiner – divide il Vangelo di Giovanni in due parti, le vicende del Cristo si svolgono su un piano totalmente spirituale, dove c’è ben poco di umano: è il piano dell’Atman. Non basta un’interpretazione razionale, occorre elevarsi alla dimensione simbolica, nella quale agiscono le grandi leggi dello Spirito. Non si tratta di simbolismo astratto, ma di una serie di eventi, di figure che sono incarnazioni di precisi princípi o archetipi spirituali, che entrano in azione, diventano fatti, si fanno storia.
La storia sacra, i grandi eventi della storia ebraica sono spesso frutto di un processo di demitizzazione, nel senso che ciò che nelle grandi civiltà precedenti Israele, nelle tradizioni religiose pre-israelitiche era stato visto e contemplato come mito, visione, nella storia d’Israele diviene fatto storico, s’incarna sul piano della realtà, si storicizza. Ciò che per altri popoli è mito, per Israele è storia. Per esempio, la festa di Pasqua era originariamente una festa pastorale della primavera, ma divenne commemorazione del passaggio del Mar Rosso. Mircea Eliade (Storia delle credenze e delle idee religiose, Firenze 1979) scrive:

Il passaggio del Mar Rosso
«La trasformazione delle strutture religiose di tipo cosmico in accadimenti della storia sacra è caratteristica del monoteismo yahwista e verrà ripresa e portata avanti dal cristianesimo».
Dove viene portata avanti dal cristianesimo? Per esempio, proprio con il miracolo di Lazzaro. Le antiche tradizioni religiose conoscevano un processo di metamorfosi chiamato Iniziazione. Nei popoli senza scrittura esso sussiste ancora oggi sotto forma di rito di passaggio, cioè di iniziazione alla pubertà, di entrata nel clan degli adulti. Nella tarda classicità questo fenomeno fu assimilato dal mondo dei Misteri mediterranei. Si passava da profani ad adepti e poi da adepti a epopti dopo una serie di cerimonie iniziatiche. La piú importante di queste cerimonie, quella che dava accesso all’epopteia, che dava accesso alla contemplazione del Divino, prevedeva che l’adepto o l’iniziando restasse per tre giorni in una fase di sonno sonnambulico, sotto la guida dello ierofante. L’anima si staccava dal corpo, nel senso che il corpo astrale ed eterico si distaccavano dal fisico: ciò faceva in modo che i risultati della disciplina interiore seguita dall’adepto, della disciplina di purificazione del corpo astrale, si imprimessero sul corpo eterico momentaneamente svincolato dalla prigionia del corpo fisico. Dopo tre giorni lo ierofante richiamava alla coscienza l’iniziato, divenuto portatore vivente dello Spirito.
Nel caso di Lazzaro il processo simbolico si fa evento. Scrive Rudolf Steiner: «Lazzaro è maturo perché questa azione si compia in lui. Egli si avvolge nella veste degli adepti e si immerge in uno stato di assenza di vita che è al tempo stesso morte simbolica. …Lazzaro fu il primo Iniziato cristiano». E altrove (VGR, p.138): «Lazzaro rimase per tre giorni e mezzo in uno stato simile alla morte. Nondimeno dobbiamo renderci conto che questo stato era qualcosa di differente da quello sperimentato dagli antichi Iniziati. Lo stato di Lazzaro non era stato provocato artificialmente dall’iniziatore, come ai tempi antichi. …In Lazzaro quel fatto era avvenuto, possiamo dire, in modo piú naturale». Non dimentichiamo che per Lazzaro – al contrario delle Iniziazioni antiche – era stato fatto un funerale e allestito un monumento funebre. Ecco perché il Cristo ama Lazzaro, ecco perché si parla di lui come del «discepolo che Gesú amava».
Non è solo Rudolf Steiner a sostenere che Lazzaro e Giovanni l’evangelista siano la stessa persona; quest’ipotesi fu avanzata da Kreyenbühl (1900), ripresa da F.V. Filson (1949) e infine da Oscar Cullmann (Origine e ambiente dell’evangelo secondo Giovanni, Casale 1976): ciò spiegherebbe perché alla fine del Vangelo di Giovanni si parla di Giovanni stesso come del «discepolo che non sarebbe mai morto», appunto perché era stato resuscitato dai morti.
E altrove (Il vangelo di Giovanni, Milano 1956): «Ci viene detto che “il Signore amava Lazzaro”. Cosa significa “amare” nel linguaggio dei misteri? Significa il rapporto fra il discepolo e il Maestro. “Colui che il Signore amava” è il discepolo più intimo, il più iniziato».

L’unzione di Betania
L’unzione di Betania: le due anime del cristianesimo. Ci sono diverse redazioni dell’episodio dell’unzione di Betania; noi seguiremo qui quella data da Gv (cap.12). Siamo a Betania, a 3 Km da Gerusalemme, sull’altro versante del monte degli Ulivi. Maria – quella che secondo la mistica agostiniana Katharina Emmerick non è altri che Maria Maddalena – unge con il myron (olio profumato) i piedi e il capo di Gesú: prepara il suo corpo fisico all’ingresso regale in Gerusalemme. Del resto il Messia (mašíah) è in ebraico l’Unto.
Giuda – l’unico Giudeo, a quanto pare, mentre gli altri sono Galilei – critica il gesto: biasima lo spreco, con eccesso di rigorismo. Anche Devadatta, il cosiddetto Giuda buddhista, era un fanatico osservante, un rigorista che voleva imporre a tutti di dormire all’aperto nella selva e di cibarsi secondo un rigido regime vegetariano. Devadatta creò perfino uno scisma nel 493-492. Giuda e Devadatta sono due rigoristi, due fanatici della norma, della lettera: e la norma, la lettera senza lo Spirito sono il regno di Ahrimane.
E allora ecco che ci viene incontro una duplice immagine del Cristo: da un lato, l’immagine del Cristo che converte e guarisce i poveri, il Cristo maestro di umanità e di carità; dall’altro, invece, il Cristo Maestro di preghiera, la natura divina del Cristo. Sono le due grandi componenti, le due colonne del cristianesimo: da un lato l’amore per i poveri, le opere di carità, lo spirito missionario, dall’altro l’anelito mistico, la contemplazione delle Gerarchie celesti, la pratica della liturgia.
Il Cristo risponde a Giuda che, sul piano spirituale, ci sono atti dovuti come la devozione, che hanno altrettanto valore degli atti di carità, anzi ne hanno di piú. Il volontariato è giusto, ma se non si accompagna alla contemplazione che senso ha? È semplice attivismo.
Queste correnti riaffiorano ancora una volta alla fine del quarto vangelo, quando Pietro, scorgendo dietro di sé l’apostolo Giovanni, chiede al Risorto: «Signore, e lui?». E Gesú risponde: «Se voglio che egli rimanga finché io ritorni, a te che importa? Tu seguimi». E il testo aggiunge: «Si diffuse perciò tra i seguaci la voce che quel discepolo non sarebbe morto». Pietro e Giovanni, le due anime del cristianesimo: la Chiesa visibile e la Chiesa invisibile, la comunità terrena di coloro che credono e la comunione spirituale di coloro che operano per lo Spirito. Il terzo millennio, attraverso le sue prove, avrà il compito assai particolare di unificare queste due anime della tradizione cristiana come mai si sono potute armonizzare prima: sarà questa la missione del cristianesimo sofianico. Si potrà cosí realizzare anche sulla Terra ciò che si è compiuto nel Cristo come archetipo, come modello spirituale: la fusione delle due anime di Zarathuštra e del Buddha: i due eterni archetipi dello Spirito.
La lavanda dei piedi (Gv 13). Ecco, il Cristo è entrato a Gerusalemme come un Re, accolto come un liberatore, al grido di «Osanna» dall’ebraico hoši’ah na’, «salvaci», o con l’invocazione «Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (baruk habba’ bšem ’Adonai), tratti dal Salmo 118, uno dei salmi dell’Hallel («lode») recitato nella liturgia della festa delle Capanne (Sukkot). La seconda invocazione però era anche usata per accogliere i pellegrini che venivano al Tempio di Gerusalemme per le tre feste (Pasqua, Pentecoste, Capanne).

La lavanda dei piedi
«Prima della festa di Pasqua», dice l’evangelista Giovanni, si avvia sull’ultimo tratto del cammino dell’amore. Ma prima Gesú riparte dal cammino di Giovanni Battista e ricorre a un rito lustrale, alla purificazione con l’acqua: compie la lavanda dei piedi. Tant’è che Pietro pensa che Gesú voglia, proprio come Giovanni, purificarli interiormente con l’acqua: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesú però non vuole ripetere il rito di Giovanni, ma vuol dare ad esso un nuovo significato. I piedi sono nell’essere umano ciò che sta a immediato contatto con la Terra, con l’humus terrestre: nessun altro simbolo piú vivo e piú evidente ci poteva essere per rivelare l’umiltà che il Cristo con il gesto della lavanda dei piedi imprime nel corpo astrale dei discepoli.
L’umiltà è il sentimento che meglio controbilancia lo streben luciferico, ma è anche quello che antidota il materialismo, in quanto sottrae la materia alla sua coltre di morte e la rianima di nuova vita, di un sentimento: fa della materia, dell’humus la piattaforma dell’azione spirituale. Per la sua dignità il Cristo sarebbe potuto essere il grande Re-sacerdote della Terra, il grande Maestro: eppure rinuncia a ciò. Il Buddha morí a 80 anni, dopo 40 anni di insegnamenti spirituali, di ininterrotta venerazione da parte dei discepoli, e alla morte venne ossequiato come un re, un imperatore cakravartin. Il Cristo rinuncia alla ricompensa terrena del suo operato: si umilia per dare un primo esempio di umiltà, per far comprendere che l’umiltà è il primo passo dell’Io, dell’agire secondo Io. Senza desiderio di possesso. È importante questo concetto, perché nell’ordine naturale delle cose non è ancora inscritto il progetto dell’Io: è inscritto il DNA delle forze fisiche, bioenergetiche o astrali. Ma l’Io in natura non c’è: ce lo porta l’uomo attraverso l’azione morale: e il primo gradino di questa incarnazione dell’Io è l’umiltà, il fondamento dell’amore. Luca (22, 24 ss.) ci informa che durante la stessa notte del seder «sorse anche una discussione su chi di loro poteva essere considerato il piú grande». E Gesú ribadisce ancora il messaggio spirituale della lavanda dei piedi: «Chi è il piú grande tra voi diventi come il piú piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è piú grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve».
Nell’Iniziazione (O.O. N° 10) Rudolf Steiner specifica che il primo passo della disciplina spirituale è «la venerazione per la verità e la conoscenza. …Solo chi possiede questa disposizione fondamentale può divenire discepolo dello Spirito. …Se non sviluppiamo in noi il profondo sentimento che esiste qualcosa di superiore a noi, non troveremo in noi neppure la forza di svilupparci fino a qualcosa di piú elevato. …Si può ascendere alle altezze dello Spirito solo attraverso la porta dell’umiltà. …Ogni critica, ogni censura, danneggia le forze dell’anima per la sua conoscenza superiore, quanto invece le sviluppa la devota venerazione».
L’Eucarestia. Come si svolse il seder, la cena pasquale, che il Cristo celebrò la sera del giovedí secondo l’uso esseno, e non la sera del venerdí, secondo l’uso ufficiale? In ricordo della liberazione dalla schiavitú dall’Egitto, gli Ebrei mangiano tre pani non lievitati, uno dei quali è diviso dal capofamiglia fra i commensali, e bevono quattro calici di vino, dopo opportune benedizioni e la commemorazione del racconto della fuga dall’Egitto. In particolare i quattro calici del seder ebraico commemorano Dio che ha condotto via gli Ebrei dall’Egitto, che li ha salvati, che li ha riscattati, che li ha presi come suo popolo.

Istituzione dell’Eucarestia
Il Vangelo di Giovanni riporta i discorsi tenuti dal Cristo durante questa occasione, ma non parla dell’istituzione dell’Eucarestia: ne parlano gli altri Vangeli. Conosciamo tutti le parole che accompagnano questo particolare momento: il Cristo eleva il pane e il vino a simboli del proprio corpo e del proprio sangue. Il pane è il simbolo del corpo che egli offre alla croce. Nel Vangelo di Giovanni questo principio spirituale è rivelato da Gesú stesso ai Greci dopo il suo ingresso trionfale a Gerusalemme: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12, 24). Del resto in tutte le civiltà mediterranee, che spesso possedevano dei misteri dalla simbologia agricola, il grano è sempre stato denotato da questo simbolismo di morte e resurrezione. La morte, nel caso del Cristo, è la crocifissione, la croce. Ma per il comune discepolo del Cristo la croce è il segno del dolore, dell’afflizione che ciascuno deve portare su di sé: «Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me» (Mt 10, 38), «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16, 24; Lc 9, 23; 14, 27). La croce è dunque il nostro fardello karmico, il peso dei nostri debiti, che il Cristo ci invita a caricarci addosso, vivendolo con fiducia verso il Mondo spirituale, con abbandono, con volontà di sacrificio, con senso di gratitudine verso il Padre celeste, il Mondo spirituale. Pane, dunque, come simbolo della croce e del karma: pane che Egli dà ai discepoli, perché ormai – grazie alla sua missione – non ci sarà piú un karma individuale di cui liberarsi, ma un karma collettivo da migliorare, perfezionare con volontà di salvezza. Scriverà infatti Paolo ai Galati: «Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete cosí la Legge di Cristo» (Gal 6, 2). Ecco come il pane, dunque la forza della croce, redime la presenza di Ahrimane in noi. Ecco come il Cristo risponde in definitiva al demone della Materia che gli chiedeva di trasformare le pietre in pane.
Il vino è invece il sangue del Cristo, la bevanda di Resurrezione, il Graal, l’immagine della eterizzazione del sangue. Rudolf Steiner chiarirà questo aspetto descrivendo nella Scienza occulta l’esercizio fondamentale della disciplina antroposofica: la meditazione della Rosa+Croce e del suo potere di eterizzare il sangue umano, contaminato dai comuni egoismi.
Questo si desume, a una riflessione attuale, da un corso tenuto da Rudolf Steiner nel 1909, intitolato L’Oriente alla luce dell’Occidente (O.O. N° 113). Rifacendosi al dramma di Edouard Schuré rappresentato in quella occasione – I figli di Lucifero – Steiner dà come immagine conclusiva, immagine di meditazione, la Stella di Lucifero sulla Croce di Cristo, come dire la luce della conoscenza e la fede, il Graal e la Croce.
Il Cristo sofferente del Getsemani. Nel podere chiamato Getsemani («il torchio delle olive») il Cristo prega: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu» (22, 42 – Cfr. anche Mc 14, 36) e medita profondamente sul senso delle parole «Sia fatta la tua volontà». Sul monte degli Ulivi il Cristo fa l’esperienza della morte.

Nell’Orto degli Ulivi
Nel commento al Vangelo di Matteo Rudolf Steiner rivela che il Cristo sul Getsemani sperimenta come il corpo fisico, abbandonato dall’anima, manifesti il suo stato di paura: in quei momenti il Cristo sperimenta come l’anima abbandona il corpo e si effonde nell’universo. Sul Golgotha si realizza ciò che si era annunciato sul Getsemani attraverso l’ematoidrosi: il sangue si versa, l’eccesso di sangue, l’eccesso egoico di Io viene sacrificato. Dice Steiner nel Vangelo di Luca: «L’egoismo fu espulso dall’uomo quando, sul Golgotha, il sangue fluí dalle ferite del Cristo, in modo che nel corso dell’evoluzione potesse venire espulso anche dai singoli Io. Il sangue che scorre dalle ferite del Cristo è il simbolo dell’egoismo esuberante nell’Io umano». Ciò che segue – la crocifissione, la sepoltura – non è altro che l’ascesa del Cristo al macrocosmo, ed è forza fondante di quella legge spirituale che dice: ogni dolore in Terra è una illuminazione nei cieli. Ogni dolore del Gesú umano è tappa dell’elevazione del Cristo.
Questa immagine del Cristo sofferente è tuttavia parte integrante del Cristo risorto e ciò era ben noto al cristianesimo primitivo. Quando però esso divenne religione di Stato, si prestò sempre piú una unilaterale attenzione al Cristo sofferente del Venerdí santo, che venne cosí a prevalere sul Cristo della Pasqua.
Il Cristo muore, secondo Lc (23, 46), pronunciando prima le parole: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (23, 34), e poi le parole parzialmente tratte dal salmo 30, 6: «Padre, nelle tue mani affido il mio Spirito» (la parola “Padre” la aggiunge il Cristo). Ancora a Dio si rivolge in Mc 15, 34 e in Mt 27, 46 quando recita il primo versetto del salmo 22: «Dio mio, Dio mio (Elí, Elí), perché mi hai abbandonato?». Elí sta per l’ebraico Elohí, «mio Dio». Chi è il Dio che Gesú invoca sulla croce? Chi è il Padre invocato da Gesú? Chi è il Padre del quale il Cristo dice: «Io vado al Padre, perché il Padre è piú grande di me» (14, 28)?
Il Padre del Cristo sono gli Elohim, di cui il Cristo è una sintesi. Un legame particolare lega il Padre al Figlio, tanto che il Cristo stesso può dire: «Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 31). Diverso il «Padre nostro» che invece invochiamo noi uomini, perché questo Padre celeste è la Divinità finalisticamente accessibile all’umano, quella totalità di Manas, Buddhi, Atman che il Cristo stesso con il suo sacrificio ha donato all’umanità. Tutta la successiva cristologia dei Padri della Chiesa non è che un commento a questi due versetti del Vangelo di Giovanni. Clemente Alessandrino (Miscellanea VI 16) dirà infatti che «Dio stesso è amore (agàpe) e per amore ci si è rivelato. Ciò che in Dio è ineffabile è il Padre, ma ciò che in lui è compassionevole verso di noi è madre. …Il figlio, partorito dall’amore, è Amore».
La tunica e la veste. Nel mondo mediterraneo del I secolo gli Ebrei vestivano come i Greci, con la tunica (chitòn) che era a contatto con la pelle e con la veste di sopra o vestiti (ta imàtia), ovvero il mantello (imation). Dice infatti Luca (6, 29): «A chi ti toglie il mantello, non opporti a che ti tolga anche la tunica!». Come mantello gli Ebrei usavano il tallit, un panno di lana rettangolare utilizzato come coperta, senza bottoni, fissato con fibbie. Gv (19, 23) dice che i soldati si divisero il mantello del Cristo in quattro parti, mentre la tunica se la giocarono a sorte, a conferma del versetto profetico del salmo 21 (v. 19) che attesta la messianicità del Cristo.
Le vesti dei grandi esseri spirituali hanno sempre una importante simbologia. La ebbe la veste che il giovane asceta Siddhârtha ricevette quando scelse la via della ricerca spirituale, la ebbe la veste che il Buddha lasciò al discepolo piú venerabile Mahâkašyapa affinché la desse al successivo Buddha, Maitreya, e l’ha avuta la tunica del Cristo. Secondo Rudolf Steiner, il mantello del Cristo è la Terra, che è divisa in popoli, razze, continenti; la tunica invece è l’atmosfera che avvolge la Terra, è il simbolo dell’aria che non si può dividere, ma soprattutto è il simbolo dell’amore che avvolge la Terra e che un giorno si realizzerà completamente su di essa.
 Esercizio: «Per Spiritus Sanctum reviviscimus»
Esercizio: «Per Spiritus Sanctum reviviscimus»
Meditazione sulla Sacra Coppa
«Guarda il calice del fiore baciato dal raggio di sole, che suscita tutte le pure forze produttive sopite nella pianta: per questa ragione il raggio di sole è anche chiamato “la Sacra lancia dell’amore”. Guarda ora all’uomo, superiore alle piante e con gli stessi organi celati in lui. Ma quanto nella pianta è puro e casto, nell’uomo è compenetrato da ogni impudico piacere e desiderio. La futura evoluzione dell’umanità porterà l’uomo, nuovamente puro e casto, a creare il suo simile mediante un altro organo di riproduzione trasformato. Come il calice del fiore, puro e casto, senza istinti e passioni, si rivolge alla Sacra Lancia dell’amore, cosí sarà l’organo di riproduzione dell’uomo. Esso si rivolgerà al raggio spirituale della Saggezza e sarà da esso fecondato per la creazione di un altro essere, un altro uomo. La laringe è destinata a diventare questo nuovo organo.» Questo creerà “il Santo Graal dell’avvenire” (da R. Steiner, La saggezza dei Rosacroce, O.O. N° 99).
Gabriele Burrini (8. continua)

