Nella storia dell’umanità ci sono state delle civiltà di volta in volta segnate dall’esperienza diretta e predominante di uno dei quattro Elementi, dal quale esse traevano tutta la loro ragion d’essere, tutto il senso della loro stessa missione terrena.
Le civiltà e la simbologia degli elementi
L’India e l’Acqua
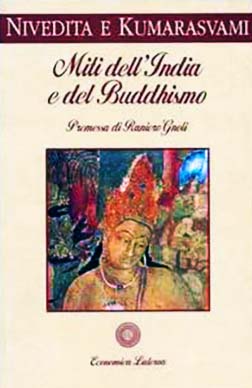 Per esempio, la civiltà indiana, dall’antico periodo vedico all’induismo moderno, ha sempre tratto tutta la sua vitalità religiosa dall’esperienza mistica del Divino sotto forma di Acqua. Basti pensare alla grande importanza nella religiosità indiana delle sacre acque del Gange, che i pellegrini portano spesso a casa in bottiglie per poterla poi usare per la pûjâ, il culto personale o domestico. Gli indiani personificano il Gange in figura femminile e lo chiamano “figlia dell’Himâlaya” o Mâ Gangâ, Madre Gange. Racconta infatti il mito che Gangâ cadde dal cielo sulla testa del dio Shiva: questi liberò poi la fiumana dai suoi lunghi capelli facendola ricadere in sette corsi d’acqua: tre torrenti e quattro fiumi. La caduta delle acque fu accompagnata da un tuono: tutto il creato fu colto da meraviglia. «Molto bella era la visione delle acque cadenti dal cielo sulla testa di Shiva e dalla testa di Shiva a terra. Tutti gli esseri splendenti del cielo e tutte le creature della terra si affrettarono a toccare le sacre acque che purificano ogni colpa» (“Vishnu Purâna”, in Nivedita-Kumarasvami, Miti dell’India e del buddhismo, Bari 1994).
Per esempio, la civiltà indiana, dall’antico periodo vedico all’induismo moderno, ha sempre tratto tutta la sua vitalità religiosa dall’esperienza mistica del Divino sotto forma di Acqua. Basti pensare alla grande importanza nella religiosità indiana delle sacre acque del Gange, che i pellegrini portano spesso a casa in bottiglie per poterla poi usare per la pûjâ, il culto personale o domestico. Gli indiani personificano il Gange in figura femminile e lo chiamano “figlia dell’Himâlaya” o Mâ Gangâ, Madre Gange. Racconta infatti il mito che Gangâ cadde dal cielo sulla testa del dio Shiva: questi liberò poi la fiumana dai suoi lunghi capelli facendola ricadere in sette corsi d’acqua: tre torrenti e quattro fiumi. La caduta delle acque fu accompagnata da un tuono: tutto il creato fu colto da meraviglia. «Molto bella era la visione delle acque cadenti dal cielo sulla testa di Shiva e dalla testa di Shiva a terra. Tutti gli esseri splendenti del cielo e tutte le creature della terra si affrettarono a toccare le sacre acque che purificano ogni colpa» (“Vishnu Purâna”, in Nivedita-Kumarasvami, Miti dell’India e del buddhismo, Bari 1994).
Il bassopiano gangetico è stata la culla dello yoga, della bhakti indiana, del buddhismo. Le sacre acque del fiume sacro sono la metafora dell’eternità dello Spirito che fluisce nel divenire del mondo, di vita in vita nelle infinite successioni delle rinascite. L’acqua in India è l’eterno simbolo del ritorno alle origini: da qui il suo potere di guarigione.
Sulle rive del Gange il pellegrino hindu legge queste sacre parole tratte dal Rigveda X, 9:
 «O Acque, fonti di felicità, vi prego, dateci la forza
«O Acque, fonti di felicità, vi prego, dateci la forza
di poter contemplare una grande gioia…
O Acque che regnate sulle cose preziose
e avete il supremo controllo degli uomini,
vi prego, dateci un balsamo di guarigione».
Sul piano dell’esperienza soggettiva lo yoghin indiano ha vissuto sempre l’esperienza interiore dell’Acqua sotto forma di percezione del prana, che non è il respiro fisico quanto l’alito eterico, la forza vitale che scorre in noi. Difatti lo yoghin indiano, controllando il ritmo respiratorio, si propone di raggiungere la dimensione incorporea del respiro, l’etericità del respiro. Non a caso Rudolf Steiner ha indicato che nell’economia delle grandi civiltà del passato la civiltà indiana fu quella che piú operò alla conformazione del corpo eterico.
L’Iran e la Luce/Aria
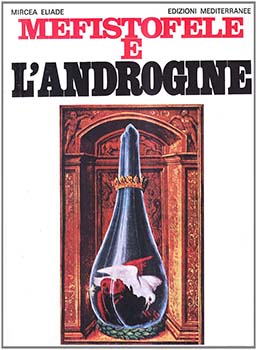
La civiltà paleoiranica, quella che, per intenderci, fa perno sulla personalità di Zarathuštra, non ebbe una cosí grande esperienza dell’elemento Acqua, quanto invece dell’elemento Aria, sotto forma di visione della Luce. Nella predilezione mazdaica per la luce quale veicolo elettivo dello Spirito anche la geografia avrà avuto la sua influenza. Come l’habitat dell’esperienza spirituale indiana è stato il bassopiano gangetico, cosí l’habitat della spiritualità persiana è stato l’altopiano iranico, percorso a sua volta da vaste catene montuose.
Scrive Mircea Eliade: «La speculazione iranica ha riscontrato a un livello non riscontrabile altrove l’antagonismo Luce-Tenebre, riferendo alla Luce non soltanto il Dio buono e creatore, Ahura Mazdao, ma anche l’essenza della creazione e della vita. Questa teologia della Luce percorre tutto il cammino dello spirito iranico, dallo zoroastrismo alla gnosi persiana di carattere ismaelitico. Fu difatti la tradizione religiosa iranica a trasmettere all’Occidente il simbolo luminoso dell’aureola come emblema di santità: questa “luce di gloria”, detta hvarnah era per gli Iranici sinonimo di saggezza e di santità» (M. Eliade, Mefistofele e l’Androgine, Ed. Mediterranee, Roma 1983).
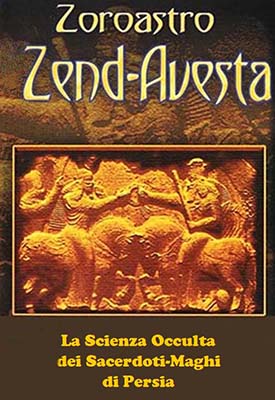 Il profeta Zarathuštra scorge infatti il dio supremo Ahura Mazda, il «supremo Signore», nella luce solare: il suo vestito è il cielo. È lui il padre del Fuoco. Cosí infatti recita il credo degli zoroastriani (Fravarânê, dalla parola iniziale del testo): «Io mi dichiaro adoratore di Mazdâ, discepolo di Zarathuštra, nemico dei Daêva (= Deva), seguace della Legge di Ahura; …faccio gustare tutti i beni del mondo ad Ahura Mazdâ, il dio buono, dalle buone misure [Si riferisce a Vohu Manah, il Buon Pensiero]; santo, brillante e glorioso, da cui provengono tutte le cose eccellenti; dal quale vengono il Bue, l’Ordine cosmico (aša), la Luce, la felicità congiunta alla Luce» [Le Zend-Avesta, Yasna 12].
Il profeta Zarathuštra scorge infatti il dio supremo Ahura Mazda, il «supremo Signore», nella luce solare: il suo vestito è il cielo. È lui il padre del Fuoco. Cosí infatti recita il credo degli zoroastriani (Fravarânê, dalla parola iniziale del testo): «Io mi dichiaro adoratore di Mazdâ, discepolo di Zarathuštra, nemico dei Daêva (= Deva), seguace della Legge di Ahura; …faccio gustare tutti i beni del mondo ad Ahura Mazdâ, il dio buono, dalle buone misure [Si riferisce a Vohu Manah, il Buon Pensiero]; santo, brillante e glorioso, da cui provengono tutte le cose eccellenti; dal quale vengono il Bue, l’Ordine cosmico (aša), la Luce, la felicità congiunta alla Luce» [Le Zend-Avesta, Yasna 12].
Civiltà atlantidea = Terra = corpo fisico
Civiltà paleoindiana = Acqua = corpo eterico
Civiltà paleoiranica = Aria / Luce = corpo astrale
Civiltà ebraico-cristiana = Fuoco = Io (anima senziente)
La civiltà ebraico-cristiana e il Fuoco
La civiltà ebraico-cristiana, ovvero la civiltà che trae le sue origini spirituali dall’evento del Sinai, è il frutto della potente esperienza del Divino sotto forma del Fuoco. Le prime immagini che ci vengono incontro sono quelle tratte dal libro biblico dell’Esodo:

«Elia sul carro di fuoco» Icona bizantina
[1] Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. [2] L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. [3] Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?» (Esodo 3, 1-3).
Successivamente, nella seconda teofania del Sinai, prima della consegna del Decalogo e del Codice dell’Alleanza, si legge:
[18] Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. [19] Il suono della tromba diventava sempre piú intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. [20] Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salí» (Esodo, 19, 18-20).
Questa è l’esperienza fondante. Ma nella Bibbia non vi è soltanto un’esperienza mosaica del Fuoco, vi è anche una esperienza profetica, vissuta dal profeta Elia (circa 870 a.C.). Nell’Ecclesiastico (48,1) si dice infatti: «Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola». Perché queste similitudini? Esse si rifanno alla sua missione profetica che si accende nell’arsura del deserto di Giuda, ma anche alla sua scomparsa dalla Terra. Elia infatti, dice la Scrittura (2 Re 2,11), fu preso da cavalli di fuoco e da un carro di fuoco.
Ma la piú pregnante esperienza profetica del Divino come Fuoco fu vissuta nell’antico Israele dal profeta Isaia (740-701).
Isaia 6,1-8
[1] Nell’anno in cui morí il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio.
[2] Attorno a lui stavano dei Serafini, ognuno aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava.
[3] Proclamavano l’uno all’altro: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria».
[4] Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo.
 [5] E dissi: «Ahimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti».
[5] E dissi: «Ahimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti».
[6] Allora uno dei Serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare.
[7] Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato».
[8] Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!».
Al simbolismo del fuoco si richiama la visione del roveto ardente. Al simbolismo del fuoco si riallaccia gran parte delle visioni avute dai profeti o descritte nell’Antico Testamento: ruote incandescenti, carboni ardenti, fiumi di fuoco, animali infuocati, cavalli rossi, metalli e pietre rosse, vesti di luce sfolgorante e infine l’aspetto igneo dei Serafini e della prima Gerarchia in genere.
Chi è questa entità spirituale che appare a Mosè, a Isaia e ad Elia sotto forma di Fuoco? Rudolf Steiner non ha dubbi: è il Cristo: «Colui che guidò Mosè, che apparve a Mosè nel roveto ardente, colui che condusse il popolo attraverso il deserto, che fece sgorgare acqua dalla rupe, quello era il Signore, era il Cristo! Ma non era ancora venuto il tempo: nemmeno Mosè lo riconobbe. Mosè lo prese ancora per un altro» (Cristo e l’anima umana, Milano 1968).

San Giustino martire
Nel suo Vangelo di Giovanni Rudolf Steiner commenta il brano di Isaia con queste parole: «Chi aveva dunque veduto Isaia? Il Vangelo di Giovanni (“Isaia vide la sua gloria e parlò con Lui”, 12, 37 e ss.) ce lo indica qui ben chiaramente: aveva veduto il Cristo! …Quando si menzionava (come in questo passo di Isaia) il “Signore”, come colui che si manifestava spiritualmente, s’intendeva parlare del Logos, come nel Vangelo di Giovanni».
Potrà meravigliare che Rudolf Steiner dica che il Roveto ardente o il Serafino dalle sei ali sia in realtà già il Cristo. Come dire che la Legge data sul Sinai non fu data dal Dio degli Ebrei, da yhwh, ma dal Cristo, quale fu ascoltato allora dal suo popolo. Fu compreso come una nuova forza che, per distinguere Israele dagli altri popoli, si imponeva come nuova vita morale, giuridica, con nuove norme alimentari eccetera. Eppure questa verità era già patrimonio della piú antica teologia cristiana. Basti leggere qualche pagina di Giustino martire.
Giustino, apologeta del II secolo, era nato in Palestina a Sichem (oggi Nablus, vicino al pozzo della samaritana): un luogo in cui crescevano melograni e limoni, a metà strada tra la fertile Galilea e Gerusalemme. I genitori, che erano agricoltori pagani, lo avviarono alla filosofia: prima stoica, poi aristotelica, poi platonica. Si convertí nel 130 e fondò una scuola sotto Antonino Pio (138-161), al quale dedicò un’Apologia. Questo primo filosofo cristiano sostenne una singolare concezione: volle conciliare filosofia greca e cristianesimo, sostenendo che «tutto ciò che è stato detto di vero ci appartiene» (Apologia II, cap. XIII) e spiegò che il Logos, prima del Cristo, aveva già avuto delle epifanie (manifestazioni): Eraclito, per esempio, poté godere della contemplazione individuale del Logos, infatti da un suo frammento [Clem. Aless. Strom. 105.] si legge che «questo ordinamento del mondo …né un dio o un uomo lo fece, ma sempre era, è e sarà: fuoco sempre vivo, che secondo la propria legge si accende e si spegne» (I Presocratici).  Secondo Giustino, Eraclito era «implicitamente cristiano»: possedeva la fides implicita …perché il Logos illuminava tutti gli uomini.
Secondo Giustino, Eraclito era «implicitamente cristiano»: possedeva la fides implicita …perché il Logos illuminava tutti gli uomini.
Ma soprattutto nella storia sacra – scrive Giustino (Dialogo con il giudeo Trifone, 75, 4) – l’Incarnazione del Logos è preceduta da una serie di logofanie, che erano, a suo dire, altrettante rivelazioni della volontà di Dio Padre. Cosí, scrive Giustino (Apologia II, 111, 2), «coloro che si salvarono in Egitto quando perirono i primogeniti egiziani, dovettero la loro salvezza al sangue dell’agnello pasquale con cui erano stati bagnati gli stipiti e gli architravi delle porte. L’agnello pasquale era Cristo, colui che fu poi sacrificato, secondo quanto disse Isaia: “Fu condotto come pecora al macello” (Is 53, 7)».
E piú oltre Giustino aggiunge (127, 4): «In altri tempi si fece fuoco per parlare con Mosè dal roveto». Insomma Giustino attribuisce queste teofanie non a Dio, ma al suo Logos, all’unico volto visibile di Dio: questo Logos preesistente, secondo Giustino e il suo seguace Eusebio di Cesarea, è identificabile con la Saggezza increata, la Sophia di Proverbi 8.
Gabriele Burrini
(12. continua)

