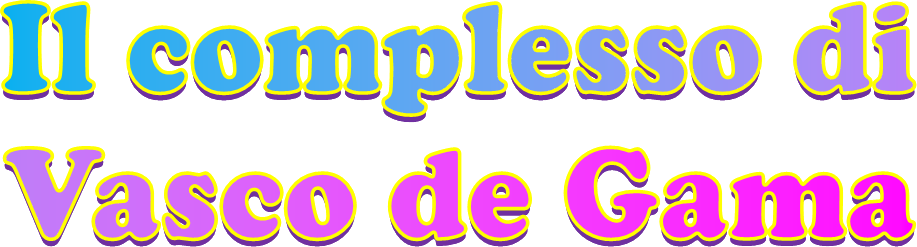Air India, Aeroporto di Bombay Anni ’70
Anni fa ero in India per un corso di specializzazione in tecnica tariffaria relativa al trasporto aereo intercontinentale. Lavoravo allora per la Compagnia di bandiera indiana che aveva, e penso abbia tuttora, la sede centrale a Bombay, oggi ribattezzata, in un sussulto ritardato di nazionalismo, Mumbay.
Allora, non esistendo i computer, si doveva procedere a mano all’elaborazione del costo di un biglietto aereo per passeggeri o di una lettera di vettura del cargo merci, ossia si doveva calcolare la tariffa tenendo conto delle valute internazionali e dei cambi relativi. I low cost erano ancora un’ipotesi di fantascienza. Dunque si cercava, mediante sofisticate alchimie di punti fittizi di riferimento, quanto offrisse una tariffa piú vantaggiosa, operando con stratagemmi di valuta, combinando tratti e segmenti, sconti per numero e via di seguito. Si doveva pervenire a un prezzo finale di assoluto valore concorrenziale, essendo la competitività seriamente feroce. Saperne di piú di un vettore concorrente, voleva dire instaurare su una certa tratta di operazione una sorta di monopolio tariffario, e ciò voleva dire allo stesso tempo esclusiva del relativo traffico passeggeri e merci.
A Bombay, alla scuola di elaborazione costi, si imparavano gli espedienti per ottenere il prezzo migliore sugli itinerari serviti dalla compagnia per la quale lavoravo. I corsi erano quindi ad alta specializzazione, e durante le ore di lezione si procedeva spesso al brain storming. A turno, cioè, gli allievi formulavano ipotesi tariffarie, suggerivano combinazioni, rispondevano a quesiti all’impronta. Il professore, un mite signore di religione induista, vegetariano, di grande cultura non solo riguardo alla materia di studio dei corsi, mi chiese un giorno di formulare un caso tariffario che la classe avrebbe dovuto poi sviluppare e prezzare sulla base tariffaria piú conseguente all’ipotesi vertente sui viaggi per studenti piú giovani.
Andai alla lavagna e scrissi: «Un ragazzo indiano va a studiare a Londra…».
Il professore con garbo mi interruppe: «È lo stesso per lei se trattiamo di un ragazzo europeo che viene a studiare in India?».
«Certo – dissi confuso ma consapevole degli equivoci dell’appunto – credo che sia lo stesso, la tariffa è uguale nei due sensi».
Durante l’intervallo per il tè, il professore si avvicinò a me e mi disse: «Sono spiacente, non vorrei averla messa in imbarazzo. Il suo è un atteggiamento mentale di tutti gli europei. Potremmo chiamarlo “il complesso di Vasco de Gama”».
 Al che, incuriosito, volli saperne di piú. E il professore mi invitò al suo circolo, dove tra le altre attività si giocava a cricket. Un game di puro stampo britannico nel quale, mi dissero altri soci, il professore era un vero campione.
Al che, incuriosito, volli saperne di piú. E il professore mi invitò al suo circolo, dove tra le altre attività si giocava a cricket. Un game di puro stampo britannico nel quale, mi dissero altri soci, il professore era un vero campione.
Era un club frequentato dalla gente bene, professionisti per lo piú, alti funzionari della pubblica amministrazione, imprenditori e commercianti arricchiti, per i quali il circolo costituiva un approdo qualificante nella società che contava a Bombay. Come tutte le istituzioni di un certo tono, anche il club, nonostante la colonizzazione inglese fosse ufficialmente terminata il 15 agosto 1947, conservava ancora usi, costumi e oggetti dei dominatori. A parte il cricket, parlavano di quel dominio di sottomissione l’organizzazione del club, il mobilio, persino i camerieri, vecchi compíti e lenti nei gesti, che ci servirono al tavolo sotto la veranda che dava sul prato erboso. Apparecchiarono con tutte le posate di alpacca chiara, persino quella del pesce, e con una serie di bicchieri e coppette.
Noi mangiammo però all’indiana, riso al curry e stufato di legumi, ma il dolce fu solo per metà indiano: un sorbetto al pistacchio con sopra il lascito inglese della crema al custard. Con tatto feci notare al mio anfitrione proprio quei contrasti. I fantasmi del dominion erano ancora lí, aleggiavano intorno, s’imponevano con i loro modi e strumenti.

Cristo e Krishna
«Vede – mi spiegò il professore – noi indiani, e in parte tutti gli orientali di religione induista, buddista e le loro derivazioni e innesti, fino allo shintoismo giapponese, non escludiamo altre forme di dottrine. Assimiliamo tutto l’estraneo, non lo rifiutiamo. Amiamo lo scambio e lo preferiamo al rifiuto dell’altro che ci porta la storia. Se una religione straniera porta del bene e aggiunge valori alla nostra, perché non accettarla? Cosí usi e costumi stranieri, se utili e positivi, perché rifiutarli?».
Nel corso della serata, mentre fuori sul prato si udivano i colpi delle racchette da cricket e dal gazebo al centro del giardino un’orchestrina suonava motivi internazionali alla moda, toccammo molti dei punti che riguardavano la colonizzazione nel suo insieme. E cosí tornammo, per ordine di cose, a parlare di quando tutto era cominciato, per l’India in particolare e per il mondo in generale.
«Credo – aggiunse a un certo punto il professore – che tutto dipenda dal carattere delle varie religioni. In Occidente vigono quelle di tipo monoteistico, derivate dall’ebraismo. Lo stesso cristianesimo, con tutte le sue derivazioni scismatiche ed eretiche, nelle sue forme successive agli inizi di tipo gnostico, risente dell’assolutismo di tipo messianico, benché il Cristo non sia venuto a fondare una religione, ma abbia portato soltanto una rivelazione che sarebbe dovuta servire a ben intendere ogni tipo di credenza e ad accrescerne la tendenza al divino. Allorquando però il cristianesimo è divenuto religione di Stato, ha assunto le stesse abitudini e tendenze messianiche e assolutistiche dell’ebraismo e dell’islamismo. È un danno quando la religione si allea con il potere politico, ma peggio è quando il potere politico, i governi cioè, si tingono di teocrazia e usano la religione quale strumento di giustificazione delle loro azioni materialistiche e, nel caso dell’Europa, imperialistiche. E qui torniamo a Vasco de Gama».
 La nostra conversazione sarebbe a quel punto durata a lungo, ma fummo interrotti dagli amici del professore, che vennero a invitarci per un giro in carrozzella fino alla spiaggia di Chowpatty, la riviera dove tutta Bombay si riversava la sera a prendere il fresco.
La nostra conversazione sarebbe a quel punto durata a lungo, ma fummo interrotti dagli amici del professore, che vennero a invitarci per un giro in carrozzella fino alla spiaggia di Chowpatty, la riviera dove tutta Bombay si riversava la sera a prendere il fresco.
 Lí avveniva di tutto: seguaci di Ganesh, il dio elefante, che immergevano la statua infiorata del loro signore, figlio di Shiva e Parvati, nelle acque dell’oceano; spettacoli estemporanei di giocolieri e fachiri, struscio delle famiglie in abiti vaporosi di seta o chiffon le donne, gli uomini alcuni vestiti all’europea, molti però con le camicie kurta ricamate, di tanti colori vivaci.
Lí avveniva di tutto: seguaci di Ganesh, il dio elefante, che immergevano la statua infiorata del loro signore, figlio di Shiva e Parvati, nelle acque dell’oceano; spettacoli estemporanei di giocolieri e fachiri, struscio delle famiglie in abiti vaporosi di seta o chiffon le donne, gli uomini alcuni vestiti all’europea, molti però con le camicie kurta ricamate, di tanti colori vivaci.
 Ci fermammo alla bancarella della spremuta di canna da zucchero, e reprimendo le mie angosce da contaminazione batterica, insistenti per la verità, fui costretto con sorriso a bere dallo stesso bicchiere di metallo passato da una bocca all’altra. Iniziazione, quindi, alla varia umanità ecumenica. E poi alla bancarella della spremuta di melograni. Una scoperta. Coltivati nel Kashmir, le melagrane arrivavano a Bombay, cosí come nel resto dell’India, insieme alle mele e alle ciliegie. Le melagrane venivano pressate con un apparecchio rudimentale, e il succo, incredibilmente dolce e aromato, ci venne servito, quello sí, in bicchieri di carta.
Ci fermammo alla bancarella della spremuta di canna da zucchero, e reprimendo le mie angosce da contaminazione batterica, insistenti per la verità, fui costretto con sorriso a bere dallo stesso bicchiere di metallo passato da una bocca all’altra. Iniziazione, quindi, alla varia umanità ecumenica. E poi alla bancarella della spremuta di melograni. Una scoperta. Coltivati nel Kashmir, le melagrane arrivavano a Bombay, cosí come nel resto dell’India, insieme alle mele e alle ciliegie. Le melagrane venivano pressate con un apparecchio rudimentale, e il succo, incredibilmente dolce e aromato, ci venne servito, quello sí, in bicchieri di carta.
Due giorni dopo ripartii, e Vasco de Gama rimase lí, sospeso nell’aria, intriso degli odori di curry forte proveniente dalle cucine del club e da quelli dell’erba del prato meticolosamente curato all’inglese. Ma quei discorsi mi fecero in seguito molto riflettere sui rapporti intrattenuti dai popoli colonizzatori con quelli sottomessi. In particolare mi aveva colpito l’osservazione che aveva fatto il professore sul carattere assolutistico delle conquiste europee nei secoli, tutte portate a termine nello spirito fondamentalistico che imponeva la propria fede, la propria cultura, le proprie istituzioni politiche e sociali, in forma coatta, esclusiva. Ogni altra espressione locale andava cancellata, obliterata dalla storia. Possiamo immaginare quanto sia andato perduto di valori umani, culturali, espressivi e persino spirituali.
Questo, a detta del professore indiano, derivava forse dal fatto che le conquiste avvenivano nel segno di accaparramenti materiali e territoriali, ma lo spirito che le animavano era una deformazione, uno stravolgimento delle dottrine religiose praticate dai conquistatori, che non ammettevano altre fedi all’infuori di quelle che essi praticavano. Intransigenza, dunque, intolleranza, dovute al carattere messianico della tradizione biblica, che aveva stravolto lo stesso messaggio evangelico, imponendolo come dogma indiscutibile e incontestabile. Crederlo, investiva i conquistatori di un’autorità che veniva loro attribuita dal fatto di possedere una fede rivelata, stabilita motu proprio come la sola, la vera, alla quale tutti dovevano aderire con le buone o con le cattive.

Vasco de Gama
Fu cosí che il portoghese Vasco de Gama, primo ad approdare in India nel 1498 dopo aver circumnavigato l’Africa e doppiato il Capo di Buona Speranza, autore di massacri cruenti in nome della sua supremazia religiosa, riuscí ad ottenere l’egemonia della flotta portoghese sull’oceano indiano, a venire in seguito nominato Viceré dell’India e ad essere insignito in patria dell’Ordine Supremo di Cristo. Un premio molto ambito, che lo avrà sicuramente fatto sentire superiore ad ogni persona di alto lignaggio del suo tempo, soprattutto se indiana. Una sensazione esaltante, un vero “complesso di Vasco de Gama”.
Fulvio Di Lieto