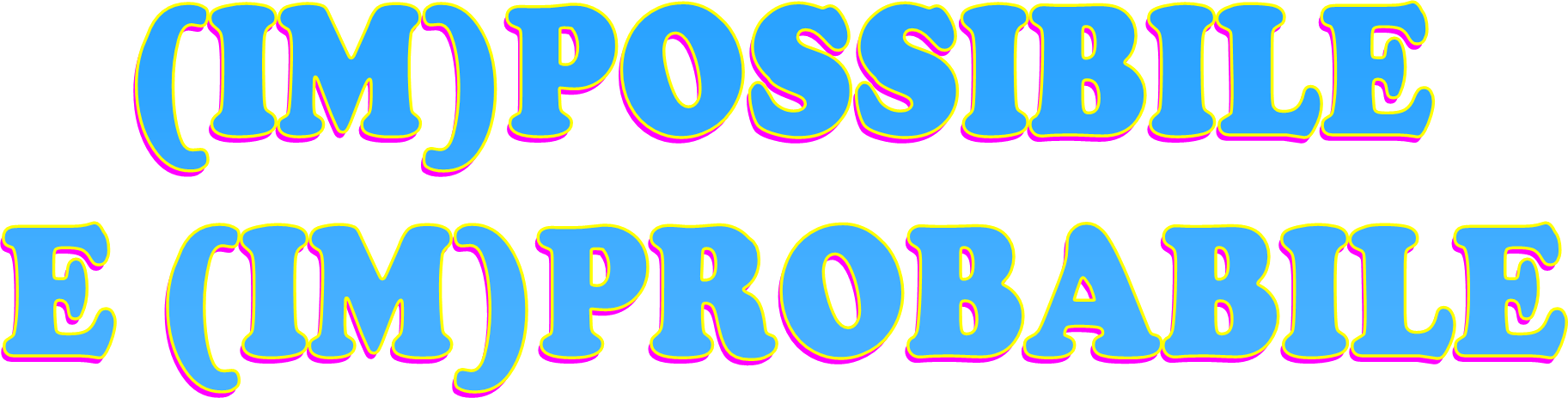Devo fare ammenda: in un mio precedente scritto ho criticato la scientificità del metodo mediante il quale si giunge a sostenere che, iniettando un vaccino anticovid (la cui efficacia dopo preventivo controllo è risultata del 60%) su un gruppo di 10 persone sane, come esito avremo sei di queste immunizzate, mentre sulle restanti quattro, il farmaco non avrà avuto effetto.
Questa logica mi pareva incredibile e per molto tempo me ne sono contrapposto, convinto che nel caso descritto, ognuna delle dieci le persone trattate col farmaco sarebbe risultata immunizzata al 60 %. Se tale era il potere parziale del rimedio, perché non avrebbe dovuto essere altrettanto parziale anche la sua applicazione sulle persone offertesi alla prova? Perché l’effetto non avrebbe dovuto equivalere per tutti?
Non avevo fatto i conti con l’oste. La mia opposizione non farebbe una grinza, se fin dall’inizio del ragionamento avessi saputo distinguere il “possibile” dal “probabile”. Nel caso in esame (somministrazione del vaccino) non ho tenuto in considerazione la disponibilità del corpo umano ad accogliere il medicamento e alle modalità reattive conseguenti.

Una medicina – che funzioni al 60 % – può aver presa su alcuni tipi fisici e non su altri; in modo che a seconda di come siano strutturati i vari organismi (e soprattutto di come possa reagire il corpo eterico degli esseri umani di fronte ad una terapia introdotta dall’esterno, ma questa nota è ovviamente riservata ad un certo gruppo di lettori) il farmaco potrà tanto attecchire quanto non dare risultati.
Le statistiche della scienza hanno finora fornito questo dato, che è diventato nel tempo il riferimento preciso, quasi dogmatico, per gli analisti del sistema sanitario: la percentuale degli effetti benefici sarà numericamente uguale al grado di efficacia del vaccino, considerando però il numero dei somministrati costituente un organismo unico (ai puri fini numerici, ovviamente). Ma non ci svela la vera causa di questa affermazione che a me invece appare estremamente importante.
Quando parliamo di efficacia vaccinale, noi restiamo nel campo delle possibilità; un medicinale testato al 60% (della sua potenzialità totale) è un dato che va letto sotto la voce del “possibile”; esso può funzionare al 60%. Non si può né si deve sostenere altro.
Se invece entriamo nel campo dell’applicazione, e in particolare prendiamo in esame il settore nel quale gli organismi trattati dal farmaco vengono sollecitati alla reazione, allora noi siamo passati dal campo delle “possibilità” a quello delle “probabilità”; che è cosa ben diversa dalla prima. Qui i dieci prescelti dell’esperimento non sono piú un “corpus” reagente unico, bensí dieci corporeità differenti, ciascuna reattiva a modo suo.
Nella possibilità, vale il sí o il no; una cosa può accadere come può non accadere. Ma nel calcolo delle probabilità, si deve tener conto di quel che effettivamente è accaduto e misurare la percentuale delle evenienze manifestate. In particolare, nel primo caso (possibilità) si vuole osservare l’incidenza in positivo dell’evento in sé; col secondo, si analizza la sua graduale suddivisione nelle situazioni specifiche.
Non per niente esiste il calcolo delle probabilità, e non quello delle possibilità, che fondamentalmente si riducono solo e sempre a due.

Mettiamo che il sottoscritto, colto da un particolare raptus gastronomico, desideri fare una torta; controllo di avere tutti gli ingredienti necessari a disposizione, e poi dichiaro: sí, io posso fare una torta. Mi concedo la possibilità del fare. Accanto ad essa c’è soltanto l’altra: quella del non fare.
Ma se domando: la torta mi verrà bene o no? Allora sono passato nelle probabilità e per verificarle devo prima eseguire il compito prefisso, cosicché – lo dico per assurdo, ma non troppo – facendo 10 torte potrò alla fine dire che alcune mi son riuscite bene e invece le restanti erano da buttare.
Da ciò posso anche dedurre – a posteriori – il grado della mia capacità culinaria; se, per esempio, fossi stato capace di portare a termine sei dolci su dieci, potrei attribuirmi un livello di abilità pasticcera del 60% senza far insorgere malcontenti matematici.
Ecco quindi in risalto l’elemento che mi aveva indotto a svolgere una riflessione errata: non si può applicare al settore delle probabilità le medesime regole che valgono per quello delle possibilità. Il controsenso sta nel non accorgersi d’averlo fatto; non si è voluto arrivare al nocciolo della questione, che è un problema del pensiero del tutto indipendente dalle vesti argomentative di cui si è avvalso per apparire e suscitare i termini del problema.
Troppo spesso nel linguaggio comune, si tende a confondere tra loro il possibile col probabile, e ciò vale altrettanto per l’impossibile e l’improbabile.
Del resto, per gli amici che seguono l’insegnamento della Scienza dello Spirito, e in particolare per quelli che hanno conosciuto da vicino Massimo Scaligero, c’è una semplice controprova da fare: quando venne scritto il libro dedicato all’opera del Maestro, i discepoli che ne furono gli autori, vollero per titolo: Massimo Scaligero – Il Coraggio dell’Impossibile; a nessuno di loro passò per la mente un Coraggio dell’Improbabile; e questo è il distinguo piú verace e incisivo di quanto possa dirsi in merito.
Sarò obbligato ora a fare un salto che, in un primo momento, potrebbe apparire poco logico; sembra una crepa nella trama di questo scritto, eppure garantisco che non lo è; in breve mi ricollegherò infatti alla tematica iniziale. D’altra parte, qualche volta si rende necessario uscire dal registro dei significati letterali e allargare il campo delle indagini su nuovi panorami; soprattutto ai fini di ricavare ulteriori esperienze. Sono esse infatti a costruire, pezzo dopo pezzo, il cosiddetto quadro generale della situazione, ovvero il tessuto di quanto si vuole (o si vorrebbe) esporre.
Ricordo la parte finale di una conferenza, fatta da un insegnante di fisica teorica (che in seguito ha voluto offrirmi la sua amicizia, peraltro graditissima e ricambiata). L’argomento trattato era un suo cavallo di battaglia: “Ipotesi sull’origine della vita nell’universo”. In passato, aveva scritto alcuni libri, delineando, sia pure a larghi tratti, la propria versione in merito a tale punto, che dai colleghi piú ortodossi venne interpretata come un vero sconfinamento nella metafisica. Forse è per questo che dovette subire molte critiche e contestazioni, tanto aperte quanto indirette, ma – per contro – è proprio tale licenza che me lo rese, fin dal primo incontro, cordialmente simpatico e gradevole, prima di tutto sul piano umano e poi scorrendo le sue riflessioni, ammirevole per certe affermazioni alquanto insolite tra gli studiosi delle scienze esatte.
«In conclusione – egli sostiene ogni volta che può – negare che la forza cosmica generante l’universo, le galassie, gli ammassi stellari, abbia partecipato in modo preponderante anche alla formazione della vita organica, per molti potrà essere improbabile, ma per me – se mi permettete – è del tutto possibile. E voglio rincarare la dose, col dire che l’impossibile consiste solo nel fatto che non sia cosí. …Sono convinto, anzi, dalle mie ricerche, che la vita organica sia stata da sempre la mèta della intera costruzione del creato; quel progetto originario, che per noi scienziati attualmente parte dal Big Bang, aveva come sua destinazione il formarsi di una aggregazione di particelle che attraverso un intricato gioco di valenze hanno saputo costituire il primo sistema neuro sensorio. Da quel momento in poi, tutto quel che segue è solo una logica conseguenza».
Si può comprendere come e quanto una affermazione del genere proferita ex cathedra da un docente che almeno dal tono e dal timbro della voce sembrava sapere il fatto suo, venisse a risuonare in me nel particolare momento della vita, nel quale avevo scelto come mantra stagionale, il motto antroposofico “l’uomo è la mèta delle Gerarchie”.
Un legame si lascia supporre; un vincolo si intuisce; un rapporto può essere frutto di fervide congetture o anche di scatenata fantasia: ma poche cose sono piú potenti di una saldatura tra due concetti staccati e distanti, quando viene eseguita davanti ai nostri occhi da uno specialista, tanto piú se costui abbia in anticipo precisato la posizione personale di scettico e ateoretico in relazione alle parti trattate.
La scienza non si pone i “perché”; lascia questi ultimi alla speculazione dei filosofi; in compenso si chiede il “come” accadano i fenomeni e quali siano i rapporti che legano tra loro le microscopiche tesserine di cui è formato il mondo delle percezioni.
Sapevo già dai banchi di scuola dell’esistenza delle due strade; le ritenevo inconciliabili, o quanto meno avevo inteso dei falliti tentativi svoltisi a piú riprese nel corso delle epoche, di convergerle una verso l’altra, mediante una sintesi concettuale.
Ogni sforzo tuttavia era sfociato nell’inconsistenza; dalla Divina Commedia dell’Alighieri al Capitale di Marx, spiccava un vuoto che l’uomo di allora non era riuscito a colmare, e che quello odierno s’illude di poterlo fare mediante cibernetica, informatica e altri marchingegni del genere.

Oggi siamo in grado di chiederci: è possibile la vita nell’universo? E siamo altrettanto in grado di risponderci: se questa che viviamo è vita, certamente sí. Si potrebbe passare allora alla seconda domanda: è probabile che tale vita si sia creata da sola attraverso innumerevoli tentativi uno piú casuale dell’altro, oppure è maggiormente probabile che vi sia stata all’inizio un’idea originaria, la quale si sia poi attuata nello spazio e nel tempo, considerando le due dimensioni conseguenze dirette del medesimo principio?
Il che ci porta difilato a un terzo interrogativo: se la vita si è resa possibile, e se esiste la probabilità che essa possa venir indagata da una coscienza umana pensante (ricordiamoci di aver risposto affermativamente a entrambe le questioni, altrimenti non saremmo qui), allora ne deriva che c’è un numero di probabilità ancora piú determinante per cui tale coscienza umana sia sorta in virtú dello stesso principio dal quale l’idea primigenia è scaturita.
Come avremmo potuto incontrare il mondo e acquisire la conoscenza di tutto ciò che esso contiene se non avessimo avuto già in noi, per lo meno in piccola parte, lo stesso motore che lo ha voluto tale? Se non fosse cosí, tutte le nostre conoscenze, di qualunque settore siano, sarebbero non soltanto infondate, ma inutili, vane, inapplicabili ad alcuna realtà.
Solo se mi convinco della possibilità del rapporto Creatore-Creato-Creatura, ogni teorema, ogni teoria, ogni prospettiva acquista in seguito la probabilità di valere e mi apre le porte ad una filiera di innumerevoli ulteriori congetture.
E se poi, in quanto uomo, mi sento in grado di farlo, questo è perché un quid di quel primissimo rapporto, vive tutt’oggi in me; mi rende capace di proseguire nel suo intento, ovviamente con le debite proporzioni in cui mi ritrovo, e con l’indispensabile appoggio della mia libera volontà.

Come i libri vengono scritti pensando ad un pubblico di lettori, come le rappresentazioni teatrali o cinematografiche si fanno sapendo che ci sarà una massa di spettatori a vederle ed a apprezzarle; come un musicista comporrà una melodia, o un poeta scriverà dei versi dedicandoli a chi gli ha ridestato l’ardore piú intimo e segreto: non diversamente, universo, stelle, pianeti e terra sono stati creati da Qualcuno che contestualmente ad essi ne ha progettato anche i futuri conoscitori.
Ma questi conoscitori, per esserlo a pieno diritto, avrebbero dapprima dovuto cimentarsi con la sciagura della perdita del rapporto; trovarsi soli, abbandonati, cacciati fuori da ogni forma di certezza; per poter lentamente, molto lentamente, ritrovare la via a quella conoscenza e a quell’amore di cui avevano bisogno per recuperare in se stessi il senso latente di un destino smarrito, capace tuttavia di realizzarsi in un atto di libertà, nel quale, in giusta dose, umiltà e gratitudine confluissero a sostenere l’esperito, trasformandolo in una sublimazione tanto inattesa quanto impronosticabile. Nemmeno la cosa piú gradevole soddisfa appieno l’incontentabilità degli uomini; anche la sorpresa gioiosa di un portento, col tempo svanisce all’orizzonte dell’oblio, ed è giusto cosí; perché una cosa è la ricerca della felicità nell’esistere, un’altra è la ricerca della vita nell’essere.
Se poi riuscissimo a capire che il concetto di quanto siamo, acquisisce un significato determinante solo progredendo nel conoscere, allora la sete di sapere che ci caratterizza potrà sfociare in autentica volontà conoscitiva. In essa il pensiero, che incessantemente la struttura, si dirige con nitida visione a quella che oramai intuisce – almeno per via astratta – la sorgente originaria.
Ogni nostra ricerca che non tenga in piena evidenza un tale riferimento, è destinata a naufragare, dopo essersi a lungo aggirata nell’errore, nella presunzione e nella decadenza, e ad aver inoltre arrecato confusione e fraintendimento all’ intera collettività.
Giunti a questo punto, comincia a delinearsi una panoramica completamente nuova, che prescinde dalle ponderazioni a tavolino, dalle meditazioni salottiere e dalle speculazioni fantasmagoriche della paranormalità; si tratta qui di cogliere in via intuitiva come tutto ciò che ci riguarda, direttamente e indirettamente, può venire da noi stessi reinterpretato alla luce di quella spinta evolutiva che normalmente sprechiamo ogni giorno, per sbrigare mille incombenze, le quali – prive di tale reinterpretazione – continueranno a rimanere senza un senso compiuto e peseranno sull’umano come un tragico fardello, enigmatico e malsopportabile.
Il nocciolo del problema non è piú se qualcosa sia possibile o impossibile, probabile o improbabile; il problema che ci sta davanti è se vogliamo o non vogliamo concedere alla capacità di conoscenza umana il rispetto e la considerazione che si merita, dal momento che ad essa dobbiamo rivolgere la nostra gratitudine se non abitiamo ancora le caverne e abbiamo in qualche modo imparato a destreggiarci negli imprevisti naturali.
Il rispetto e l’amore per la conoscenza ci introducono a un ulteriore avanzamento: viene posta in rilievo l’essenziale importanza del pensiero, e da qui può iniziarsi un processo interiore di autodeterminazione atto a svelarci qualcosa che mai e poi mai avremmo potuto prendere seriamente in considerazione durante il percorso svolto, anche se tuttavia (ora possiamo ammetterlo) un numero sempre maggiore di concause, strada facendo, andava suggerendolo: la sacralità della sua essenza.

10.000 giapponesi cantano l’Inno alla Gioia
https://www.youtube.com/watch?v=X6s6YKlTpfw
La mia volontà di uomo ha le sue radici nella forza; i miei sentimenti umani hanno le radici nell’amore; ma io me ne sento sconnesso, non so volere né amare al pieno delle mie possibilità. Per ritrovare tali correnti di vita, per sentirle vibrare in me, devo venir scosso dal profondo, magari rileggendo Tagore o ascoltando per l’ennesima volta l’Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven. Sono palliativi estemporanei, ma mi informano sulla presenza di alcune facoltà sopite.
Coltivando il pensare secondo gli insegnamenti dei Maestri dello Spirito, i risultati, secondo il mio punto di vista, sono difficili da ottenere, ma la loro efficacia è indiscutibile. Essa tende a durare nel tempo, non si comporta da palliativo. Potrà affievolirsi, ma il ricordo del momento in cui la coscienza si è ridestata dal proprio torpore, non si estingue mai. Saper rievocare quei momenti dipende dal nostro volerlo fare.
L’illusione ci culla coi sogni dell’impossibile, la parvenza del reale ci fa ammirare il caleidoscopio magico delle probabilità; ma la coscienza che si risveglia porta all’esperienza della Redenzione; questo è un dato di fatto. Ogni prospettiva interiore ed esteriore viene trasformata, s’incomincia a familiarizzare col concetto di non aver piú bisogno di una “realtà di fuori” da contrapporre ad una “realtà di dentro”; un’unica verità si presenta, di cui entrambe vengono sovrastate e sostenute. Il soggetto – che ciascuno virtualmente è – si rende conto di esserlo grazie all’oggetto che gli ha dato modo di portare a compimento il percorso di maturazione.
È un rapporto misterioso quello che s’instaura tra il soggetto conoscente e l’esperienza percettiva; il pensiero, attivato, formula domande e si dà continue risposte. In ciò, l’oggetto percepito concede, fino ad un certo punto, informazioni di sé. Lentamente fa mostra di svelarsi: in sostanza, alle serie percettive si assommano quelle delle immagini mentali, delle rappresentazioni, le quali devono per forza apparirci dapprima sotto forma di ulteriori percezioni. È una via insidiosa, può spingerci nella immensità del vuoto, ove la nostra enfasi di conoscitori/ricercatori non farà altro che annientarsi per dispersione; oppure, portarci in un micromondo subatomico, in cui le regole non rispettano per nulla quanto abbiamo imparato e reso sin qui confortevole se non abituale.

La fuga nel futuro sta alla pari col rifugiarsi nel passato; servono soltanto a farci dimenticare l’attimo presente e quel che possiamo fare perché questo attimo si trasformi in un incontro conoscitivo fecondo, grazie ad una costante e progressiva maturazione interiore.
È necessario distinguere il possibile dall’impossibile, come è altrettanto importante separare il probabile dall’improbabile, tuttavia nei momenti in cui si crea un salto di qualità nello sviluppo della coscienza, quando il mondo compare rinnovato alla luce dell’Autocoscienza, le distinzioni di cui sopra perdono la loro ragione d’essere.
Prima dell’autocoscienza i testi dell’Antroposofia possono apparire complicati o addirittura ermetici; ma dopo l’Autocoscienza, essi diventano nitidi, perfettamente intelligibili. È un passaggio, un grado di risveglio come ce ne sono sempre in ogni periodo della vita terrena; per tutti gli uomini vedere la natura è una possibilità talmente ovvia che pare non meriti una presa di posizione particolare; ma quelli che nella natura riescono a vedere lo Spirito cristallizzato, la creazione stessa bloccata in attesa di un atto conoscitivo veramente capace di proseguire il corso, fanno l’esperienza della probabilità nell’esito positivo: riconoscono nel drammatico gioco del probabile/improbabile la tensione necessaria all’evoluzione dell’intera specie umana. Le turbative, lo scontro, le contrapposizioni anche cruente, per adesso servono ancora ad alimentare la dinamica di una spinta propulsiva che ci vede in parte consapevoli, in parte responsabili, in parte estranei per rifiuto e ignoranza.
Ciò non toglie che, nel suo complesso, il lavorío d’amalgama e di distillazione, anche attraverso vie strane e contraddittorie, continui la sua opera. La nostra partecipazione è sempre possibile, la nostra partecipazione cosciente diventerà sempre piú probabile.

Pochi giorni fa, durante una conversazione telefonica, una gentile amica mi ha letto una breve poesia di Pablo Neruda, a me del tutto sconosciuta; la ritengo estremamente importante ai fini delle riflessioni trattate: «Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno».
Adesso sarà facile notare che la prima parte della poesia riferisce a una data “possibilità” (siamo tutti certi d’essere nati!) mentre la seconda è dedita alla “probabilità” di una evenienza. (“rinascere… Ogni giorno”). Che mai avrà voluto dire il poeta?
Forse tra la sicurezza del possibile e l’eventualismo del probabile, c’è di mezzo un esistere che vale la pena di venir vissuto?
Seguiamo la progressione: anima, salto di qualità; coscienza, salto di qualità; autocoscienza, salto di qualità; redenzione, ed ora un ulteriore passo in avanti: la “rinascita”. È l’importante conquista di chi ha deciso di non lasciarsi dominare dagli eventi del mondo, ma di incontrarli con vigile cura e con amorosa attenzione; di verificarli sul banco di prova della vita secondo una personale investigazione tanto spirituale quanto scientifica, alla quale sa di essere chiamato; lo sa perché consapevole d’averne avuto, oltre al ruolo di protagonista, anche quello della regia.

Solo cosí, solo da questa particolare rinascita in poi, l’anima si rivolgerà all’Autore d’ogni cosa creata e Lo ringrazierà veramente per la grande occasione accordata; essa continua a scorrere come la sabbia nella clessidra, in attesa dell’evento decisivo: che lui soltanto può suscitare, svelando a se stesso il retroscena: che è morire nel fisico per svegliarsi nello Spirito.
L’intero ciclo delle vite terrene non avrebbe senso se non quello d’una lunga preparazione a compiere il Grande Passaggio benedicendolo con il crisma della propria adesione cosciente.
In fondo, se si vuole, anche questa può venir considerata un semplice presa di responsabilità come tante altre; nella fattispecie tuttavia, è impossibile non veder sbocciare il fiore della ri-conoscenza, che la rende unica, insuperabile, diversa in modo netto da ogni esperienza interiore precedente.
Mi sono lasciato trasportare dall’esultanza, il che non è mai un bene anche se indirizzato a mete venerabili. Per cui torno con i piedi a terra e a tal proposito svolgo una riflessione molto semplice (anche se ci ho messo del tempo per completarla) ed è stata utile in parecchie circostanze.
Nell’area delle persone che dalla sponda opposta vengono genericamente indicate, ora come materialisti, ora come atei, o miscredenti, oppure accusati di anti-creazionismo, comunque rifiutanti in toto ogni spiritualità, serpeggia (pare il caso di dirlo) un dogma: presumere cioè che non esiste alcuna evoluzione, né del corpo né dell’intelletto; ché dello Spirito non se ne parla neppure. La vita, secondo costoro, va avanti a cicli ripetitivi, mutando solamente gli aspetti esteriori piú appariscenti, che mantengono intatto e consecutivo il canovaccio storico: il copione si rinnova attraversando secoli e millenni, al punto che, giunto al capolinea naturale, ricomincia ab initio, senza che alcuna coscienza terrena sia in grado di accorgersene.

In pratica tali seguaci hanno scoperto, senza saperlo, il “motus perpetuus”; seppure nessuno, cosí dice il proverbio, abbia il diritto di atteggiarsi a profeta in patria, per contro, a nessun patriota è mai riuscito di profetare bene all’estero; un detrattore dello Spirito infatti non trae vantaggi dal dissertare sull’eternità; purtroppo per lui, il moto perpetuo è una derivazione di questa, anche se ridotta ad un dialettismo risicato.
A siffatti signori si potrebbe proporre una teoria di questo tipo: l’acquisire conoscenza rende impossibile restare fermi al grado di sviluppo antecedente; un bimbo che frequenta la scuola, un lavoratore che va all’estero, uno scapolo che mette su casa e famiglia, un cambio di lavoro, uno spostamento di residenza, ma anche un semplice raffreddore, o la vicinanza di qualche persona, sono sufficienti a cambiare radicalmente la vita.
O, per dirla meglio, possono modificare il modo soggettivo di vedere la vita. Quindi avere delle esperienze, a parte l’importanza intrinseca di queste, è un vero e proprio catalizzatore che ci conduce a considerazioni nuove, che diversamente non avremmo svolto.
Se prima di una acquisizione conoscitiva mi trovavo allo stadio X, dopo sarò certamente passato allo stadio di X+1; e il me-stesso-soggetto X+1 non vedrà piú il mondo come lo vedeva quando era nella fase X, bensí lo vedrà modificato, diverso; qualcosa (magari piccolissima, al momento forse irrilevante) si è aggiunta; e tutto si espande, diventa di piú ampio respiro.
Immaginiamo adesso di estendere il ragionamento prendendo in considerazione non un singolo soggetto conoscitore, ma l’umanità intera, quale aspiratrice al conoscere; è evidente che ad ogni variante, ad ogni esperienza collettiva, ad ogni atto cognitivo eseguito, corrisponderà il manifestarsi di un mondo nuovo in cui vivere, e parimenti, una nuova forma dell’esistere che in qualche modo si conformerà ad essa.
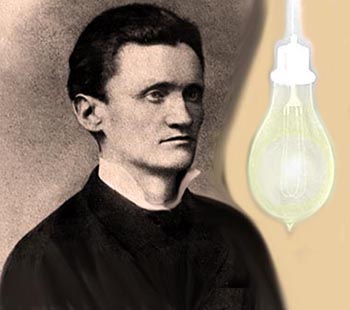
Alessandro Cruto – Inventore della lampadina elettrica
Basti pensare al modello dell’universo di Tolomeo, per passare poi a quello di Galilei, di Copernico e di Keplero. Oppure porgere attenzione a come andava la società mondiale prima e dopo la scoperta dell’America o l’invenzione della luce elettrica. Sarebbe però un’autentica perdita di tempo, dal momento che abbiamo stabilito fin dalla partenza che perfino lo starnuto d’uno scimpanzé introduce nella realtà quotidiana una spinta di rinnovo capace di ampliarsi e riprodursi propagandosi per ogni dove attraverso tempi e distanze.
Risultato? Di fronte ad una serie di riflessioni cosí impostate, il nostro laico-ateo-materialista-agnostico-miscredente, che ha fin qui contestato e respinto ogni assunto evoluzionistico, viene a sbattere contro una questione che gli sorge davanti, grande come una montagna invalicabile: noi stiamo andando avanti; tutti, sempre; sia che ce ne accorgiamo, sia che non lo sappiamo, sia che non lo vogliamo sapere. Ma perché stiamo andando? E verso dove?

Basteranno poche esemplificazioni (che devono essere assolutamente lasciate alla libertà di quanti vogliano davvero ragionarci sopra) per arrivare ad una conclusione, per gli obiettori della spiritualità, esattamente opposta a quella da cui erano partiti: l’evoluzione dell’uomo, da un certo punto in poi, passa sotto la sua decisione di autorettifica; non basta crescere, svilupparsi per poi declinare e morire; il tempo offerto dalla vita va investito nel tentativo di migliorare se stessi in senso qualitativo; l’elemento etico non solo si affianca a quello pragmatico della storia e delle condizioni esistenziali; esse hanno il compito di offrire il necessario palcoscenico sul quale svolgere l’operazione di bonifica interiore, ma è quest’ultima che si rivela nel lungo termine essenziale ai fini di dare alla nostra vita un senso compiuto.
La prima parte dell’evoluzione umana – quella caratterizzata dalla necessità – è una risposta all’interrogativo se mai la vita si fosse resa possibile nel modo in cui in effetti sorse; la seconda parte, riguarda invece una probabilità: che tra gli esseri pensanti e coscienti, si sviluppi la libertà di raccogliere in uno sforzo comune tutti i dati acquisiti attraverso scienza ed esperienza, al punto tale da poterli convogliarli in un significato che – lo si scoprirà dopo – l’anima da tempo aveva fatto suo.
Se l’uomo sarà capace di far vivere la propria anima, con la forza e con la vita interiore cui essa aspira da sempre, allora mondo, universo e cosmo avranno ancora un futuro che ci vedrà possibili protagonisti comprimari. Altrimenti si farà strada la probabilità di non esserlo mai stati.
Angelo Lombroni