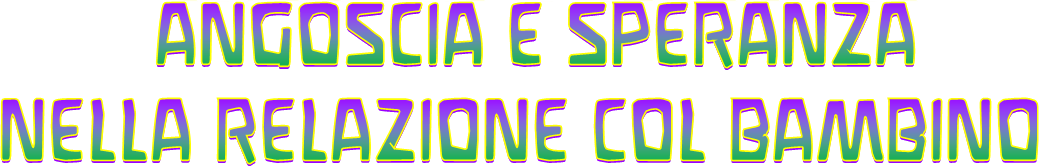Dobbiamo renderci conto del pericolo che minaccia la nostra coscienza, un pericolo che è causato dalle circostanze attuali e che si esprime in una estraneità crescente e sempre piú profonda fra il mondo degli adulti e quello infantile. Se oggi «dobbiamo compiere una vera e propria opera di salvataggio verso ogni bambino» (Rudolf Steiner, O.O. N° 296), ciò dipende dal profondo spavento che le anime infantili provano di fronte a una cultura che si chiude alla corrente che proviene dalle sorgenti dell’infanzia.
Henning Köhler, Non esistono bambini “difficili”,
Natura e Cultura Editrice.
Occorre porre il tema dell’angoscia a fondamento della riflessione pedagogica, giacché essa, al pari di un gas, sembra aver avvolto in modo pressoché inavvertito la nostra contemporaneità effondendo nel nostro cosmo percettivo diffidenza e sgomento.
Sperimentare angoscia vuol dire confrontarsi con la dimensione spirituale o ideale, se preferite, poiché il suo contenuto non si riscontra in una serie di rappresentazioni fisiche. Dov’è l’angoscia? L’angoscia non ci pone di fronte alla reattività relativa ad un pericolo immediato, come nel caso della paura, né ci pone di fronte all’aspettativa di un evento supposto come pericoloso, come di norma avviene per l’ansia.
Chi prova angoscia sa di non avere una causa oggettiva a cui imputare la propria emozione. E se allora la causa non c’è, vuol dire che si teme il nulla, il vuoto. Come proverò a dimostrare, nell’angoscia l’essere e il nulla sono termini coincidenti. Tertium non datur: non esiste una terza possibilità. Il cardine della riflessione è da ricercarsi al di sopra delle parti. E comunque il fatto che io provi angoscia mi rende possibile la riflessione su un argomento ideale, spirituale. Come è possibile che il nulla si imponga alla mia coscienza? Come è possibile che il vuoto mi nuoccia?

La “discesa infinita” di Van Gogh
Quando parliamo di stati di paura, di vergogna, di ansietà, di angoscia… spesso descriviamo le percezioni ad esse associate con espressioni del tipo: «Avrei voluto sprofondare», «Sono giú di corda» (dove per corda occorre intendere il cuore, cor-cordis, e non la fune o le corde del violino), «Ho come un peso sul cuore», «Sto con la faccia per terra», «Vedo tutto nero»…
I filosofi dal canto loro parlano di vertigine, di abisso o di caduta, quando affrontano il concetto dell’angoscia. Vincent Van Gogh chiamava la sua travagliata vita “la discesa infinita”. Si scende e si avverte un peso: si innesta, per cosí dire, un meccanismo di plumbea inerzialità che ci fa avvertire la nostra pesantezza e che ci tira giú in una regione oscura, priva quindi di luce.
«So di essere un peso per voi», «È come un peso morto»… insomma gli esempi non mancano e tutti sembrano riportarci al peso, all’inerzialità, alla caduta, alla vertigine e all’oscurità.

Altra immagine della depressività è il deserto: il luogo privilegiato della spersonificazione. Gli anacoreti andavano nel deserto per spogliarsi di sé ed incontrare un dio. Vi incontravano, però innanzitutto il miraggio, il demonio: l’Ostacolatore. Comparando le storie dei mistici potremmo dire che se vai nel deserto per praticare una forma di ascesi e incontri subito la divinità, allora c’è qualcosa che non va: allora l’Ostacolatore te l’ha fatta. Ti ha fatto credere che bastasse rimanere con i piedi sulla sabbia per un po’, per raggiungere uno stato di elevazione spirituale, di miglioramento: ma dov’è il confronto con la Terra?
È un po’ ciò che accade oggi con quelli che possiamo definire i materialisti dello spirito: basta accendere un incenso per volare negli ultramondi (un certo tipo di spiritualista può non essere dissimile dal materialista, se cerca l’oggetto della propria fede rinnegando o trascurando la ricerca del soggetto, dell’Io che cerca e pensa). Ma non è quello che fanno anche i giovani quando, per liberarsi dal giogo della relazione con la terra, fumano uno spinello?
È solo dopo questo superamento che si apre l’abisso, il baratro: è solo dopo aver riconosciuto il miraggio, che il deserto ci appare come tale e finalmente sprofondiamo nell’angoscia.
Ho usato l’avverbio finalmente in modo volutamente provocatorio, ma vedete, per prendere in mano il proprio destino occorre innanzitutto strapparsi all’illusorietà del “va tutto bene” o peggio dell’“andrà tutto bene” – come si dice oggi – che è proprio l’immagine scimmiesca e caricaturale dell’angoscia. Mentre l’ansia ravvisa un pericolo non definito in un tempo collocato di là da quello presente, la società, dicendo “andrà tutto bene”, suggerisce un dinamismo del bene verso la corrente del tempo futuro, non si sa partendo da quali presupposti. Ma questo bene dinamico, questo trapasso di un bene presente in un bene futuro invero non c’è: se il bene futuro non origina da una perennità del bene, esso non c’è, e dunque non rappresenta neppure la possibilità di una manifestazione, bensí l’evidenza di un’allucinazione: crediamo di poter trovar la luce dove la luce non c’è, e dunque ci troviamo nella descrizione di una percezione senza oggetto: uno stato allucinatorio, appunto.
Questa è angoscia: un pensiero del genere crea e distribuisce angoscia. L’angoscia dice: mettiamo le tenebre o il nulla dove questi concetti non sono logicamente ammissibili; mentre il pensiero dell’andrà tutto bene dice: mettiamo la luce, la pienezza, dove luce e pienezza non saranno logicamente ammissibili. Il problema è questo: questo genera angoscia. Quando si chiede ad un angosciato: «Cos’è che ti angustia?» la risposta piú plausibile sarà: «Non lo so». Di fronte a un plenum di nulla o a un vacuum di pienezza ci ritroviamo comunque a sperimentare angoscia. Siamo sull’orlo del precipizio. Oggi di fronte alla società dei consumi, a una società che consuma se stessa, che estingue se stessa, arriviamo a sperimentare il nulla nella pienezza. Sembrerebbe una sorta di esercizio ascetico, ma è una sensazione comune a molti. Ed è per questo che l’angoscia continuerà in futuro a proliferare.
La presente discussione sul concetto di angoscia, come vedete, non ha un carattere medico o psicologico ma un orientamento filosofico.
L’angoscia storicamente ci fa sprofondare nelle tenebre e nel vuoto, ma oggi, dicevamo, sprofondiamo nella luce, nella pienezza, nell’opulenza. Parlo di luce, forse dovrei parlare – parafrasando Dionigi l’Areopagita – di Luce Supertenebrosa – poiché questa luce che rivela la nostra quotidianità ha una natura tenebrosa. La luce della coscienza, il lume della ragione… possono essere offuscati, ma il soggetto percipiente non può saperlo se non sopravanza se stesso. Se mi preparo, se mi educo al viaggio nel deserto, invece potrò dire: «Ehi, quello dev’essere un miraggio!».
Un ragazzo di una scuola media, Giacomo, ha scritto questo pensiero, che cito a memoria:
Non si passa il vicolo buio ad occhi chiusi.
E anche se non cambia niente fra aperti o chiusi,
la certezza di poter vedere è sempre un gran vantaggio.
Oggi l’angoscia abbaglia piú che rabbuiare. Siamo abbagliati dall’idea che “sano” voglia significare “esente da malattia”. Ma se ci precludiamo la possibilità di ammalare, allora dobbiamo precluderci l’idea di guarire, di divenire. Come si può avere una relazione con il futuro, con il diveniente, se non divenendo? Muori e divieni dice Goethe, ma come si fa se fermiamo l’istante, se tutto va sempre bene?
Un pensiero attribuito, forse, a Seneca, recita: «Chi dunque guarirà coloro che si ritengono sani?». Ho scritto forse, perché non ho trovato la fonte della citazione. È comunque un pensiero determinante in questo periodo storico, e tutti dovremmo perlomeno guarire dalla ferita originaria che è la separazione dal tutto, dalla perdita dell’innocenza, dall’uscita da quel sacro territorio che è l’infanzia. La ferita, la separazione da uno stato fusionale con il tutto prodotta dall’acquisizione della coscienza – pensiamo ai bambini che ci vengono affidati, pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti… – può essere guarita solo dalla coscienza stessa. È un paradosso ma nel Parsifal la ferita che affligge Amfortas è guarita dalla stessa lancia che la produce.
La cultura italiana ha un gran debito con Giovanni Pascoli, poiché ci ha anticipato i temi di riflessione sul Puer proposti dall’universo della psicanalisi. Ma quando parla un poeta è come se si esprimesse l’universo. La scuola attuale ci ha fatto disdegnare questa figura, mentre Giovanni Pascoli andrebbe ringraziato. L’avversione preconcetta è del resto il tocco finale di un insegnamento miserrimo.
Ma come facciamo a riunirci con il tutto? Ricordo un comico il cui motto era: «Vojo torna’ bambino!». Un pensiero che rivela una disposizione caricaturale, puerile: che bella è l’età in cui venivo accudito, in cui c’era la mamma e se cadevo mi dava un bacino…
L’idea di infanzia, invece, è una faccenda da giganti. Siamo abituati a vedere i nostri bambini come degli gnometti, dei piccolini, e invece faremmo meglio a considerarli, almeno quando ci riuniamo per parlare di loro, come dei giganti. Gli impulsi che portano sulla Terra, sono gli impulsi con cui la Terra stessa evolve. Janusz Korczack – il celebre pedagogista polacco – quando parla dei bambini invita spesso a non considerarli come dei “piccoletti”. Ci dobbiamo inchinare per accudirli ma non per metterci al loro livello quanto piuttosto per meritare di essere all’altezza dei loro sentimenti.

Siamo giunti allora nel vicolo buio, sull’orlo del precipizio, siamo nel deserto quando il sole è allo zenit. Ed ecco arrivare l’angoscia che Kierkegaard chiama: vertigine della libertà. L’angoscia è l’immagine della soglia, di un confine: di certo un confine tra il mondo dei sensi e quello spirituale. Se non vi piace questo aggettivo, lo ripeto, sostituitelo con ideale, tanto la sostanza non cambia. È solo dopo aver superato il miraggio, la tentazione, che il deserto si mostra davvero per quello che è. Il miraggio è uno specchio di noi stessi, la tentazione riflette noi stessi. Dopo questo superamento, finalmente ci appare la vastità dell’essere.

Quando si leggono libri di viaggio – mi sovviene Nelle terre estreme, di Jon Krakauer – arriva sempre un momento in cui il protagonista rimprovera se stesso. “Avrei fatto meglio a starmene a casa”, “Ma chi me l’ha fatto fare”… “Come ho potuto pensare di pormi in questa condizione in cui mi trovo faccia a faccia con la realtà straordinaria e mostruosa della natura?”. Ecco l’angoscia. Si vorrebbe tornare indietro, alcuni lo fanno, altri no: per questo l’angoscia è una soglia.
L’angoscia segna un passaggio di soglia, un trapasso con il divenire, con la corrente del futuro. L’angoscia ha una funzione benefica quando sopravanziamo noi stessi, quando siamo pronti per trapassare nel divenire, divenendo a nostra volta. È il Muori e divieni di Goethe, altrimenti basterebbe morire soltanto. La condizione del lentamente muore – come direbbe Neruda – è molto comune al giorno d’oggi.
Chi lentamente muore, smette di divenire: espressioni come “è un modo per ammazzare il tempo”, “è un passatempo”, “è un modo per ingannare il tempo”, rivelano questo rapporto tendenzioso con il proprio essere piuttosto che con l’arcano del tempo. Mai come in questo periodo, ad esempio, l’utilizzo dello smartphone è divenuto un modo per ammazzare il tempo, un passatempo. Se vediamo passare il tempo è perché il nostro Io smette di divenire e s’arresta. Ma il tempo mai s’arresta ad attendere l’uomo. Tornano allora nuovamente vivi i pensieri di Seneca: Ducunt volentem fata, nolentem trahunt (Il fato conduce colui che vuole lasciarsi guidare, trascina colui che non vuole). Ecco che di fronte alla Soglia, l’angoscia diventa speranza per chi fluisce con il divenire, o paura paralizzante in chi si illude di poterlo “ammazzare”.
Potremmo chiudere qui perché generalmente l’angoscia è associata a questa paura indeterminata ma somatizzata: “sto male e non so perché”. Allora basta prendere un medicinale e, come si dice: “Passa la paura”. Certo è cosí, però c’è anche dell’altro.
Vi è un punto in cui la gravità può essere invertita, in cui veniamo richiamati da un altro centro di gravità. Qui non ci supporta piú il comune linguaggio ma ci viene incontro quello dell’arte, ed in special modo il linguaggio della musica.
Leibniz si riferiva alla musica definendola: “exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi” (inconsapevole pratica di aritmetica, nella quale l’animo non si accorge di adoperare numeri). Schopenauer parafrasò questo pensiero in: “Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi” (La musica è un’inconsapevole pratica di metafisica nella quale l’animo non si accorge di fare filosofia).
Confortati e incoraggiati da queste premesse osiamo allora addentrarci brevemente nel campo della musica, cercando di fluire con essa, di afferrare quello che attraverso essa, ci si rivela musicalmente.
Vi è una sonata di Beethoven, la sonata per pianoforte in do minore n° 32 op.111 che descrive questo viaggio. Occorrerebbe ascoltare la sonata ed analizzarla provando a coglierne i colori, le atmosfere, le linee di forza (quali sono le sue direzioni, muove verso il basso, verso l’alto?).

“La caduta verso l’alto” (Sturz nach oben) Ludwig van Beethoven, Sonata op. 111, secondo movimento, battuta 98
Io ho vissuto per anni nell’atmosfera di questa sonata. Da ragazzi alcune musiche – ero uno studente di Conservatorio – divenivano il nostro pane quotidiano, la nostra condivisione. Non potevamo parlare di una musica cosí come si fa di un libro, eppure i contenuti musicali silenziosamente condivisi, ci plasmavano, modellavano le nostre anime. Passavamo mesi a sentire gli amici studiare determinate opere, a ripeterne i passaggi piú difficili. L’attività di studio dei colleghi agiva sulle nostre interiorità come se esse fossero la sostanza plasmata dallo scultore.
Nel secondo movimento, qualcosa cattura l’attenzione dell’ascoltatore. Secondo i musicologi, Beethoven era in vena di sperimentazioni, ed allora si lanciò nella composizione di un secondo movimento basato su delle variazioni culminanti in una sorta di boogie woogie primordiale.
In realtà questo movimento ritmico frenetico prelude a un’inversione del centro gravitazionale. La sonata op.111 è una porta magica: ci porta ad attraversare l’universo e ad orientarci verso un nuovo centro. È quello che succede superata la soglia dell’angoscia. Siamo chiamati a divenire, ad abbandonare il vecchio polo gravitazionale. Beethoven esprime attraverso quella frenesia ritmica le doglie preludenti alla imminente nascita.
La speranza nasce dall’angoscia. L’indeterminatezza oggettiva dell’angoscia è come una domanda lanciata in qualche angolo di spazio del tempo futuro.
Per lo scrittore e giornalista Massimo Fini: «Il futuro è solo una rappresentazione della mente: è un tempo inesistente». C’è molto di vero in questo, eppure l’angoscia è la vertigine della libertà, poiché essa ci permette di varcare una soglia dove l’inesistente tempo futuro ci viene per cosí dire incontro, divenendo spazio. «Qui il tempo diventa spazio» recita Gurnemanz nel I Atto del Parsifal di Richard Wagner, prima dell’apparizione del Santo Graal.
Il tempo adesso schiude la serie di possibilità che sono offerte all’uomo e che egli non vedeva.
La speranza è il trapasso del bene futuro entro il bene presente.
Non potrei aggiungere altro. Questa Sonata è il testamento spirituale di Beethoven. Se qualcuno dovesse chiedermi cos’è la speranza, come si raggiunge, cosa implica, gli direi di ascoltare la sonata op. 111 di Beethoven e di lasciare alla musica il compito di rivelare ciò che il linguaggio non può esprimere. Le parole ci conducono dinanzi al mistero ma non sono il mistero. L’euritmia aiuterebbe certamente a veicolare i possenti contenuti di questo testamento spirituale e a tradurli in una cura per l’anima.
Per comprendere, invece, come la speranza sia non un atteggiamento devozionale ma una forza trasmutatrice che opera attivamente nell’anima, sarebbe opportuno ascoltare e meditare l’Introduzione all’Oratorio op. 85, “Cristo sul Monte degli Ulivi”, sempre di Ludwig van Beethoven. È qui che Beethoven getta squarci di grazia sul tumulto emotivo vissuto da Cristo nel Getsemani prima della sua crocifissione.

Allora Gesú andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. (Mt 26: 36-37).
Ci lasciamo con la domanda: da dove arriva quella grazia che Beethoven realizza nell’Introduzione? Perché è lí?
Per i giovani la risposta all’angoscia è il movimento. Il movimento nei giovani è speranza. Privare i giovani del movimento è gettare le basi per portarli a non superare la soglia dell’angoscia.
Nicola Gelo (1. continua)