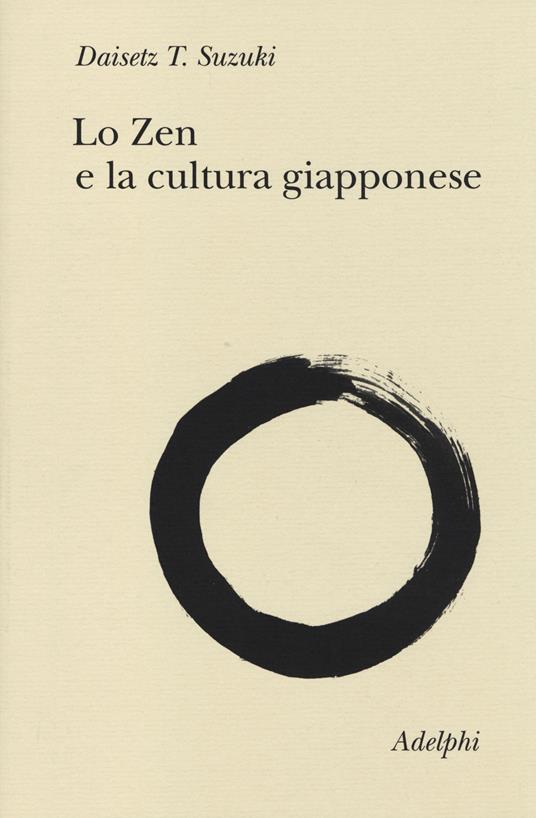
Tra le espressioni del Buddismo Mahāyānico, lo Zen, che può essere considerata la piú essenziale dal punto di vista metafisico, è inoltre quella che ha maggiormente promosso la cultura giapponese. Lo stile interiore che è proprio di quella forma di ascesi, è divenuto lo stile di vita e quindi di eroismo, come è dimostrato nell’arte della scherma, che prosperò soprattutto nel periodo Kamakura. Allo stesso tempo ha originato una visione particolarmente estetica della natura e dell’Universo. Ammirevoli e stupefacenti sono gli asceti in cui ci imbattiamo in quel periodo della storia giapponese in cui lo Zen fece maggiormente sentire la sua influenza: figure in cui si incontrano perfezione umana e spirituale, che mentre sono maestri di meditazione sono allo stesso tempo maestri di scherma, e poeti e pittori di alta qualità. Menzioniamo, ad esempio, Miyamoto Musashi del periodo Tokugawa, fondatore della Scuola nota come Nitōryū, che non fu solo un maestro del passato nell’arte della scherma ma anche un artista Sumiye e un poeta.
Il volume che stiamo recensendo è la seconda edizione, riveduta e ampliata, del lavoro scritto dall’Autore con il titolo Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture, pubblicato nel 1938 dalla Società buddista orientale dell’Università buddista Otani di Kyoto. Per anni Daisetz Teitaro Suzuki è stato l’esponente piú autorevole e rigoroso degli insegnamenti dello Zen. L’eccellenza del suo lavoro dipende soprattutto dalla delicatezza e dalla maniera artistica con la quale egli affronta un tema essenzialmente non dialettico, super-razionale, che non può essere confinato entro limiti intellettualistici.

Daisetz Teitarō Suzuki
È evidente che Suzuki può parlare di Zen in quanto egli mantiene intatti i suoi requisiti non dialettici. Per interpretare lo Zen bisogna condividere lo spirito del dhyāna stesso, a condizione, per cosí dire, che l’esposizione sia in qualche modo una continuazione dell’atto della meditazione. E questa è l’impressione che si riceve ogni volta dalla lettura dei lavori di Suzuki sullo Zen: può parlarne perché, in sostanza, lo sperimenta.
Il suo non è soltanto un lavoro di studio; è soprattutto un’opera di penetrazione interiore del tema, che egli penetra perché lo vive.
Una delle caratteristiche principali dello Zen è che non trascura lo stile, anzi lo richiede. Poiché l’atto della meditazione è libero da ogni formalità, e dato che si svolge al di fuori di tutte le categorie naturali, possiede le stesse forze che hanno creato la natura; percorre di nuovo i sentieri attraverso i quali la natura è stata originariamente formata. Si può quindi dire che il mondo luminoso del Ganda–vyūha si risveglia nella meditazione e cerca di esprimersi nelle forme di un nuovo mondo, un mondo che è nuovo perché è quello originale. Da qui derivano le diverse forme in cui si esprime lo Zen: la maestria nel maneggiare la spada e la tradizione dei Samurai, la pittura di Sumiye e il tipico poema Haiku, l’“arte del tè” e il sentimento della “trasparenza della natura”, cosí che lo stile noto come sabi, o wabi, rivive costantemente.

Cerimonia del tè
Non è uno stile ma si presenta come tale: una legge interiore che non può essere insegnata ma sorge solo come lo stesso fiore della pura meditazione in coloro che sono capaci di contemplare l’universo come un grande Kōan vivente e che si rivolgono alle cose della vita quotidiana con la semplicità trascendentale che scaturisce dalla contemplazione di questo tipo.
Suzuki ci fa capire come il flusso dell’essenza dello Zen attraverso la vita e il suo sbocciare come espressione di una purezza identica a quella della creazione originale, abbiano plasmato non solo lo stile interiore della cultura giapponese dal XII secolo, ma anche parte dell’esperienza positiva della meditazione attraverso il lavoro di una grande famiglia di spiriti.
Perché lo Zen – osserva l’Autore – fa appello non alle idee ma agli atti, non al mondo delle astrazioni, ma a quello della volontà attiva, che è nella sua essenza la volontà non incarnata continuamente in cerca di un corpo.
Il senso dell’incondizionato e l’imperativo bisogno di libertà puramente metafisica sono il fulcro di tale formazione, che trova la sua espressione nella piú alta cultura di un popolo. Cosí, nel Lankāvatāra Sūtra si fa riferimento alla “verità della solitudine” (viviktadharma) come un’abitudine essenziale, ovvero la capacità di essere soli, per essere veramente uno con l’universo, veramente vicino all’Essere. Le nostre relazioni quotidiane con le cose che ci circondano sono illusorie. Le cose che sono veramente vicine a noi sono dentro di noi, e passano in noi attraverso la solitudine, attraverso l’esperienza del “vuoto”; è la continua richiesta del satori. La meta al di là di questa vita è sempre presente per l’uomo che medita o pratica il nembutsu, poiché la vita – come intuiva Platone tra gli occidentali – è la contemplazione della morte: la contemplazione dell’“ignoto” che è la vera realtà; un “invisibile” che diventerà visibile.
Secondo la pura tecnica del dhyāna, il pensiero, che fino a quando non si estingue non può cogliersi, è infatti in presenza dell’ignoto, ma di un ignoto che è l’obiettivo vivente dell’autentica vita del soggetto stesso, un inizio della conoscenza ma non ancora reale conoscenza o saggezza (prajnā). Perciò l’ignoto, invece di testimoniare con la sua presenza una realtà che trascende l’atto della meditazione, conferma l’impossibilità di arrivare a una visione del Buddha o dei Bodhisattva trascendendo questo atto, per mezzo, ad esempio, di una visione puramente religiosa, fideistica, dualistica.
L’ignoto esiste nella misura in cui è costantemente un limite che è superato nella contemplazione. E qui sta il segreto dello Zen: che l’“oltre” si realizza nell’essere, perché è il fondamento dell’essere: l’essere cui generalmente gli uomini guardano con timore e che è solo l’altro lato del ricamo di cui è intessuta la vita, la mancanza o la negazione di ciò che si sente essere la sostanza della vita. Ecco perché lo Zen non può essere confinato in un sistema, non può essere spiegato con un’analisi che porterebbe alla sua distruzione. La “via”, o lo “stile interiore” dello Zen, eliminando tutto ciò che condiziona la contemplazione – poiché il satori è la possibilità eternamente presente e il tathāgata dovrebbe essere identificato con l’atto stesso della contemplazione – integra la realtà dell’essere con l’atto vivente, in un atteggiamento identico a quello dello spirito che sta per creare. Restituendo cosí quella libertà metafisica che ogni formulazione intellettuale, anche se all’interno della corrente dello Zen, nel corso del tempo e con le alternanze storiche delle lezioni impartite, tende inevitabilmente a ritrarsi da essa, facendone un oggetto, una cosa, un’imagine.
L’asceta, ci insegna Hui-neng, quando è impegnato nell’atto autentico della conoscenza, non è piú uno specchio della verità, un’intelligenza condizionata dalle cose o dalle idee o dalle loro relazioni, ma è lui stesso il centro della creazione. Egli stesso è il principio creativo. Poi, volgendosi nuovamente all’esistenza, alla natura, alle cose, alle relazioni umane, egli stesso, basato sull’inazione, agisce come se nel mondo stesse agendo il tathāgata stesso. La legge del sabi – che non è nella sostanza una legge ma una tonalità interiore – ha le sue radici in questa esperienza trascendente. La sua intrinseca semplicità e la sua freschezza non sono regole o modalità, ma sorgono da una spontaneità metafisica che è il risultato di una continua liberazione dai condizionamenti.
Assorbito nei fondamenti, morto alle classificazioni umane, epperò in sé sorgente attingendo all’essenza misteriosa che è la fonte di ogni categoria, l’asceta si muove nel mondo, creando in esso relazioni che egli suscita ogni volta, plasmandole, perché il suo potere creativo è inesauribile. Tutto ciò che lo lega al mondo si deposita nelle profondità della sua natura; liberando la sua natura egli a sua volta si libera della natura affinché essa (la natura) ritorni a lui purificata e diventi per lui un aiuto, un’ispirazione.

Kami nagara no michi
Posando nel proprio sé interiore, e traendo da sé la forza della tranquillità originaria, balsamo inesauribile per risanare le ferite dell’esistenza, egli può portare avanti l’opera della natura ad ogni livello di vita, ripetendo, si potrebbe quasi dire, il processo della creazione. «C’è in ognuno di noi – scrive l’Autore – un desiderio di tornare a una forma di vita piú semplice, che includa modi piú semplici di esprimere i sentimenti e anche di acquisire conoscenza. La cosiddetta “via di Dio” lo indica. Benché io non sappia esattamente quale significato vogliano dare a questo termine i seguaci del Kami nagara no michi, mi sembra certo che con questo essi vogliano intendere di tornare indietro, o di conservare, o di far rivivere il modo nel quale gli Dei si suppone abbiano vissuto prima dell’arrivo dell’umanità. Quella era una via di libertà, naturalezza e spontaneità. Come ce ne siamo allontanati? Qui sta un grande problema religioso fondamentale. La sua soluzione dà la chiave per comprendere alcuni aspetti del Buddismo Zen e dell’amore giapponese per la Natura».
Ma non c’è dubbio che la spontaneità originaria, che era possibile in quanto non ostacolata da una coscienza razionalizzatrice, può rivivere solo a condizione che tale coscienza si estingua, pur mantenendo allo stesso tempo intatta la luce o l’autonomia che era stata accesa da quello stesso processo di razionalizzazione. Perché, se nella prima fase della sua formazione spirituale il ragionamento logico non portasse l’asceta ad andare verso lo Zen, come potrebbe sceglierlo? Come potrebbe comprenderne l’insegnamento? Come dice Shri Aurobindo, il pensiero è prima l’aiuto e poi diventa l’ostacolo. Ma è l’ostacolo sulla via di un puro elemento spirituale che si è acceso proprio grazie al pensiero stesso.
Il libro di Suzuki pone questi e altri problemi. In conclusione, esaminando l’influenza dello Zen sulla mente giapponese, ha sondato la questione dell’essenza dello Zen, un’esperienza interiore che lavora alla radice della “realtà” come una forza causale, e che quindi, se è veramente tale, non può che esprimersi come un modo di vita, come forma dello spirito. L’analisi è condotta con quella limpida disposizione dei soggetti che deriva da una conoscenza personale del loro nesso ideale.
Il volume è completato da preziose appendici: “Due mondō tratti dallo Hekigan-shū”, “Il sutra Vimalakīrti”, “Yamamba, un dramma Nō”, “La gatta e l’uomo di spada”, “Chuang-tzū”, una bibliografia aggiornata e un indice analitico. Il volume è illustrato con sessantotto tavole in collotipia.
Massimo Scaligero
Tradotto da: East and West, Settembre 1959, Vol. 10, No. 3.
Link all’articolo originale inglese: “Zen and japanese culture by Daisetz T. Suzuki“

