
Nilla Pizzi negli anni Cinquanta
Negli anni Cinquanta, se non ricordo male, andava in voga una canzoncina, cantata da Nilla Pizzi, il cui ritornello faceva cosí: «Tutto passa e si scorda, tutto deve finir…». A quel tempo, poco meno che ragazzino, non mi interessava molto il significato del testo. Ero tuttavia rimasto colpito dalla dolcezza malinconica della melodia che mi risuonava come una carezza rassegnata, una mestizia proveniente da un dolore, che dopo i primi eccessi, s’era dovuto in qualche modo acquietare e ricomporsi. Oggi capisco un po’ di piú; era un riferimento all’epoca particolare in cui veniva diffusa; poteva valere in senso positivo come in quello negativo.
La Seconda Guerra Mondiale era di fatti terminata da poco; i sopravvissuti (intendo non solo quelli rimasti illesi, ma anche quelli che non avevano subíto direttamente le pesanti perdite del conflitto) sentivano di poter guardare con fiducia all’avvenire. Allora nessuno sapeva cosa in seguito avrebbero significato le parole “ripresa e resilienza”; a quei tempi la spiegazione sarebbe stata troppo complessa e con la sigla del P.N.R.R. Totò ci sarebbe andato a nozze. Sapevamo comunque tutti che c’era molto da rifare, molto da ricostruire e, per chi pativa qualche rimpianto, ci sarebbe stata pure la necessità d’imparare a conviverci.
Dieci anni piú tardi, dai banchi del Liceo Petrarca di Trieste, apprendevo con viva curiosità il «Panta Rei» di Eraclito. Fin dall’inizio, le delucidazioni fornitemi dagli insegnanti e dai libri di studio in merito all’antico inciso non mi soddisfacevano. Eraclito mi aveva trasmesso delle aspettative, ed io non ero in grado di trovare i giusti riferimenti. Questo mi disturbava fino ad un certo punto. Anche perché se il problema, che mi si era appena creato, aveva provocato in me una piccola lacuna, ero consapevole di poter vivere benissimo e a lungo, senza riempirla. Cosí almeno speravo. Però il “buco” c’era, e nei momenti in cui l’avvertivo, provavo un fastidio particolare, come succede quando ci si accorge di aver trascurato una nota importante senza riuscire però a ricordare quale.
Dovevo attendere altri quindici anni. Arrivò la Scienza dello Spirito, arrivarono gli esercizi di concentrazione e di meditazione, gli incontri romani con Massimo Scaligero, con gli amici antroposofi della testa e con quelli del cuore; mentre mi aggiravo in mezzo a queste sollecitazioni, il mio Panta Rei sembrava ora dischiudersi quasi fosse sul punto di svelarmi un recondito messaggio, ora ridiventare piú muto d’una tomba antica e senza nome.
Ho cosí camminato lungo gli anni della vita, fianco a fianco con questo strano compagno di viaggio, non bene identificato, eppure piacevole e interessante, perfino durante i nostri silenzi; avvertivo in questi l’essenza enucleabile di una filosofia che mi mancava, alla quale aspiravo, e che per le condizioni in atto e le contingenze esistenziali, non riuscivo a cogliere in modo preciso.
I problemi di natura interiore piú formativi sono i problemi dell’anima; e, se lo vogliamo dire, non possono venir considerati problemi. Un problema reale è rimanere in mezzo al deserto del Sahara con la jeep in panne e il cellulare scarico. Non per questo le vicende dell’anima vanno poste in secondo piano, anzi. Però devono venir riconosciute come “richieste”, non scambiate per problemi; richieste quasi sempre intense, elevate, impellenti. E tra i problemi e le richieste passa una bella differenza: i primi possono venir risolti con destrezza, mezzi materiali e colpi di fortuna; le altre non accettano espedienti, marchingegni o estrazioni di lotterie varie; esigono piuttosto una chiave interpretativa che ciascuno deve prima forgiare in pectore, su misura unica ed esclusiva per la serratura che aprirà, se davvero ci tiene ad aprirla.
Il che richiede parecchie cose che assomigliano molto alle virtú, e per questo non mi perdo a descriverle; prima di tutto perché le conosciamo bene, almeno per sentito dire, e in secondo luogo per il fatto che l’argomento “virtú”, se non si presenta come un vero e proprio esempio di vita pratica, ma si lascia solo leggere sulla carta stampata, diviene un moralismo soporifero a danno di quanti cercano di rimanere svegli per imparare.
Infatti chi è desto nell’interiorità, sa sempre di dover imparare; chi invece dorme in piedi e agisce in base ad un telecomando manovrato da postazioni remote, è costretto a ripetere: «Noi (plurale maiestatis) non ci facciamo dare lezioni da nessuno!». In fondo la differenza tra problemi e richieste, tra opportunismo e virtú, tra il “dover fare” e il “voler agire” sta tutta qui.
Cosa avrà voluto affermare Eraclito? Non per nulla i contemporanei l’avevano soprannominato “l’Oscuro”; le sue enunciazioni laconiche (ma efesine) si prestavano a diverse interpretazioni, e se uno non conosce bene il funzionamento della bussola, vede soltanto un ago, mezzo bianco e mezzo nero, oscillare tra le sigle N, S, E ed O; il che non basta a trovare la strada di casa.
Per contro, ci sentiamo talvolta motivati a indagare la realtà, incluse le vicissitudini della vita interiore; ma non sempre i motivi che sostengono la nostra richiesta portano pensieri e riflessioni alla meta desiderata. Può accadere (ed infatti accade di frequente) che ci si fermi al primo appiglio, si consegua un atto cognitivo superficiale, tutt’altro che esauriente, e lo si prenda per il traguardo cercato.
Forse è per questo che accanto al vecchio detto “chi cerca trova”, è stato posto un emendamento, un po’ disinvolto, che sostiene un’altra tesi: “chi cerca, cerca; e chi trova, trova”. Del resto, mi pare giusto ricordarlo, la storia insegna che i “cercatori” non avevano le medesime caratteristiche dei “trovatori”(questo nei tempi in cui le due categorie erano ancora distinguibili; oggi, in genere, non si cerca né si trova, si agguanta quel che capita a tiro).
Studiare la Scienza dello Spirito, leggere e meditare sul pensiero dei Maestri che l’hanno sostenuta e divulgata, serve a molte cose; ma, per mio personale giudizio, la speranza di poter cercare nel mondo sovrasensibile ai fini trovare e colloquiare con le anime disincarnate, è da ritenersi l’ultima cosa in ordine d’importanza. Avviarsi sulla Via dello Spirito con questo chiodo fisso in testa, diviene una complicazione operativa capace di invalidare anche i frutti di tenace volontà e di onesta applicazione. Cercare non è mai la sola causa del trovare, ma è piuttosto un presupposto efficace.

La “corsa all’oro” nell’Ovest degli USA
Una commistione del genere può accadere in quanto la brama del traguardo annulla il piacere del viaggio, il senso dell’avventura, la gioia di incontrare, di conoscere, amare e rispettare; non è difficile capire come la corsa all’oro degli antichi pionieri, dal fiume Sacramento verso l’Ovest, si risolse in una riffa all’americana, dove la febbre del metallo si trasformò e dilagò nel tempo simile ad un contagio pandemico, ancor oggi ritenuto vessillo di civiltà, di progresso e senso ultimo di un umano benessere, acquisibile a patto di rifiutare lo Spirito, la missione dell’uomo sulla terra, la funzione dell’anima e la grande opera del karma.
«C’è gente che pagherebbe per vendersi» sentenziava con ironica malevolenza Oscar Wilde, mettendo in risalto la cupidigia che da sempre affligge l’umanità. Ed infatti è sotto gli occhi di tutti come l’intricato flusso dei fiumi di denaro che scorrono senza posa ovunque, venga svolto, attraverso le mani invisibili di astuti, abilissimi e anonimi croupier, capaci di far scoppiare guerre, carestie, povertà, ingiustizie sociali, tensioni al fulmicotone e feroci contrasti di opinioni e sentimenti, ovunque: nei singoli, nelle famiglie, nei piccoli gruppi come nelle comunità, nelle nazioni e nei popoli.
Se la versione esatta di Panta Rei fosse circoscrivibile in un «Tutto Passa», buttato lí sul tavolo dell’osteria assieme al vino e ai tarallucci, la visione disincantata del mondo attuale sarebbe meno preoccupante; dopo i temporali, dovrebbe tornare il sereno. Ma una tale interpretazione, anche giusta se vogliamo, eppur troppo minimalista per cogliere l’antico nocciolo di saggezza, è costantemente smentita dalle vicende umane, nonché dai fatti storici che ne conseguono; in particolar modo dai retroscena che manovrano la strategia del nostro divenire, rendendolo sempre piú precario e disperato.
Un Panta Rei accompagnato da «Tutto Passa (e si scorda)» sospinge sempre piú i sostenitori verso il baratro, dacché ogni cosa che esiste in questo mondo, anche la piú nobile e virtuosa, se stracapíta o abbandonata al suo ermetismo, innesca una concatenazione a valanga, che può rivelarsi catastrofica per tutti.

Chi trascura il passare di un’ora che non tornerà piú, anche se non lo sa, fallisce un appuntamento col proprio karma. Crederà di potersi bagnare per una seconda volta nelle acque dello stesso fiume, ma non gli sarà concesso, giacché il corso degli eventi che riguarda l’uomo, la terra e l’universo non si arresta, né potrebbe tanto meno svolgersi a ritroso.
Quindi, il “Divenire”: ecco la parola magica, il concetto capace di rinsaldare il passato all’avvenire, di congiungere il presente col futuro, cosí fortemente impugnato e ribadito dal filosofo quasi duemila e cinquecento anni or sono. Cosa significa “divenire”? Significa che tutto è sempre in uno stato di continua, incessante trasformazione. Altro che “Tutto Passa”! Con questa battuta si riduce ogni cosa ad un punto fermo, la si blocca per un desiderio umano di poter chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo.
Ma nel pensare in tal modo non ci si avvede, non si riesce a porre nel dovuto rilievo la nostra funzione di traghettatori, che è l’unica a far transitare (non certo il tempo e le sue frazioni, che vanno avanti senza bisogno di interventi umani), ma la consapevolezza di esserne collegati; non quindi semplici parti integranti di un gigantesco meccanismo universo, bensí minuscoli, ma indispensabili, rotelline che possono dare allo scorrere inarrestabile del tempo, il senso ultimo di un ritmo, di un battito, di un’armonia, di un bisogno di vita, che accenda di sé l’infinito scorrere dei giorni, delle ore, delle esistenze.
In uno scritto recente, ho preso lo spunto dal romanzo di Michael Ende, “Momo”; chi l’ha letto (o ne ha visto l’ottimo film) ricorderà senz’altro il momento indimenticabile, ed il profondo ammaestramento che ne consegue, dell’incontro tra Momo e Mastro Hora. E chi non l’ha ancora veduto, può evitare il rischio di perderlo, andandolo a cercare là dove è ancora leggibile o visibile (questo prima che i Signori in Grigio ce ne tolgano la possibilità, eliminandolo totalmente dalla circolazione).
Eraclito parlò dunque di un divenire che tocca ogni essere umano; questo divenire è il ritmo segreto della vita che pulsa nei nostri cuori, nei quali il passato, rielaborato ad humus, fa spuntare i nuovi germogli per il futuro. Parlò non soltanto a quelli del suo tempo, ma alle generazioni a venire; per renderle consapevoli che la dimensione del tempo, ove non venga sostenuta dallo scorrere delle vite umane e delle loro vicissitudini sublimate attraverso pensieri colmi di volontà e traboccanti d’amore per il prossimo, diventerebbe un fiume asciutto, arido al punto di prosciugarsi e non potersi chiamare piú fiume. Sarebbe dapprima stagno, poi palude e infine deserto.
In effetti, la traduzione in “tutto passa” manca della sua metà, che è: “ tutto arriva”. Una metà davvero indispensabile per onorare l’antico Autore. Per la natura il divenire non costituisce un problema e neppure oggetto di un’intima richiesta. La natura non diviene; è bensí il divenire che nell’inverarsi adopera tutte le forme, i colori e le sostanze della natura, ci vive dentro, e quando rimaniamo a volte sopraffatti dall’emozione nell’assistere ad uno spettacolo incredibilmente splendido, di sole, cielo, mare o montagne, dovremmo ricordare che ci troviamo davanti all’opera dell’infinito divenire, di cui noi stessi, pur appesantiti dal bagaglio ingombrante di personali minuzie, siamo parte integrante, in quanto avviati ad una speciale forma di cooperazione per ora tutta da scoprire.
Il divenire è speranza, progetto, anelito, proiezione di un qualche cosa che ancora non c’è ma che potrà esserci. Però, però… attenzione! Le nostre prospettive per il futuro esigono una certezza: prevedono di mantenere fisso il quadro di partenza. Nelle metodologie delle scienze esatte, il termine preciso è quello di “ceteris paribus”, ovvero la teoria esposta rimane valida solo se le condizioni di partenza restano ferme dall’ipotesi alla dimostrazione. Il che, nel quotidiano, non si verifica mai. In un certo modo le premesse sono viziate fin dall’inizio.
Facciamo un esempio: quando avevo 18 anni, appena finito il Liceo, mi iscrissi all’Università nella facoltà di Economia e Commercio. Anche se non del tutto chiaro, avevo davanti a me un quadro appena abbozzato di quel che grosso modo avrebbe potuto essere un giorno il mio settore lavorativo.
Ma avevo fatti conti senza l’oste. I miei pensieri (diciamo le mie supposizioni) di allora, per quanto realistiche, non avevano calcolato tutte le possibili varianti che sarebbero intervenute nel lasso di tempo tra il progetto d’avvio e la sua realizzazione concreta. E infatti arrivarono tutte (o almeno credo, perché non le ho contate); diventai agente di commercio (rappresentante viaggiatore), cambiai regione, lasciai gli studi, poi la ditta per cui lavoravo chiuse i battenti, tornai alla mia città, mi iscrissi da fuori corso alla facoltà di Scienze
Politiche prima e a Giurisprudenza poco dopo, ed infine, su segnalazione di un amico che aveva appena abbandonato il posto di produttore per una agenzia di assicurazioni (aveva trovato qualcosa di meglio) mi rivolsi colà, ed entrai cosí nel mondo assicurativo, di cui non sapevo praticamente nulla.
Rimasi sul campo per 43 anni e 7 mesi, ovvero fino all’età della pensione; con diverse mandanti, vari livelli ed incarichi; da produttore a capogruppo, quindi ispettore, quindi subagente, per coronarmi alfine Agente Generale il 4 aprile 1968. C’entrava forse tutto questo con la mia propensione di matricola per il corso di Economia e Commercio, timidamente avanzata prima ancora che partisse il colpo dello starter? Apparentemente no, per nulla.
Gli eventi girano e lavorano spesso in modo talmente veloce e vorticoso che non riusciamo a capire non solo quale sia la direzione generale dei medesimi, ma addirittura se una direzione generale possa esistere ed emergere da quel loro impetuoso accavallarsi. Come diceva il mio vecchio allenatore di canottaggio: «Non puoi leggere la Gazzetta dello Sport durante la battaglia». Oggi tuttavia mi rendo conto che nel passato, per numerose volte, l’ho fatto; per la semplice ragione che non vedevo (o non volevo vedere) la battaglia come tale. Praticamente ho combattuto senza saperlo. Il che equivale a non aver combattuto affatto; ritrovarsi con ferite e cicatrici che i medici, dopo attenta osservazione, definirebbero “di dubbia provenienza”.
Donde salta fuori il verbo “divenire”? L’etimologia corrente se la cava con un “venire da… scendere giú da…”, questo però non dice molto. Da tempo la Scienza dello Spirito mi ha convinto (ossia mi ha fatto capire e io me ne sono persuaso) che comunemente tutti gli esseri animati “vengono giú da…”. Ma la parola “divenire” porta in sé una forza misteriosa, urgente, la cui direzione è tutta declinata al futuro; certo, importa conoscere il passato, avere notizie sulla propria provenienza, acquisire e stabilizzare il senso dell’autoidentificazione; ma questo è frutto di ciò che abbiamo alle spalle: il Panta Rei è una spinta in avanti: si proietta in quel che sarà, o potrebbe essere.
Per cui (mi scuso fin d’ora per la licenza poetico-lessicale) dopo aver masticato e digerito piú volte il senso del Panta Rei, nella maniera in cui mi suonava buono e giusto, sono arrivato ad una conclusione piuttosto irrituale, ma – a mio giudizio – interessante, aderente soprattutto al significato che Eraclito volle dare a quel motto. Affermo pertanto che nulla vieta di considerare il termine “divengo”, “divenire” una forma modernizzata e contratta del latino “divum, o divinum, inire”: entrare nel divino: diventare dei.

E questo mi pare che, per quanti abbiano letto il Vangelo di Giovanni, possa ricordare qualcosa di determinante. Qualcosa che – incomprensibilmente, ma non troppo – è stato messo in disparte, senza le indicazioni e i riferimenti di cui le varie esegesi hanno nel tempo sovraccaricato ogni passo, ogni parola e ogni punteggiatura delle Scritture.
Se l’interpretazione non è fallace, allora sostenere che il Panta Rei significhi: «Ogni cosa è in un Perpetuo Divenire», è un accostamento tutt’altro che arbitrario alle fonti delle indagini spirituali; in particolare, è in accordo con quanto appreso dalla Scienza dello Spirito, circa la destinazione dell’uomo e la sua missione attraverso il ripetersi delle vite terrene.
Dai Mondi dello Spirito, l’anima discende nella dimensione fisicosensibile, che è la dimensione della Morte, per incontrare la possibilità di sperimentare in Essa la propria Redenzione e Rinascita. Un simile impulso è cosí potente che l’azione liberatrice può estendersi anche ad altre forme esistenti, attive o inerti, cadute nella materia e nel condizionamento che la consegue.
Ci sono vari motivi per i quali il significato del divenire è sempre stato tenuto lontano dal pulpito confessionale. In questo senso dobbiamo ammettere che le dottrine ufficiali hanno dimostrato scarsa generosità nel non cogliere, dentro il Panta Rei del filosofo greco, una connessione logica con una delle affermazioni piú eclatanti del Nuovo Testamento.
Di tali motivi ne scelgo soltanto uno, perché mi sembra essere quello che evita maggiormente la possibilità di innescare polemiche e invece va a chiarificare alcuni aspetti riguardanti la conoscenza delle cose in relazione all’umana interpretazione delle medesime. Mi pare di averlo già illustrato altrove, ma la ripetizione non è mai inutile; durante il giorno io vedo discretamente bene (con gli occhiali) fino a trenta metri; ho degli amici che possono vedere (senza occhiali) fino a cinquanta o sessanta metri, beati loro! Comunque è evidente che per me la realtà di cui sono circondato non è la stessa di chi ha l’occhio di lince. Almeno in partenza. Cosí può altrettanto dirsi per tutti i sensi corporei; per non andare poi a parlare del cosí detto “sesto senso”.
Per quanto riguarda il conoscere, accade in linea di massima la medesima cosa; ognuno sa un po’, chi piú chi meno, ma per ciascuno di noi l’ambito della sua conoscenza (ossia la sua momentanea totalità) viene percepito interiormente come fatto completo e compiuto. Sono rarissimi gli uomini adulti che rivelino una preoccupazione, anche modesta, per le proprie lacune culturali; forse le tengono per sé, ma l’atteggiamento che aleggia sul mondo odierno è una convinzione diffusa in base alla quale, una volta piazzati sul posto di lavoro e messa su casa e famiglia, una propensione per ulteriori conoscenze scientifiche o filosofiche sarebbe tempo sprecato.
Il che sta a dire che la nostra coscienza ordinaria vive (o vegeta) solo nel presente; per onorare il passato ci sono i ricordi, per infiorare il futuro ci sono le speranze; reparti questi, che per quanto organi di elaborazione percettiva interna, spettano in gran parte alla vastità della psiche, ben poco alla coscienza.
Quando lentamente, giorno dopo giorno, facciamo sparire dietro lo schermo delle premure ordinarie e degli impegni di routine, ogni velleità di conoscenza e di incontro col mondo, che non sia esclusivamente quello cerebrale, abbiamo ridotto senza saperlo la nostra capacità di consapevolezza a livello zero.
Diventiamo simili alla Sentinella della Fortezza Bastiani, raccontata da Dino Buzzati, nel suo “Il Deserto dei Tartari”. Dopo anni e anni di vigilanze, appostamenti e di turni di guardia, nulla mai accadendo, e non provenendo dal Deserto alcuna forma ostile, l’allerta non può essere quella di prima.

Del resto, pure gli Apostoli ebbero ad addormentarsi in quella famosa notte nel Giardino dei Getsemani. Ed erano gli Apostoli!
L’uomo di oggi porta dentro di sé una coscienza senza dubbio pensante, ma pensante propter quid; non secundum quid. La differenza è decisiva. Tutti sanno cosa hanno pensato o quel che hanno da pensare, ma pochi possono rispondere alla domanda: «Com’è che si pensa?». Anzi, per alcuni una domanda del genere non avrebbe nemmeno un senso.
Vivere centrati nel presente non è sbagliato; semmai lo sbaglio sta nel non accorgersi, cosí facendo, di porre in estremo rilievo l’istantaneità, mentre trascorso e futuro passano in seconda linea, in quanto non danno ai nostri sensi la stessa corposità che l’attimo, nel momento in cui c’è, sa dare.
Ma disgraziatamente l’attimo è… un attimo; la sua natura è quella di passare, scivolare via e dar posto al successivo; «Attimo fermati! Sei bello!» di Goethe: il Poeta intuiva il dramma dell’ineluttabilità del fugace che elude continuamente l’anima legata alle categorie sensibili.
In sostanza noi ci formiamo, inconsciamente, una visione della realtà basata su una specie di artificio. Se in una stanza buia faccio rapidamente roteare una piccola luce, anche una sigaretta accesa, vedo formarsi un circolo luminoso. Ma non esiste alcun circolo, è solo la mia incapacità di cogliere il movimento della luce, nel suo frazionarsi in un’infinità di punti; lo assumo come movimento continuo e completo.
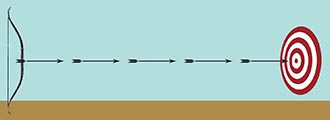
Una volta afferrata la realtà del giochino, si può venir spostati di colpo sul ragionamento opposto: mentre con la semplice visione credevamo di osservare un circoletto luminoso, ora, riflettendo per astratto, impariamo che tale movimento è del tutto apparente; in ogni suo punto infatti vi è la brace della sigaretta accesa, che transita, spostandosi velocemente. Dal che potremmo pensare che il movimento in sé non esista, essendo esso formato da un’infinità di passaggi, in ciascuno dei quali la sorgente di luce, per forza di cose, dev’essere ferma. Nulla di nuovo sotto il sole, giacché tale induzione costituí una delle perle filosofiche della Scuola Eleatica nell’antica Grecia, vedi il paradosso della freccia di Zenone, illusione di movimento perché ferma nella somma degli istanti immobili.

Rumi
Altrettanto però siamo portati a fare con la temporalità che ci incanala dal passato al futuro attraverso una miriade di frammentazioni, consegnandoci allo stesso ingannevole gioco. Se, come affermava Jalal al-Din Rumi, «la Verità è uno specchio caduto dalle mani di Dio», allora il Tempo dev’essere l’Eternità, che ha voluto infrangersi nella provvisorietà del molteplice. Pertanto il divenire, ogni divenire, come l’uomo d’oggi lo pensa, resta una produzione astratta, discorsiva; un pleonasmo che non può piú appartenere alla logica dell’essere, la quale proprio sul divenire si fonda. Nell’istante in cui lo percepiamo, l’attimo è sempre solo un divenuto, mai il diveniente. Per questo è possibile percepirlo.
Il rapporto con la dimensione del tempo, non ha da essere statico (momento dopo momento) né dinamico (un flusso continuo che non si ferma mai); potrà essere cosí se la coscienza con la quale lo si sperimenta, si è formata maggiormente nell’esperienza dei sensi fisici, oppure se ha conquistato la capacità di svolgere congetture astratte che prescindono dal realismo tout court. Entrambi i casi rappresentano due forme di errore, tipiche delle posizioni estremistiche.
L’uomo è in evoluzione, ma la sua anima, la sua coscienza, quando sono deste, viaggiano piú veloci di lui; tendono a precederlo. Vedi, ad esempio, le intuizioni. Per cui viene il momento dal quale emerge il problema: qui o i miei sensi sballano, oppure nulla è come pare che sia. È un momento estremamente delicato perché è facile, se non lo si approfondisce a dovere, ricadere su una delle due posizioni polari, sopra specificate, oppure giustificare le due come una distorsione dell’altra.
Ho sentito una volta dire da un critico d’arte che la pittura futurista è in fondo una “distorsione” della pittura del periodo romantico. Possiamo dargli torto? No. Se si continua ad ignorare le centinaia di migliaia di passaggi che trasformano un passato melocromatico in un enigmatico futuro, allora il batter d’ali della farfalla di Tokio niente avrà mai a che vedere con la nevicata di New York. Il quesito nasce sempre dal fatto che la coscienza dell’uomo sta in mezzo tra la dimensione dei concetti e delle idee, e quella della percezione e rappresentazione. Quest’ultima ci induce a cogliere (e ri-tenere) il momento, la cosa, l’oggetto, l’attimo come fosse uno dei tanti percepibili/percepiti. La necessità di spazio e di tempo inquadra l’esperienza sensibile come si deve, ovvero limitandola all’apparente. Mentre col mondo dei concetti e delle idee noi navighiamo a vista sulla barca dell’astrazione; tutto ci appare fluido, scorrente, dinamico, e non riusciamo, di norma, ad afferrare un elemento senza che questo si modifichi fin dal nostro primo contatto.
Rudolf Steiner ci parlò dell’anima e delle sue parti costitutive; le specificò in senziente, razionale-affettiva e cosciente. È quindi logico comprendere che per un certo verso siamo sempre pronti a recepire il solo presente e ci aggrappiamo ad esso come naufraghi allo scoglio, anche quando il presente è cessato da un bel pezzo; l’anima senziente e, almeno in parte, quella razionale-affettiva, non può comportarsi diversamente. Ma quando rifletto, studio, progetto, medito, quando mi pongo in raccoglimento interiore per dipanare determinati problemi, allora io supero in me il limite della spazio-temporalità, e viaggio, dapprima in astratto, tra ipotesi, abbozzi di soluzioni, rapporti, connessioni varie con i quali comincio a ricomporre i pezzi sparsi del puzzle, cercando di dar loro un assetto, una direzione, una finalità. Tuttavia, se il mio pensiero non ha ancora acquisito quella forza e quella indipendenza dal mondo dei sensi e delle passioni, per innalzarsi ad altezze insolite, dovrò restare a terra e ritenere che i concetti e le idee siano sí, una bellissima cosa, ma continuerò a credere che il mio stomaco vuoto non si placa con i concetti di pastasciutta o minestrone. Il momento del contatto con il divino è ancora lontano. Pertanto, tutto diventa (ecco rispuntare il Panta Rei!) una questione di evoluzione, di maturazione individuale. Riprendendo il verso di Jalal el-Din Rumi, ognuno afferra un pezzetto di verità, caduta dal cielo, e quel che vi vede dentro, crede rappresenti il Tutto; non recepisce il fatto che anche all’altro e agli altri accade la medesima cosa, e si rimane male quando il proprio vicino, l’amico, la persona stimata, ti smentisce di brutto, dicendoti che il tuo frammento di specchio è fasullo, e soltanto il suo specchia l’intera verità.
Lungo la strada della maturazione, c’è la conoscenza sovrasensibile, che è un ideale, ed abbiamo poi la gnoseologia, che è l’insieme dei metodi di volta in volta adoperati dai portatori di pensiero per accedervi. Ma per la ragione specificata poc’anzi, per non essere attualmente del tutto sviluppati in quanto ad organi interiori (cervello compreso) veniamo a trovarci in una situazione molto particolare: il potere d’attrazione fisico-sensi-sibile, che ci ha sempre legato e condizionato alle categorie esistenziali e della necessità, si è un po’ consunto; abbiamo fatto qualche timido e confuso passo in avanti, ed abbiamo scoperto le meraviglie delle scienze, dell’informatica, della cosmonautica. Ma ci stiamo legando ad esse come già nel lontano passato ci siamo legati al fuoco, alla pietra e al ferro. Non sospettiamo neppure che l’esperienza del pensiero che ha sostenuto, e tuttora sostiene, le varie scienze, è una forza unica; una forza che noi abbiamo dovuto apprendere frantumata per motivi di pratica spazio-temporale. Non potendo ingerire tutta d’un colpo la Conoscenza (l’idea della Conoscenza) abbiamo dovuto spezzettarla, e lentamente, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, assorbirla, assaporarla, digerirla, emendarla a seconda dei casi e delle situazioni. E tutto questo non lo abbiamo fatto con un movimento sincronico dell’umanità intera. Siamo stati costretti a farlo a centellini e, quel che è piú pericoloso, ognuno per conto proprio.

L’ottomiliardesimo nato nel mondo
Oggi, finalmente, almeno l’istruzione popolare, per lo meno nei paesi piú evoluti, ha assunto un aspetto simile all’organicità, e grosso modo si può dire che un’infarinatura culturale, almeno di livello medio basso, viene offerta a tutti. Ma tuttavia resta il fatto che su questa terra sono contemporaneamente presenti otto miliardi di individui, ciascuno col suo grado di cultura, di sapere, di conoscenza, di tradizione e di velocità di apprendimento e maturazione, completamente diversi e disomogenei l’uno dall’altro. Staccata l’idea di Conoscenza dalla rappresentazione delle metodologie adoperabili per conseguirla, è già un miracolo se la somma 3+3 risulti dare 6 in tutti i continenti. Queste coincidenze in fatto di precisione ed esattezza, non ci assolvono tuttavia dal non aver perseguito la medesima puntualità anche là dove le leggi del “peso/misura” non si possono applicare. Pertanto rimane al centro della coscienza odierna un vuoto che per ora sembra incolmabile, e che in un certo senso, è il risultato di uno scollamento gnoseologico tra il modo in cui viviamo il presente e quello con cui ci dedichiamo al passato o al futuro.
Onde avere un tema specifico sul quale svolgere le riflessioni e meditazioni del caso, propongo, a conclusione di questo scritto un parallelo tra due stadi di coscienza umana, diversamente formati perché diversamente maturati, ma parimenti rinsaldati dalla capacità di svolgere nella propria interiorità e in maniera artistica, quel che per molti altri sarebbe fonte di dispersione e d’intimo dissidio.
Ho voluto non evidenziare i nomi, i cognomi e le opere da cui ho tratto quanto seguirà; non per giocare agli indovinelli, ma per fare in modo che tutta l’attenzione di chi legge queste righe sia rivolta esclusivamente al quel momento di crescita interiore che, da solo, è capace di trasformare il Panta Rei di Eraclito, da un quadro costretto nella cornice dell’umano soffrire, in una finestra spalancata sul rigoglioso, soave divenire di cui ciascun uomo è un potenziale frammento.
«Sono tornato dopo tanto tempo in questo posto, sperduto a Dio e agli uomini, per cercare di ricomporre attraverso una miriade di pezzi sparsi, lo specchio rotto della memoria».
Si avverte qui lo sforzo immane di una coscienza che tenta di essere Autocoscienza; è quasi sul punto di farlo, ma ha ancora bisogno di supporti, di vicende, di storie da vivere; storie che sembrino diverse dalle precedenti; è un momento in cui la desolazione domina, culmina nel grido di silenziosa protesta: “sperduto a Dio e agli uomini!”. Non c’è piú voglia di parlare, di ascoltare, di discutere. L’unica àncora di salvezza è “tornare, tornare, tornare”; perché, vagamente, si sa, si sente che c’è un “posto”, ci deve essere, dove – forse – la soluzione, anche se logora e frantumata in “una miriade di pezzi sparsi”, attende.
«Quiete lontana di Costellazione e ansia di Luce sulla Terra, accendono il ritmo dell’anima, incontro alla Tua donazione senza fine».
Cambio di registro: adesso l’Autocoscienza, forte dell’aver acquisito in un’unica sintesi il senso ultimo di tutto il gioire/soffrire delle vite terrene, volge a spiegate vele, verso la sua Luce; quella che da sempre la chiama a Sé, e – contemporaneamente – le scende incontro, a compimento d’una promessa d’Amore che non può essere se non Immortale.
L’anno 2022 è terminato; certamente esso si è chiuso nel giogo pesante della prima citazione.
Facciamo in modo che l’anima nostra sappia avventurarsi nel Nuovo Anno recando in sé la pace profonda e la dignità spirituale della seconda.
Angelo Lombroni

