
In un periodo nel quale la metodologia e la tecnologia sembrano voler costruire una cultura pianificata mondiale, è molto utile riproporre il problema della contingenza. D’altra parte, restringere la razionalità a un rigoroso razionalismo è il tentativo dell’Io di porre la sua affermazione in una categoria intoccabile: ma è proprio ciò che nasconde il profondo riconoscimento della forza della contingenza, insieme all’impossibilità di assumerla come una visione positiva e consapevole. In questo sta il valore di un contributo come questo volume di Shūzō Kuki (1888-1941), filosofo e poeta; egli pone la contingenza al centro dei problemi metafisici, mostrando cosí di sentire il bisogno dell’esistenza dell’individualità, come bisogno superiore di libertà.
Quando la contingenza è sentita e pensata al di sopra dell’empirismo e dello scetticismo, ovvero al di fuori di una razionale codificazione dell’irrazionale, è indubbiamente l’inizio di una esperienza della personalità interiore. È vero che l’esperienza scientifica nella sua fattualità è il grande correttore della necessità razionalistica, ma la scienza oggi, generando la tecnologia, emana un cosmo di necessità meccanica che tende, dal punto di vista fisico, a cogliere – attraverso le leggi – non solo la natura naturans, ma anche il sovrannaturale.
La questione della contingenza, secondo Boutroux e Bergson, non ha sempre avuto forme coerenti di vita speculativa, se si pensa a quale fosse realmente il suo primo presupposto. I concetti di māyā e di samsara possono essere presi come misura della situazione che è teoricamente imposta dalla filosofia della contingenza. Grazie a quest’ultima, la relazione deve essere intesa in senso immanente e attivistico, non come se fossero dati in essa dei “punti distinti” che permettano alla mente umana di coordinarsi, ma nel senso che la distinzione è proiettata nella realtà dalla forza intrinseca della mentalità stessa. È proprio questo tentativo di comprendere una serie di dati, che fa sorgere davanti a sé la distinzione che delimita questi fatti, e che, stabilendo una relazione tra loro, li rende intelligibili. Il confine della contingenza è la consapevolezza della relazione, che offre un mezzo per superarla attraverso un ulteriore atto di conoscenza: davanti al quale solitamente ci si ferma, o al quale si contrappone la pigrizia mentale dell’uomo.

Shūzō Kuki
Si evince dal trattato di Shūzō Kuki quale sia la natura della serie di obiezioni filosofiche alla contingenza: anche quando appaiono logiche e dialetticamente valide, tradiscono una posizione di pensiero priva di sicurezza rispetto al loro “fondamento”, e quindi tesa a cercare aiuto nella necessità, nella sistematizzazione, nell’ordine fisso delle cose, nella qualità meccanica della natura e della storia.
La stessa distinzione delle tre modalità della contingenza: “categorica”, “ipotetica” e “disgiuntiva”, rischia essa stessa di non trarre la totalità del significato della contingenza come esperienza interiore, che non è la stessa cosa della sua forma filosofica, la quale implica ancora, comunque, distinzione, relazione e sistematizzazione. Kuki ci mostra cosí la sua decisiva indipendenza speculativa. La doppia polarità di aseitas e abalietas lascia alla relazione fra loro un ampio campo di gioco, il margine del parálogos di Aristotele, che solo il rapporto con un principio di libertà e di affermazione individuale restituisce al suo giusto significato.
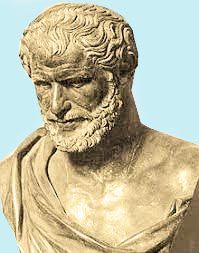
Democrito di Abdera
Il tema della contingenza che può diventare filosofia, o sistema speculativo, non può che divenire un paralogismo o una retorica: questo infatti dovrebbe comportare una posizione di autonomia intellettuale, non per la mancanza di un procedimento gnoseologico, ma per eccesso di esso. Si potrebbe dire che un jnana-yoga, o una via zen, o un percorso di meditazione buddista, può essere il logico coronamento dell’assunto della contingenza. Altrimenti diventa esso stesso una necessità, una opposizione dialettica al principio stesso della contingenza, che, da Democrito di Abdera ad Hamelin, sorge sempre nel pensatore come il segno della sua autonomia e della sua possibilità di filosofare áneu malakía, per non rendere la natura una sovranatura in forma razionale o scientifica. Dunque questo tema è di attualità, non solo in Oriente ma anche in Occidente, riguardo alla tendenza della tecnologia e del pensiero che ad essa è quotidianamente legato, divenendo automatico e perdendo costantemente la sua autonomia intuitiva rispetto ai problemi: questo tema è trattato da Shūzō Kuki con estrema sottigliezza e consequenzialità.

Le divinità Isazanami e Isazanagi guardano formarsi l’isola originaria Onokorozim
Pensiamo che sia importante non solo dal punto di vista filosofico, ma soprattutto psicologico e morale, che quasi tutta l’opera di Shūzō Kuki sia in giapponese, cioè viva in una lingua che ha già nella sua struttura la forza dello Spirito. È un pensatore della statura dei grandi giapponesi come Nishida e Tanabe, costruttivo o positivo come loro, anche se di diversa formazione. Come nota Hisayuki Omodaka, che ha tradotto quest’opera e scritto l’introduzione, Kuki interpreta il mito giapponese evocando la genesi di Onokorozima, isola originaria e simbolica, a significare la contingenza primordiale; egli riconosce anche l’importanza dell’etica del Bushidō e sente lo stile interiore ed estetico noto come Fūryū, proprio di un sentimento fondamentale e poetico per la natura.
Massimo Scaligero
Kuki Shūzō Le problème de la contingence.
Editions de l’Université, Tokyo 1966.
Da: East & West, Settembre-Dicembre 1967, Vol. 17, No. 3/4.

di James Haughton Woods
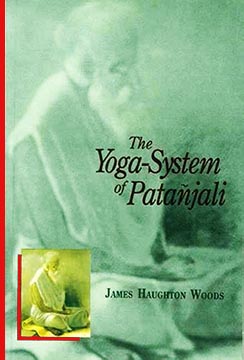
Quest’opera, ora alla sua terza edizione (la prima risale al 1914), è il volume XVII della Harvard Oriental Series, diretta da Charles Rockwell Lanman, con la cooperazione di vari studiosi. Il sistema Yoga, una dottrina indú classica di concentrazione mentale, contenente le “regole mnemoniche” o Yoga-sūtra di Patanjali, il commento, o Yoga bhāshya, attribuito a Veda-Vyāsa, e la spiegazione, o Tattva-Vāicāradi, di Vāchaspati-Mishra, è stato tradotto da James Haughton Woods, che illustra e delinea il tema attraverso una prefazione, un’introduzione e una sistematizzazione analitica dei testi. Il lavoro di Woods è noto da anni ed è considerato uno dei piú validi in materia.
Gli Yoga sūtra non presentano alcuna problematica filosofica nella loro struttura essenzialmente pratica, tranne che per il loro riferimento teista, cioè un riferimento ad una monade trascendente, Isvara, simboleggiata dalla parola-suono “Om”, sulla quale lo Yogi deve meditare per innalzare la sua mente al di sopra delle fluttuazioni ingannevoli. Questo deve essere sottolineato per rendere evidente la presenza del Dio come promotore del dhyāna e del samādhi, o potenza risvegliatrice del pranidhāna, piuttosto che come un potere che opera umanamente. Per tale ragione i commentatori sentono la necessità di arricchire la funzione del Dio: Vyāsa lo vede come un salvatore che prende la forma sovrasensibile del sattva per agire tra gli uomini. Secondo la stessa direzione, Vāchaspati Mishra attribuisce a Isvara un ruolo cosmogonico, e a Bhoja il compito cosmico della relazione continua tra purusa e prakriti.
La posizione teista non cambia l’aspetto pragmatico dello yoga, come qui prospettato, secondo la necessità dell’assoluta risoluzione mentale delle apparenze del mondo. I 194 sūtra sono presentati secondo una fitta e serrata serie di esigenze per l’affermazione del principio purusa: il testimone silenzioso, che percepisce tutto senza venir cambiato da ciò che gli è rivelato. È l’anima nel suo essere originario, talmente identica a se stessa da non potersi vedere. Eppure può manifestarsi allo yogi in un lampo trascendente, quando purifica la buddhi da tamas e rajas. In quel caso è l’Io superiore o trascendente che riesce a vedersi, in quanto diviene oggetto di se stesso, e non che l’io riflesso possa subordinarlo a sé come oggetto. Il chiarimento di questo punto è essenziale come base noetica del sistema, e in tale accezione è attuale oggi, perché stabilisce l’impossibilità che l’esperienza dell’Io sia un fatto mentale o dialettico. Solo lo stato di buddhi, a livello di sattva, permette all’Io di sperimentare se stesso: non perché l’io riflesso sia eliminato, ma perché la riflessività e la forza interiore dell’Io, attuata, vengono superate.
Chiamiamo “attuale” tale posizione dell’esperienza dell’Io, dato che nella filosofia occidentale una delle principali confusioni riguardante il problema dell’Io, come prospettato da Hegel, consisteva nell’incapacità di concepire la percezione della trascendenza nell’immanenza: questo problema doveva indubbiamente essere chiaro a Hegel, ma è stato messo in dubbio dalla successiva dialettica, che non partiva dal principio della dialettica, ma dalla dialettica della dialettica hegeliana, entrando cosí in una serie interminabile di contrasti discorsivi , cioè di filosofie prive dell’esperienza interiore del pensiero. L’attualità di Patanjali non è solo quella di una disciplina del pensiero e della contemplazione, ma anche la concezione di uno sfondo religioso e trascendentale in pieno accordo con l’ascesa del mistico ai livelli superiori della coscienza, manas, buddhi e ātman.
Massimo Scaligero
James Haughton Woods, The Yoga-system of Patanjali
Motilal Banarsidass, Delhi, 1966.
Tratto da East & West – Settembre-Dicembre 1967, Vol. 17, No. 3/4.

Kulatissa Nanda Jayatilleke
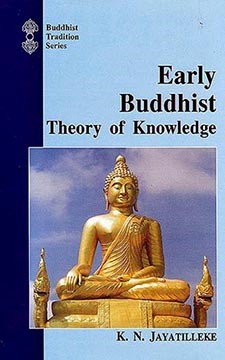
Questo trattato del Prof. Jayatilleke è un contributo alla comprensione della gnoseologia tematica del Buddismo originario e della sua relazione con il pensiero indiano. Il problema è del tutto indipendente dalle moderne soluzioni gnoseologiche: il tema della conoscenza nel Pāli Nikāya, ad esempio, dovrebbe essere esaminato in relazione al modo di conoscere implicito in quel misticismo. La proiezione delle categorie dell’empirismo logico o dell’analisi strutturale, cosí importanti per gli studiosi contemporanei, in quella visione ascetico-pragmatica è indubbiamente possibile e può avere interesse scientifico: può essere un esercizio semantico, di certo utile, ma non risponde alla noesi propria del Buddismo originario.
Neppure il “materialismo” del Tattvopaplavasimha di Jayarāśi Bhalta può essere identificato con ciò che oggi viene inteso come materialismo. Allo stesso modo, l’ilozoismo presocratico non può essere considerato materialismo. L’uomo antico non poteva immaginare una materia che fosse astratta e identica a se stessa: questo non avvenne nemmeno nel caso dei buddisti considerati Nāstika, o della scuola Lo-kāyata-Cārvāka, per i quali le varie assunzioni della realtà non comportavano una negazione del valore dell’essere, ma erano ancora esperienze dei gradi dell’essere, che non possono essere assimilati al nichilismo, allo scetticismo o al materialismo critico della filosofia moderna.
Lo stesso uso del modus tollendo tollens nella posizione empirico-critica non può esaurirsi in un assunto formale, proprio per la ragione che si muove sul piano della concettualità metafisica e fa appello a un principio intuitivo. La dialettica e la logica buddiste effettivamente offrono una struttura formale che può essere identificata attraverso il canone della logica moderna, ma lo studioso deve essere in grado di tener conto di una situazione psicologica costituzionale e di una corrispondente visione del mondo, che caratterizzavano l’uomo antico e non possono essere identificate con la posizione psicologica e intellettuale dell’uomo moderno. Non si può stabilire, sulla base dell’espressione discorsiva e linguistica, omologia o identità a quel livello. La dialettica o la logica buddista sono sempre i contenitori di un contenuto di coscienza, sia che appaia realismo o nominalismo. Se non si tiene conto di questo, si rischia di ridurre il misticismo, la metafisica, l’etica, la psicologia ecc., del mondo antico, alle categorie del pensiero moderno, che manca della dimensione interiore del primo.
Ad ogni modo, l’indagine condotta qui da K.N. Jayatilleke, anche se rigorosamente basata su tali categorie, è indubbiamente un buon contributo alla ricostituzione di quello che era il significato intrinseco dell’indagine intellettuale implicita nel Buddhismo antico.
Massimo Scaligero
K.N. Jayatilleke, Early Buddhist Theory of Knowledge,
George Allen and Unwin, Ltd., London 1963.
East & West, Settembre-Dicembre 1967, Vol. 17, No. 3/4.

IL DISCORSO DALLE MILLE SILLABE
di Vasudeva Sharana Agrawala
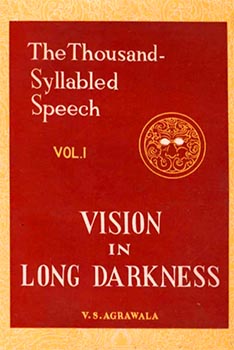
Quest’opera è l’introduzione e l’analisi, il testo e la traduzione dell’Asya-Vāmīya Sūkta di Rishi Dīrghatamas: uno studio del simbolismo cosmico nella sua versione vedica, che Vasudeva S. Agrawala ha svolto non solo con rigore filologico, ma soprattutto con l’amore di chi penetra nella realtà della materia trattata.
L’Asya Vāmīya, Inno del Rig Veda (I, 1.64, 1-52), offre l’opportunità a Rishi Dīrghatamas di fare varie meditazioni sul Mistero della Creazione. Egli è un pensatore asceta del periodo vedico, dotato di conoscenza scientifica e filosofica, e dotto nella consistenza del mondo visibile, cosí da poter contemplare il mistero delle origini senza perdere il contatto con la realtà presente.
Il testo – come nota Agrawala – ha un linguaggio intellettuale, ma in senso puro, poiché evolve secondo il ritmo imaginativo insito nella natura creativa. Cosí che questo linguaggio è studiato come una serie espressiva di simboli: «Gli antichi lo consideravano come Nidāna Vidyā, ad esempio pensavano al potere pranico di Gāyatrī e lo vedevano visibile nel Fuoco fiammeggiante, e consideravano Agni come simbolo di Gāyatrī». Rishi non è solo l’interprete, ma anche colui che rivive la rivelazione originaria grazie alla sua esperienza personale. Nessun commento vedico è possibile senza quell’esperienza: questa verità è sottolineata da V.S. Agrawala, sia nella sua introduzione che nell’analisi dell’opera. Egli nota che Rishi riuscí a identificare il profondo significato cosmogonico dei Veda, che in sostanza era Srishti Vidyā. L’elemento cosmogonico è comunque inseparabile dalla dottrina dei molteplici stati dell’essere e quindi da tutte le forme di sapienza metafisica e rituale. Avendo colto la pienezza e l’ampiezza delle idee cosmogoniche dei Veda, egli ha adottato un linguaggio di simboli corrispondenti, costituito dall’intero alfabeto di numerosi Vidyā: i Deva-Vidyā, Chhando-Vidyā, Samvatsara-Vidyā, Virāj-Vidyā, Suparna-Vidyā ecc.
La presentazione, la traduzione e il commento di Agrawala rendono omaggio al valore dei contenuti, conferendo loro una oggettiva e viva forza comunicativa. Ciò è evidentemente dovuto al fatto, ormai raro, che lo studioso della dottrina è allo stesso tempo uno sperimentatore del proprio contenuto interiore. Non si tratta solo di un’opera di erudizione, o di un contributo scientifico, ma soprattutto di un’esperienza spirituale che V.S. Agrawala ci dà la possibilità di rivivere.
Massimo Scaligero
V.S. Agrawala, Vision in Long Darkness. The Thousand-syllabled Speech, Vol. I.
Varanasi, Prithivi Prakashan, 1963.
East & West, Settembre-Dicembre 1967, Vol. 17, No. 3/4.
Link agli articoli in inglese: “Kuki, Woods, Jayatilleke, Agrawala”

