 Il Potere del Principio si manifesta nel pensiero come luce predialettica.
Il Potere del Principio si manifesta nel pensiero come luce predialettica.
Questa luce è presente nel pensiero che si dia come oggetto, e come tale sia sperimentabile.
C’è una precisa condizione di partenza: si verifica quando il pensatore, per virtú d’ascesi meditativa (concentrazione) risale il corso del pensiero dal momento del “pensare-sul-pensato” a quello del “pensare-sul-pensare-stesso”, ora inteso come pura potenzialità non impegnata in determinazioni oggettive.
Ciò avviene nella misura in cui si raggiunge la consapevolezza d’avere a che fare con un’energia scorrente all’infinito, capace di creare qualunque pensiero, di mantenerlo o di eliminarlo, lasciando allo sperimentatore la constatazione d’averlo voluto avere o d’averlo voluto estinguere.
Constatazione che diventerà fondamentale per le ragioni che seguono.
Il momento sorgivo del pensare, inizio dell’attività pensante, non necessita d’ancorarsi e sostenersi con altri pensieri, sensazioni o sentimenti; nell’intima struttura del suo essere è presente il sovrasensibile.
Mentre qualunque elemento tratto dal mondo fisico e da quello psichico deve dapprima venir conosciuto e compreso mediante il pensiero, il pensare datosi come oggetto di se stesso non si subordina a condizioni: in quanto entità pensante, l’intero esistente è causa prima d’ogni pensabile.
In essa si esprime il Potere del Principio.
Tuttavia, per arrivare a questo punto l’uomo ha bisogno d’imparare la strada che deve percorrere, ovvero trovare la possibilità umana d’accostarsi al momento della Luce predialettica.
Questa possibilità, alla portata di qualunque coscienza volitivamente pensante, merita una riflessione articolata.
L’obiettivo ha il nome di “luce predialettica” perché la sua albedo si manifesta quale luce di coscienza quando si esauriscono i decorsi argomentativi e le descrizioni dialettiche. È comprensibile che di fronte a questa affermazione uno spirito portato all’ortodossia e all’inflessibilità relativa si senta turbato per il controsenso insito nella frase.
Se una cosa ha da essere predialettica, è evidente che non può venir palesata attraverso i gradi della dialettica, pena la decadenza del costrutto logico.
Ma tanto lo scrivere quanto il parlare devono per forza di cose, almeno nei casi meno infelici, dipendere dal pensiero. E il pensiero stesso può concedersi nelle versioni dialettiche, retoriche, filosofiche o di sofisticato culturismo dottrinale, altrettanto bene quanto lo fa elevandosi al di sopra di questi paludamenti, sapendoli elementari rivestimenti con i quali il mondo fisico-sensibile tende ad appropriarsi di ciò che non è suo.
L’elevarsi non è un problema del pensiero, ma della coscienza in cui il pensiero opera, ovvero il grado di attenzione, di destità e disponibilità da essa offerti.
Conseguentemente, una coscienza debole che ignori la segreta natura di quel che comunque scorre in lei, non vedrà nel pensiero se non una capacità dell’uomo di ragionare sulle cose del mondo; questo ovviamente è vero, ma non offre alcuno spunto capace di far intravedere almeno per ipotesi che si tratta di una forza soprannaturale aperta nella dimensione del sacro.
L’uso dell’aggettivo predialettico indurrebbe a credere che l’esperienza cercata debba precedere nel tempo i pensieri usati per realizzarla; ciò sarebbe esatto se la coscienza pensante dell’uomo fosse capace di trovare da sé, gratuitamente pronto, l’attimo sorgivo del pensiero, che è il suo momento predialettico.
La coscienza è costretta invece a partire da dove oggi è ordinariamente arrivata, ossia dal mezzo di un’immersione, se non uno sprofondamento, nella discorsività irrefrenabile, nella verbosità emotiva, nella logorrea maniacale; per cui, se vuol ritrovare – in piena obiettività e consapevolezza – quell’origine dell’attività pensante di cui si dice, deve fare marcia indietro e risalire contro l’usuale corrente che, per abitudine e rilassamento del grado di allerta, l’ha condotta lontano dal suo inizio; al punto che è diventato difficile non solo immaginarlo, ma anche supporlo quale semplice ipotesi.
Sull’esercizio della concentrazione si sono dette molte cose, ma sempre con il rischio d’impantanarsi in un dialetticismo esasperato, che si ritiene autorizzato a parlarsi addosso per 360°, e quindi invalidare il motivo stesso per cui il meditatore si era disposto all’esecuzione.
Certamente non è proibito parlarne, ma il fatto è che l’esercizio deve essere praticato. Tale prassi comporta lo scontro con l’elemento della dialettica; viene chiesto uno sforzo notevole, in quanto diretto a sostenere qualcosa che non esiste e che potrebbe pure darsi non si riesca a far esistere, se non dopo assidue applicazioni; il valore umano profuso è in tutti i casi una “condizione necessaria, non sufficiente”.
 Per quel che riguarda la mia esperienza in merito, la concentrazione è un esercizio semplice da comprendere ma anche molto difficile da attuare. È facile spiegare il procedimento, ma non è possibile raccontare l’esito. È un po’ come trovare l’equilibrio camminando su un filo teso: le cadute sono inevitabili, e sono oggetto di ripetute narrazioni, mentre l’eventuale percorso netto è ineffabile.
Per quel che riguarda la mia esperienza in merito, la concentrazione è un esercizio semplice da comprendere ma anche molto difficile da attuare. È facile spiegare il procedimento, ma non è possibile raccontare l’esito. È un po’ come trovare l’equilibrio camminando su un filo teso: le cadute sono inevitabili, e sono oggetto di ripetute narrazioni, mentre l’eventuale percorso netto è ineffabile.
Ma perseverando, e ponendo attenzione a come le cose funzionano quando ci si dispone a praticare questa via interiore, si comincia a notare che il pensiero è certamente l’elemento principale su cui si lavora, tuttavia da un certo momento in poi, ossia esaurito quel tratto di concentrazione in cui ci si “racconta” l’oggetto preso come iniziale riferimento, spogliandolo di tutte le sue accezioni dialettiche, quel che giunge dopo richiede una saldezza dell’anima, che le derivi da un coordinamento preciso tra volontà e sentimento impiegati nel compito che si svolge.
Si viene a sapere dello stato di buona salute di un corpo fisico, dal suo non farsi sentire in alcun modo. Cosí va intesa la fermezza dell’anima: sostenuto e cessato il momento della parola interiore, coglie l’essenza dell’oggetto su cui si è costruito l’esercizio, e di questa se ne riempie tutta, rimanendo al momento immobile, staccata, sospesa da ogni altra funzione fruitiva.
Solo nella quiete, che non è riposo o rilassamento, ma è il risultato invero particolare della sua adesione all’impegno praticato, e quindi in uno stato di quiete dinamicamente attiva, equilibrando le componenti del volere e del sentire, può venire offerta al pensiero la capacità di autopercepirsi nel pensare e di recuperare in esso la pura identità.
Dopo la concentrazione, meglio parecchio dopo, si può riflettere su quel che si è tentato di fare e sul come si è condotto l’esercizio; niente di piú di un semplice onesto studio su se stessi nell’impegno meditativo. Si potrà notare una regola emergere come primo risultato di esperienza; nulla di nuovo sotto il sole, ma stavolta il sole che illumina le cose ce lo siamo creati noi nella nostra interiorità e con il nostro esercizio.
I pensati sono l’eterno impedimento a che il pensare, ovvero la sua forza allo stato originario, possa darsi a noi in piena coscienza; i pensati bloccano normalmente il percorso di risalita del pensiero alla sua fonte; diventano chiuse, dighe, sbarramenti; diventano nozioni cadaveriche di un sapere morto che dogmaticamente impone la visione di una realtà tanto massiccia quanto inestricabile; per cui è assunto quale unico esistente quel che in realtà ci nasconde l’essere, senza il quale neppure l’esistente avrebbe parvenza.
Credo di non sbagliarmi se tra le mie manchevolezze annovero una scarsa disponibilità alla cosiddetta “devozione”; la ritenevo un’espressione fideistica, mistico-sognante, ma con il tempo ho dovuto ravvedermi, perché il mio preconcetto era sorto senza un briciolo di pensiero che possa dirsi tale (come del resto tutti i preconcetti).
Spesso infatti, quando scrivevo, preferivo il termine “disponibilità interiore “ o “disposizione dell’anima” che mi sembravano centrare meglio il senso del devoto. Invece oggi, e questo grazie al tempo che ho potuto dedicare agli esercizi interiori, in particolare a quello della concentrazione, posso dire che la devozione descritta in precedenza, cioè l’attitudine dell’anima a farsi dapprima quieta, poi unificare le forze del volere e del sentire, ponendole a totale servizio del lavoro che in quel momento si sta eseguendo sul pensiero, è il propellente e il catalizzatore migliore per compiere l’operazione.
Tuttavia, per chi voglia concentrarsi, l’attenzione deve essere rivolta esclusivamente all’oggetto della concentrazione; quel che può avvenire nell’anima non fa parte dell’esercizio. Se la situazione ottimale non si presenta subito, nascerà poi come fatto spontaneo allato al percorso del pensiero. Per cui, quanto fin qui detto vuol essere soltanto una semplice descrizione dell’atto interiore (purtroppo esposta anche per via dialettica, del resto inevitabile) ma sempre al di fuori del compimento dell’atto stesso.
Chi ha già conosciuto i mantra che Massimo Scaligero ha indicato a guida di una corretta impostazione orientata allo Spirito, avrà probabilmente riconosciuto in questo scritto, non espresso in modo palese ma aleggiante tra le righe, uno dei suoi principali, descritto in Tecniche della Concentrazione Interiore (5a Meditazione).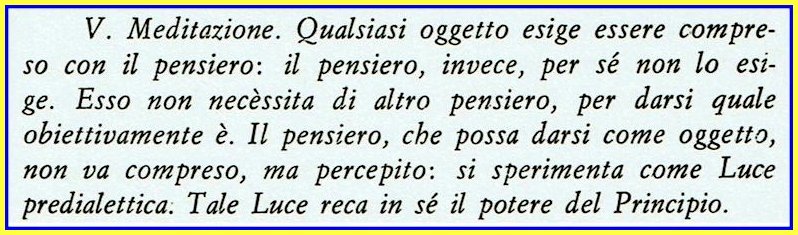
Questo mantra mi ha colpito in modo particolare; presenta una rilevante simmetria con il problema della conoscenza, anzi, con il processo della conoscenza. Tale il motivo di questo scritto: voglio porre in tutta evidenza una correlazione tra due percorsi ben distinti eppure in un certo modo speculari.
Nel conoscere, l’uomo si trova davanti ad un mondo già fatto, per cui egli attiva i suoi pensieri su tutto ciò che attira la sua attenzione e il suo interesse; la facoltà pensante è insita nella sua essenza di uomo ed egli la adopera di continuo.
Giunge persino ad adoperarla anche nei casi in cui la percezione che ha suscitato in lui il pensare non sia strettamente fisica e materiale; ha saputo indagare anche nei settori dell’astrazione e della fantasia. Il filosofeggiare ha abbracciato razionalismi, idealismi e correnti di pensiero, ora creandoli, ora distruggendoli, ma comunque restando sempre in piena attività in mezzo a elementi del tutto immateriali.
La psicologia dal canto suo si è costruita interi mondi dell’interiorità umana sui quali lavorare e ipotizzare senza sosta, e spesso senza risultato, ma come si suol dire, quel che conta è tentare. Del pari la scienza, specialmente quella d’avanguardia, si addentra nell’universo con una certa baldanza e non arretra davanti alla possibilità di teorizzare su dimensioni supposte al di là dello spazio e del tempo, o ascoltando risonanze cosmiche dalle quali dedurre scontri titanici tra galassie avvenuti milioni d’anni fa, e in questi cercare sostenibili tracce sull’origine del nostro universo.
Ma per tutti i casi, anche per quelli non citati, vale la regola che ai fini conoscitivi l’uomo deve sempre attendere l’incontro con una percezione (esteriore o interiore) e da essa avviare la propria attività pensante.
Il percorso si delinea in questo modo: percezione + pensiero = conoscenza dell’oggetto.
Ma un oggetto, cosí conosciuto, rivela forse la sua completa identità? Sicuramente no; ne risulterà una determinata rappresentazione, una sorta di realtà parziale, che potrà bastare per un tempo, neppure troppo lungo, a classificare l’oggetto e renderlo elemento di un sapere valevole per una cultura provvisoria.
Il passo fondamentale alla scoperta in toto dell’oggetto, che è la sua verità, sta nel poter giungere per via conoscitiva all’essenza di questo. Ovvero, giungere al punto in cui, la nostra spinta al “conoscere ancora e oltre” si ferma, non perché cessata o bloccata: si ferma perché sa d’esser giunta al capolinea.
 Quando e in quali condizioni potrebbe avvenire un simile momento nella storia del pensiero umano?
Quando e in quali condizioni potrebbe avvenire un simile momento nella storia del pensiero umano?
Sono convinto che ci sia un’unica possibilità: percepire l’essenza dell’oggetto identica all’essenza dell’attività del pensiero che abbiamo esercitato per incontrare e studiare l’oggetto.
Questo grado di percezione è il solo in cui si dimostra come l’atto conoscitivo sia il contatto stesso con quel pensare che regge la terra, i mondi, l’universo; è l’identica forza che là si è espressa nel tempo come creazione, e qua, sulla terra oggi, nell’uomo, come riconquista di quel potere.
L’antica creazione riprende il suo corso, passando stavolta attraverso l’esercizio della concentrazione, che è un atto conoscitivo, ma è anche un atto di volontà, di devozione, e prima ancora un atto di libertà.
Per cui, in un contesto preciso, nella coscienza si è verificato un salto di qualità capace di riprodurre in sé il momento dell’identità del pensiero umano con la forza- pensiero grazie alla quale l’uomo pensa. Il tutto accolto da una interiorità che ha voluto e saputo predisporsi all’evento.
Ecco quindi la simmetria che il mantra di Massimo Scaligero pone nei confronti della gnoseologia e di tutti quei misteri che le venivano connessi fintanto che la coscienza degli indagatori, per quanto dotta e intuitiva, non disponeva di una contropartita spirituale, libera da dottrine tanto fideistiche quanto dogmatiche.
Il pensiero dal quale è sorto il creato è il medesimo che l’uomo – normalmente inconsapevole – adopera per costruirsi la strada nel mondo. Diviene evidente quando per spinta evolutiva, dalla quale non si escludono volere individuale, predisposizione, destino e formazione, arriva a considerare la possibilità di risalire meditativamente la corrente dei pensieri, per l’esattezza, di un preciso pensiero, scelto e focalizzato su un oggetto qualunque, quello che può apparire il piú semplice, modesto o inutile, come un chiodo o uno spillo, e da questo partire per l’ascesa.
Solo un’anima molto candida, ammesso che ce ne siano in giro, potrebbe pensare di conseguire risultati eclatanti dopo una mezza dozzina di esercizi. Bisogna tener presente che il risultato di cui ci è stato trasmesso l’insegnamento, potrebbe anche non verificarsi.
Ma questo non ha alcuna importanza: amare la concentrazione (si fa per dire, perché è piuttosto difficile innamorarsi di un’applicazione interiore che richiede svolgersi in un’atmosfera asettica, imperturbata, il piú lontana possibile dagli echi dell’anima), persistere nel suo farsi senza mai nulla attendere di particolare, è il modo corretto per affrontarla.
La modestia, la piccolezza del significato dell’oggetto scelto per avviare il processo del pensiero, sarebbe opportuno rappresentasse una pari modestia e acconcia rivalutazione della dimensione egoica di quanti desiderino compiere l’esercizio.
L’ordinario pensiero attivato dalla percezione porta a una ordinaria conoscenza del mondo, la quale, anche se coincidente con tutto l’attuale scibile, resta sempre ordinaria, perché l’atto conoscitivo compiuto, privo di una coscienza correttamente predisposta, è monco: manca della possibilità di intravedere il retroscena di quella che chiamiamo “la nostra realtà” in divenire, sia essa indirizzata a esaminare un filo d’erba sia coinvolta nell’avvenirismo delle onde gravitazionali.

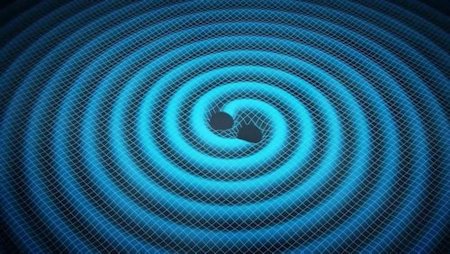
Opposta e simmetrica è la via del pensiero esercitato nella concentrazione. Il dato percettivo preso dal mondo sensibile, per quanto immaginato e portato quindi a percezione interiore, diviene il banco di lavoro. Lo sperimentatore si appresta a togliere una dopo l’altra tutte le vesti mondane, proprietà e modalità d’esistere che gli appartenevano e che lo rendevano per l’appunto quell’oggetto e null’altro.
Quando proseguire nel percorso descrittivo-dialettico ‒ che per ovvie ragioni deve essere sempre svolto in modo conciso e senza uscire dal tema ‒ diventa inutile perché la coscienza si è convinta d’aver detto tutto quello che c’era da dire, e un ulteriore insistere porterebbe solamente alla ripetitività, allora quel che si può sperimentare, senza scomodare effetti sovrannaturali o momenti ieratici (che riguardano l’intima biografia d’ogni singola anima) è che viene a crearsi una precisa sovrapposizione tra l’ente dell’oggetto pensato, messo cosí “a nudo”, e la sostanza pensante cui abbiamo attinto per realizzare l’esperimento.
Due essenze si toccano, coincidono riconoscendosi qualitativamente identiche. La sostanza tratta dal mondo dell’esistere e l’elemento di vita del pensare proveniente dal mondo dell’essere, per il meditante si fondono in una, non perché sia stata la sua piccola opera a congiungerle, ma perché stavano cosí da sempre; soltanto una particolare forma organizzativa del conoscere (quella umana) le aveva dovute apprendere separatamente, acquisendole una dopo l’altra nello spazio e nel tempo di lunghe epoche.
Percezione + pensare (della concentrazione) = conoscenza del mondo; ma non piú secondo realtà multistrati oggi imperanti e domani decadute; ora la conoscenza del mondo è una con la conoscenza-coscienza che avverte la sua capacità di abbracciare il Tutto. È il conoscere del ri-conoscere.
Abbiamo compiuto il percorso che porta alla pienezza dell’umano.
Questo potrebbe venir visto da qualcuno come un salto obbligante la coscienza a spingersi in avanti di millenni, e quindi, sotto un profilo strettamente morale, un’induzione riprovevole perché forzosa, anacronistica e per giunta immodesta.
Ma chi pratica la concentrazione sa che nessun uomo ha mai dovuto rimproverarsi d’aver lavorato per il futuro, nell’intento di renderlo migliore del presente; specialmente se cosí facendo non solo non ha trascurato nulla nella sua esistenza, ma anzi ha preparato per sé e per gli altri qualcosa di buono da proiettare nelle vite future.
Qualsiasi persona, anche avulsa, per destino o per volontà, dall’indagine interiore, comprende con facilità che il concetto di “vita” si lega saldamente a quello di “evoluzione”.
Per gran parte dell’umanità le cose finiscono qui. Il limite della morte fisica non induce a promuovere pensieri importanti verso il futuro.
Ma con l’arrivo del Maestro dei Nuovi Tempi (Massimo Scaligero indica Rudolf Steiner con questo appellativo, e chi ha conosciuto Scaligero sa quanto poco incline egli sia stato alle intitolazioni onorifico-celebrative) il binomio “vita-evoluzione” si è dilatato al punto da aprire un senso nuovo alle concezioni preesistenti, laiche o confessionali che siano.
Ci fa aggiungere ‒ anzi, è giusto dire “ci fanno aggiungere” perché dopo Steiner, l’opera di Scaligero viene a rafforzare vieppiú il valore del percorso autoconoscitivo ‒ a “vita-evoluzione” un’altra parola: “conoscenza”.
Da qui adesso, qualche timido passo possiamo farlo anche da soli: cos’è la conoscenza se non l’attività pensante che esercitiamo senza sosta in tutte le direzioni?
Pure il passaggio successivo diventa semplice: se la vita evolve, ed io, conoscendo, mi evolvo con essa, allora non ho alcun dubbio: è estremamente importante esaminare com’è fatto questo meraviglioso strumento che si chiama pensiero, che usiamo ininterrottamente senza aver mai compreso in modo completo cosa sia e donde venga.
Qui possiamo notare la macroscopica differenza che “vita + evoluzione” hanno se ad esse si aggiunge, o meno, la parola “conoscenza”.
Con questa entriamo nel campo del pensare, e dal pensare, preso come oggetto di nuovo studio, si può accedere al metafisico, al sacro, al divino: ai mondi dello Spirito.
Il cammino della concentrazione conduce alla possibilità di questo accesso; è il momento della svolta, o della Luce predialettica del pensiero.
In essa vive il Potere del Principio.
Ogni minuto offerto alla concentrazione è un contributo a che tale Luce si manifesti nella coscienza dei discepoli e di quanti vogliano diventarlo.
Angelo Lombroni
