 Chi per un motivo o per un altro capitasse a Belfast, Irlanda del Nord, e volesse visitare la città che, nonostante Shankhill Road e le zone calde dell’irredentismo IRA, offre piacevoli scorci di vita sociale e culturale, verrebbe senza meno condotto alla zona portuale. Qui, nell’area dove un tempo sorgevano i cantieri navali Harland e Wolff, visiterebbe il Museo dedicato al Titanic e alla sua piú che drammatica epopea. Nella prima decade del Novecento, una forza lavoro di 15.000 uomini lo costruí insieme alla nave gemella RMS Olympic. La sigla sta per Royal Mail Ship. Entrambi i bastimenti, i piú grandi dell’epoca, avrebbero qualificato Belfast tra le eccellenze della cantieristica navale nel mondo.
Chi per un motivo o per un altro capitasse a Belfast, Irlanda del Nord, e volesse visitare la città che, nonostante Shankhill Road e le zone calde dell’irredentismo IRA, offre piacevoli scorci di vita sociale e culturale, verrebbe senza meno condotto alla zona portuale. Qui, nell’area dove un tempo sorgevano i cantieri navali Harland e Wolff, visiterebbe il Museo dedicato al Titanic e alla sua piú che drammatica epopea. Nella prima decade del Novecento, una forza lavoro di 15.000 uomini lo costruí insieme alla nave gemella RMS Olympic. La sigla sta per Royal Mail Ship. Entrambi i bastimenti, i piú grandi dell’epoca, avrebbero qualificato Belfast tra le eccellenze della cantieristica navale nel mondo.
Il Museo, “un edificio maestoso e sensazionale, la maggiore esposizione al mondo sul Titanic” vantano guide e dépliant, riproduce negli spazi e nell’allestimento l’interno della “ill fated ship” la nave sfortunata, come venne definito dagli Inglesi il Titanic dopo il naufragio.  Ma tra la ricercatezza museale, che tenta di ridare al visitatore il feeling realistico che dovette ispirare chi lo vide, splendido e ricercato, prima che scivolasse alla sua tomba nei vortici gelati dell’oceano Atlantico, nulla e nessuno gli rivelerà il particolare che il varo del Titanic, avvenuto il 31 maggio 1911, non ebbe alcuna benedizione religiosa, come di solito veniva fatto per le altre navi.
Ma tra la ricercatezza museale, che tenta di ridare al visitatore il feeling realistico che dovette ispirare chi lo vide, splendido e ricercato, prima che scivolasse alla sua tomba nei vortici gelati dell’oceano Atlantico, nulla e nessuno gli rivelerà il particolare che il varo del Titanic, avvenuto il 31 maggio 1911, non ebbe alcuna benedizione religiosa, come di solito veniva fatto per le altre navi.
E non solo. Pare che, a voler dare credito a news che circolano in rete, la nave gemella Olympic, molto simile al Titanic nella struttura nautica, sia poi servita per imbastire una diabolica macchinazione, attraverso uno scambio avvenuto dei due bastimenti, per cui l’Olympic, meno dotata della consorella nella raffinatezza e cura dell’arredamento interno, che aveva già viaggiato e subíto un danno che avrebbe dato diritto a un modesto risarcimento, ne avrebbe preso il nome e la principesca copertura assicurativa. Il viaggio inaugurale sarebbe stato anche l’ultimo. L’Olympic-Titanic, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, alle 23.40, secondo la tesi ufficiale impattò con un iceberg vagante, mentre, secondo una teoria complottistica, fu invece speronato da un cargo svedese, come anni piú tardi accadde all’Andrea Doria. Un’altra congettura lo vuole squarciato da tre cariche esplosive. Come che sia la verità, di certo morirono nel procurato naufragio quasi tutti i nemici di J.P. Morgan – lo spregiudicato banchiere proprietario del Titanic – colpevoli di opporsi al suo progetto di fondare la Federal Reserve, l’organismo pubblico di gestione delle riserve monetarie e finanziarie degli Stati Uniti, e quindi del mondo, essendo già allora il dollaro l’unità dinamica in divenire dell’economia globale.
In breve, i soldi che fanno i soldi, nel caso dello pseudo-Titanic, una resa dei conti tra predatori alfa. Negli anni, identificato il relitto a 3.000 metri di profondità, riprese e foto ne hanno mostrato la scarnificata struttura, orbite vuote di spazi senza luce, ossatura larvale di umana follia volta all’inganno.
E la Divinità? Il fatto che non sia stata chiamata in causa al compimento dell’opera di calafataggio non ha influito sul destino finale delle due navi implicate nell’intrigo. In Divino non s’impone, e meno che mai punisce. Se ricusato, si ritrae. Ha troppo amore e rispetto per la vita umana. Non è sua la vendetta. E neppure la disposizione a indurre in tentazione l’uomo, con l’inventarsi cioè panie e trabocchetti per farlo scivolare nel peccato, rendendosi in tal modo complice del vero e solo Tentatore, che è Satana. Ci ha tenuto a precisarlo papa Bergoglio, sull’onda critica dei teologi francesi che avevano già da tempo fatto notare l’incongruenza del Padre nostro, la preghiera cardine data dal Cristo, nella frase che recita: “…e non ci indurre in tentazione”. La traduzione dal greco antico dei Vangeli di Matteo e Luca aveva creato la resa arbitraria del testo. Nella realtà, è l’uomo, creatura assolutamente libera in pensiero e azione, a dannarsi o angelicarsi, seguendo o meno i subdoli espedienti che il Maligno è bravissimo a suggerire. È l’uomo che pratica il vetero-testamentario “occhio per occhio dente per dente” e tesse intrighi spesso mortali.

L’Olympie e il Titanic durante la loro costruzione
L’Olympic-Titanic s’inabissò alle 2.20 del 15 aprile 1912, trascinando con sé 1.518 passeggeri e membri dell’equipaggio. I superstiti furono 705. Il Titanic-Olympic navigò, sicuro, per altri 25 anni.
E non affondò, rispettando in tal modo l’etichetta di nave inaffondabile che gli era stata data dai suoi progettisti e armatori. Venne demolito come Olympic nel 1930. La sua storia è quella dell’orgoglio umano che sfida la natura e gli dèi.
Il nome echeggia infatti il mito dei Titani, i dodici giganti che osarono sfidare Zeus che alla fine li fulminò. Dare un simile nome a una nave è già di per sé un atto di sfida ai Numi. Chi porta un tale appellativo è destinato a giganteggiare, a imporsi con la sua mole e la sua forza dirompente e soverchiante. Una nave di 300 metri di lunghezza, larga 30, alta 60, irrompe con prepotenza nella dimensione fisica del mondo e ne condiziona il rapporto con l’uomo. Il quale non può far altro che ricavare, da simili scambi, moniti e simboli, cogliendone soprattutto i segnali trascendenti e le allegorie piú eloquenti o enigmatiche. Segnali da interpretare quali allusioni alla fragilità della condotta umana, succube delle forze ostacolatrici in qualsiasi occasione l’uomo si affranchi dall’elemento spirituale, anzi, lo provochi con il gesto irriverente di Nemrod che scaglia verso il cielo e gli dèi, dalla  Torre di Babele, la freccia della sua vanagloria.
Torre di Babele, la freccia della sua vanagloria.
Aggiornato ai tempi e ai costumi, il gesto del superbo re di Babilonia diventa un inchino alle forze materiche del mondo, l’acquiescenza per sollecitarne favori. Avviene allora la confusione delle lingue e il crollo del manufatto, rovina di chi vi aveva cercato successo e gratificazione. A Babele gli uomini decisero, per loro libera scelta, di aprirsi al male. San Paolo ne parla nella sua lettera ai Romani: «Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri dei loro cuori, sí da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore». Menzogna che, nel caso del Titanic, sarebbe stata il millantare l’inaffondabilità strutturale di un bastimento, e intanto lo si esponeva, con maneggi e intrighi di vasta portata, alla catastrofe voluta, e menzogna sarebbe altresí stata la scelta di qualificare un’altra nave, la Concordia, come nave portatrice di cordialità, pur battente bandiera di un Paese che, già secoli orsono, il sommo Poeta riteneva «nave senza nocchiero in gran tempesta».
Ma la nave ammiraglia della Compagnia di navigazione Costa un nocchiero l’aveva, e di grande esperienza, e il mare Tirreno lambiva con onde gentili i frastagli costieri e la secca delle Scole, poco fuori il porto dell’isola del Giglio. Alle 21.45 del 13 gennaio 2012 la grande nave da crociera, con 4.229 passeggeri, di cui 1.013 membri dell’equipaggio, urtava uno scoglio sommerso delle Scole. L’impatto aprí uno squarcio di 70 metri nell’opera viva del piroscafo, l’acqua lo invase causando il naufragio con la morte di 32 persone e la successiva condanna del nocchiero a 16 anni di reclusione. Un uomo solo ha pagato per un atto di follia collettiva terminata in tragedia. Follia di troppi eccessi. Sarebbe un esercizio corrivo stabilire nessi karmici e fatali coincidenze con il naufragio del Titanic, tra cui quella della coincidenza degli anni, 1912-2012. Ma si può rilevare, come per il Titanic, l’occorrenza di archetipi subnaturali. Il primo è nella smania titanica, voler essere cioè eccessivi in pensieri, parole e opere, cosí da moltiplicare le difficoltà del vivere umano, senza risolverne alcuna. Navigli da crociera, ciclopici per stazza e dimensione, sfidando ogni cautela nautica, sfiorano scogliere e banchine, impegnano a tappo i canali della Serenissima, minacciando oltraggiosi i delicati merletti marmorei delle Ca’ nobili e dei ponti non piú dei Sospiri ma dei brividi, per l’eventualità che un timoniere apolide, equivocando i termini semantici e la segnaletica, incocci la passerella di Calatrava, danneggiando irreparabilmente la nave ma liberando finalmente Venezia di una ingombrante quanto futile struttura costata quanto il recupero del Concordia. Certi saluti e inchini, con o senza fischi, costano. Il richiamo filo-semantico alla compagnia coinvolta nel disastro del Giglio è assolutamente casuale. Resta comunque il fatto che è in atto da anni un perverso rituale, un’ordalia tra le varie compagnie da crociera per stabilire tra esse un primato di eccellenza, che si traduce alla fine in piú passeggeri. Che oltre alla ‘mano de Dios’ nei disastri, negli incidenti e disguidi piccoli e grandi ci sia anche quella dell’uomo è un sospetto difficile da reprimere. E che a guidare la mano dell’uomo, in questo particolare contesto ed in altri di varia natura ci siano le mani degli Ostacolatori, è altrettanto plausibile. La seduzione di essere scarrozzati per i Sette Mari da una specie di Orto delle Esperidi è forte assai. Se poi, come nel caso della Concordia e di altri simili vascelli, l’Orto delle ninfe, figlie di Atlante, diventa il Giardino di Klingsor, in cui irrompe, non prevista, una voluttuosa Kundri di origine transilvana, assoldata da forze avverse ma ignote, allora il nocchiero, non avendo le salde virtú di Parsifal, perde la bussola e la nave sbanda, deriva, impatta con l’iceberg, lo scoglio sommerso, e infine naufraga.
 E allora è tutto uno stornare le cause del disastro dalle inadempienze umane per puntarle sulle dette coincidenze scaramantiche, notando ad esempio che la partenza della Concordia da Civitavecchia sia avvenuta di Venerdí 13, preventivata per le 17.00, poi spostata alle 18.50, per ragioni logistiche. E sono emersi, nel gioco mediatico dello scoupismo, particolari a sensazione, come quello che al varo della Concordia, avvenuto il 2 settembre 2005, la bottiglia di champagne che la madrina, Eva Herzigova (il nome della prima donna, quella della mela) lanciò contro la chiglia del bastimento in segno benaugurale, non si frantumò, presagio, questo, di guai (video). Scaramanzia, superstizione, dicerie marinaresche. Aggravate dalla presenza alla sfortunata cerimonia di un cardinale chiacchierato per gli eccessi sibaritici della sua residenza privata e dall’esperta di culinaria che unge di butirrose ricette gli schermi televisivi nelle ore di massimo ascolto. Queste coincidenze il nocchiero forse le notò, essendo discendente da un popolo che, pur sapendo in via razionale che un segno premonitore, certe concomitanze, cifre e date non meritino fiducia, pure è portato a crederci, obbedendo all’interiore noto quesito: e se fossero vere? Il rifiuto della bottiglia di frantumarsi sembra provarlo. Ma vanità, ambizione, avidità e lussuria tarpano la coscienza, rendendo le virtú solo pedanti optional.
E allora è tutto uno stornare le cause del disastro dalle inadempienze umane per puntarle sulle dette coincidenze scaramantiche, notando ad esempio che la partenza della Concordia da Civitavecchia sia avvenuta di Venerdí 13, preventivata per le 17.00, poi spostata alle 18.50, per ragioni logistiche. E sono emersi, nel gioco mediatico dello scoupismo, particolari a sensazione, come quello che al varo della Concordia, avvenuto il 2 settembre 2005, la bottiglia di champagne che la madrina, Eva Herzigova (il nome della prima donna, quella della mela) lanciò contro la chiglia del bastimento in segno benaugurale, non si frantumò, presagio, questo, di guai (video). Scaramanzia, superstizione, dicerie marinaresche. Aggravate dalla presenza alla sfortunata cerimonia di un cardinale chiacchierato per gli eccessi sibaritici della sua residenza privata e dall’esperta di culinaria che unge di butirrose ricette gli schermi televisivi nelle ore di massimo ascolto. Queste coincidenze il nocchiero forse le notò, essendo discendente da un popolo che, pur sapendo in via razionale che un segno premonitore, certe concomitanze, cifre e date non meritino fiducia, pure è portato a crederci, obbedendo all’interiore noto quesito: e se fossero vere? Il rifiuto della bottiglia di frantumarsi sembra provarlo. Ma vanità, ambizione, avidità e lussuria tarpano la coscienza, rendendo le virtú solo pedanti optional.
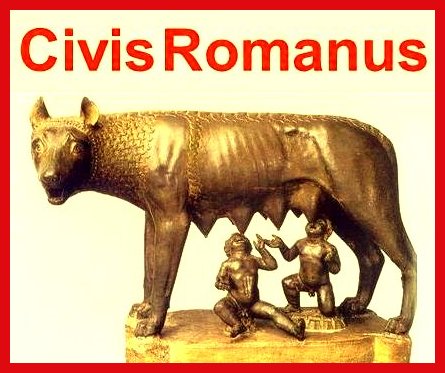 I milioni di visitatori che sciamano da ogni angolo della Terra a Roma per ammirarne la superba e al tempo stesso tremenda grandezza, avvertono che gloria e potenza non sono state frutto del caso e del favor dei ma poggiano senza dubbio sulla pratica delle virtú, nel privato della domus, come negli scranni del senato, tra le file delle legioni, persino tra i bottegai e i lavoranti della gleba: virtus, pietas, fides e humanitas sono state fino al crollo dell’Impero, ossia per mille anni, l’asse portante del codice morale del civis romanus e di quanti, immigrati, ne condivisero credo e osservanza.
I milioni di visitatori che sciamano da ogni angolo della Terra a Roma per ammirarne la superba e al tempo stesso tremenda grandezza, avvertono che gloria e potenza non sono state frutto del caso e del favor dei ma poggiano senza dubbio sulla pratica delle virtú, nel privato della domus, come negli scranni del senato, tra le file delle legioni, persino tra i bottegai e i lavoranti della gleba: virtus, pietas, fides e humanitas sono state fino al crollo dell’Impero, ossia per mille anni, l’asse portante del codice morale del civis romanus e di quanti, immigrati, ne condivisero credo e osservanza.
Un codice morale che, supportato da decaloghi e dottrine, costituiva, scrive Scaligero sul «Resto del Carlino» l’8 marzo 1940: «L’essenza delle antiche religioni greca e romana, il cui carattere pragmatico è la rispondenza perfetta del mondo sacrale a quello della politica e della civiltà – rapporto vivo e realistico, unione talmente creativa che difficilmente può essere intesa dai moderni nel suo completo valore – consiste non già nella divinizzazione superstiziosa degli elementi della natura, ma nell’assunzione di tali elementi come simboliche e manifeste espressioni della forza divina. …Da qui scaturisce il senso “olimpico” e classico della vita e del sacro, che non è – si badi – una reazione al senso ctonico e tellurico, ma un completamento di questo; anzi esso stesso lo comprende e lo dinamizza nella sua totalità. …Tale possibilità caratterizza appunto l’esperienza religiosa del greco e del romano: la loro forza interiore si fonda sulla certezza di quel che nella visione religiosa è rappresentato come realtà del mondo. Il senso della realtà, sensibilizzato nelle antiche forme degli dèi, costituisce ciò che poi sarà la fede nel senso cristiano».
Il pensiero spiritualista si collega poi allo storico. Nella sua Civiltà di Roma Pierre Grimal scrive: «Ma Roma non si difende dalla morte con la bellezza, come i Greci, che speravano di eternarsi con la bellezza. Il romano si difende dalla morte con la virtú in vita e dopo con la gloria e la buona reputazione. Questa struttura della morale romana resterà tale nel tempo. Finirà con l’assimilare persino le dottrine dei filosofi, rinnovandole, adattandole al bene della patria. Base della morale è la conformità con la natura, tanto quella dell’uomo quanto ordine del mondo materiale e divino, in una perfetta organizzazione sociale».
Una simile struttura morale e ideale non ebbe difficoltà ad assimilarsi alle dottrine stoiche, mentre diffidava di quelle epicuree, proprie perché in qualche modo queste attentavano alla tenuta sociale e morale dei Romani. Il Cristianesimo fu una naturale estensione dei principi stoici temperati dalla consapevolezza dell’esito divino della creatura umana che alla fine avrebbe realizzato il ritorno dell’anima individuale nel grembo universale, cosmico, dell’Anima del mondo. La virtus, dunque, è quanto il popolo romano riteneva giusto praticare per essere un buon civis e un vir, cioè un uomo, nell’accezione estesa a ogni àmbito della vita privata e pubblica. Questo modo di essere, aggiunge Grimal, formò: «Un’aristocrazia spirituale dell’umanesimo romano fatta di uomini praticanti le grandi virtú del passato. La funzione degli dèi, in questa concezione ideale, è quella che i filosofi assegnano loro: il dettaglio delle pratiche religiose deve essere rispettato nella misura in cui fa parte dell’ordine civico e contribuisce alla coesione sociale. …Le pratiche religiose rispondono a una esigenza divina, come la preghiera col cuore puro, il sacrificio che è l’offerta volontaria, l’omaggio liberamente reso dalla creatura al Creatore. Tale razionalismo morale non escludeva qualsiasi credenza nel soprannaturale».
Molti personaggi della storia romana colmano per intero il calco etico-religioso di cui tratta Grimal. Tra quelli che riguardano il tema in oggetto spicca l’imperatore Marco Aurelio, grande stoico.
 Chi affronta l’estenuante percorso per ammirare la Roma classica partendo da piazza Venezia, se lo trova ritto in arcioni proprio al centro della spianata capitolina. Si tratta della copia della statua equestre originale posta oggi nel Palazzo dei Conservatori, che affaccia sulla stessa piazza. Una curiosa leggenda popolare vuole che quando gli tornerà integra la doratura abrasa dagli anni e sparirà il ciuffo di crine, la cosiddetta “civetta”, sulla testa del cavallo, la fine di Roma, e quindi del mondo, sarà vicina. E almeno questa non sarà colpa della reggenza municipale in carica al momento del disastro.
Chi affronta l’estenuante percorso per ammirare la Roma classica partendo da piazza Venezia, se lo trova ritto in arcioni proprio al centro della spianata capitolina. Si tratta della copia della statua equestre originale posta oggi nel Palazzo dei Conservatori, che affaccia sulla stessa piazza. Una curiosa leggenda popolare vuole che quando gli tornerà integra la doratura abrasa dagli anni e sparirà il ciuffo di crine, la cosiddetta “civetta”, sulla testa del cavallo, la fine di Roma, e quindi del mondo, sarà vicina. E almeno questa non sarà colpa della reggenza municipale in carica al momento del disastro.
Succeduto a quel modello di virtú al cubo che era stato Antonino, giudicato dai sudditi e dalla storia un padre, piú che un reggente dell’Impero piú vasto del mondo di allora e, per i valori, di sempre, Marco Aurelio, vegetariano, animalista, dormiva sul nudo pavimento, praticava l’astinenza, e le sue “Meditazioni”, a detta di Montanelli, pur non rappresentando un gran documento letterario, «contengono il piú alto codice morale che ci abbia lasciato il mondo classico».
Durante l’epidemia di peste che le legioni portarono a Roma dal Medio Oriente, Marco Aurelio fu volontario tra le squadre sanitarie che assistevano i malati e seppellivano i morti. A Roma perirono oltre duecentomila persone. L’Urbe si ridusse a mesto villaggio. Successe al trono Commodo, figlio gemello dell’imperatore. Del padre non aveva alcuna virtú. Si vociferava infatti che fosse il frutto di una relazione extraconiugale di Faustina con un gladiatore. E tale fu Commodo nella sua breve permanenza sul trono: affrontava e uccideva tigri e leoni nel circo.
Inutilmente Seneca tuonava contro i crudeli spettacoli circensi, perché svilivano il divino nell’uomo. Vane rimostranze etico-estetiche di un filosofo che vedeva con ansia la deriva morale del popolo romano e l’esaurisi della sua civiltà, come previsto dall’apostolo Paolo nella sua Lettera ai Romani: «Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. 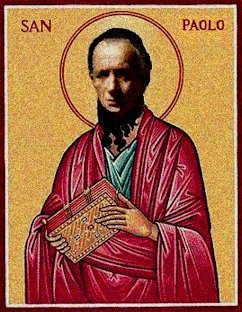 Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo cosí in se stessi la punizione che s’addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balía di una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa».
Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo cosí in se stessi la punizione che s’addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balía di una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa».
Paolo scrisse questa specie di anamnesi morale dei Romani quando sul trono sedeva Nerone, un’anima travagliata dai vizi e dalle debolezze che, in punto di morte, l’imperatore addebitava al suo cattivo genio. Nella realtà, tra guerre civili, incesti, sacrilegi, aborti, ripudi e congiure, era Roma nella sua totalità ad aver aperto la propria ‘alma’ ai cattivi geni, ai numina avversi, alle potenze infere. Paolo era a Roma quando il fuoco la divorò quasi per intero, nel luglio del 64 d.C. L’apostolo delle Genti venne decapitato sulla Laurentina nel giugno dell’anno successivo.

Ricostruzione del Tempio della Concordia
L’incendio divorò tutta la parte antica della città, compreso il Tempio dedicato non a una deità ma alla personificazione di una virtú: la Concordia. Il tempio era stato voluto da Furio Camillo, dopo la sua vittoria sui veienti, nel 396 a.C. Venne inaugurato da suo figlio Lucio nel 367 a.C. Vi era custodito l’archivio di Stato e divideva lo spazio nel Foro, ai piedi del Campidoglio, col tempio di Saturno, custode della ricchezza e quindi del tesoro erariale. Da gente accorta, i Romani facevano coabitare in stretta contiguità i segreti piú delicati della vita pubblica con il denaro e gli oggetti di valore in grado di fare cassa: statue, suppellettili preziose, gioielli, gemme e quant’altro potesse servire nelle emergenze.
Imbastire nessi e coincidenze della Concordia romana distrutta da un incendio, e quindi dal fuoco, con il naufragio di quella italiana distrutta per acqua, è uno sterile esercizio millenarista. Complottista, rincarerebbe uno dei compilatori dei nuovi dizionari aggiornati.
Possiamo tuttavia comporre, è un diritto scaramantico, un parallelo con la nostra derivante società discorde su tutto, dai vaccini alle regole del calcio, e trarne una previsione, un monito. La nave Italia non è a motore e neppure a vela: è una trireme da guerra, anzi una nave oneraria. Tante file di remi, una paranza di bonavolontà che scontano i loro errori e fallimenti, e nutrono speranze, spostando il bastimento in un mare percorso da correnti e soverchiato da tornado e trombe d’aria. C’è un nocchiero alla barra e un pausarius, che batte la cadenza di voga usando un martello, il portisculus, e modulando un canto in esametri, il celèuma, perché la nave proceda in sincronia e sicurezza.
Arriveremo a destinazione felici e in salute, se il nocchiero è capace, se l’equipaggio lo rispetta e i passeggeri lo amano.
Ovidio Tufelli

